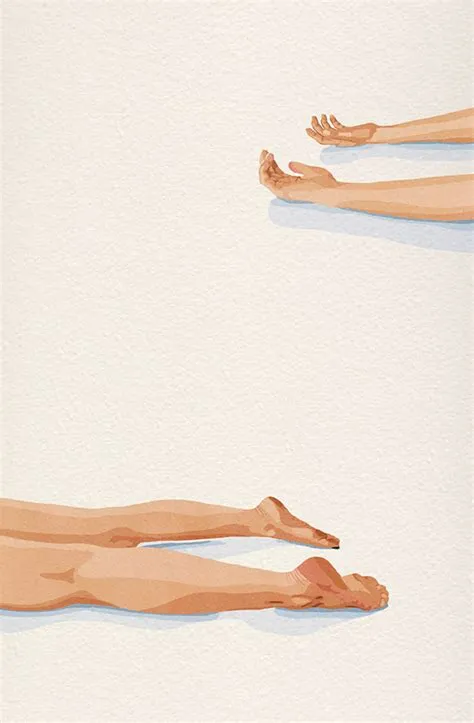Speciale
Adolescenti violenti
I giovani fanno paura, perché non stanno là dove dovrebbero stare. Non stanno ordinatamente nelle categorie che ci siamo costruiti per dar senso al mondo, eccedono le nostre capacità di comprensione, sono un elemento di disordine che va tenuto a bada, sotto controllo. È una storia antica, questa, i vecchi hanno sempre lamentato il malcostume e il degrado delle giovani generazioni, facendo coincidere la fine del proprio mondo con la fine del mondo. I giovani si giudicano per difendere la saldezza di un mondo che si dissolve. Ma nell'ipermodernità, nel tempo dell'accelerazione, come dice Hartmut Rosa, l'inafferrabilità dei giovani è per le generazioni precedenti qualcosa di iperbolico. I giovani sono alieni, non compresi ma giudicati, e gli alieni possono facilmente diventare mostri. Lo sono perfino a scuola, dove la questione decisiva dovrebbe essere la relazione educativa (relazione è ciò in cui sono implicati due soggetti, e non dove esiste un soggetto attivo e un oggetto passivo) e invece il giovane diventa qualcuno che recalcitra, ribelle a ogni forma di buon senso: e perciò diventa normale chiamare i carabinieri a scuola per una pagina satirica, e perciò si invocano punizioni esemplari per chi mette in atto una sua propria forma di protesta contro un mondo che non accetta, come è stato nel caso dei ragazzi e delle ragazze che non hanno voluto sostenere l’orale agli esami di maturità.
I mostri sono l’elemento principale nel caso della narrazione mediatica che da anni dipinge le strade della città come luoghi oscuri dove imperversano bande di giovani che vengono definite “baby-gang”. Un'espressione anfibia, teratologica nel senso più profondo, dove colui che è baby, invece di essere l'innocente, che non opera il male, diventa l'atomo di una legione demoniaca, una turba indistinta che perverte l'ordine del tempo, e della gerarchia su di esso fondata.
Ma ha senso parlare di “baby-gang”? Lo psicologo e psicoterapeuta dell'Istituto Minotauro Alfio Maggiolini, nel libro da lui curato Non solo baby gang. I comportamenti violenti di gruppo in adolescenza, ci dice che no, non ha senso: “baby-gang” è termine che non ci aiuta a capire i fenomeni che accadono, perché, oltre a cancellare le differenza tra tipologie di gruppi molto diverse tra loro, evoca un immaginario che manipola la realtà: non sono babies, né preadolescenti (ciò che suggerisce una progressiva anticipazione di atti violenti, dove invece non è così), ma si tratta di adolescenti e giovani adulti; e non sono gangs, ovvero gruppi organizzati gerarchicamente e orientati al controllo del territorio, trattandosi solitamente di gruppi non strutturati. Dovremmo invece parlare, suggerisce Maggiolini, di “gruppi violenti di adolescenti”, per quanto l'autore sia consapevole che i media cercano sempre frasi ad effetto, e “baby-gang” ha certamente un più forte impatto clickbait.
Difficile capire un fenomeno, quando già il nome, che dovrebbe essere la porta d'ingresso per la sua comprensione, distorce la sua realtà. Ancora più difficile capirlo quando partiamo dalla percezione che i reati violenti degli adolescenti siano in forte crescita, quando invece – come viene approfondito in un saggio del libro – assistiamo da molti anni a una generale diminuzione dei reati minorili, con l'eccezione delle risse, unico reato aumentato anche nell'anno del Covid.
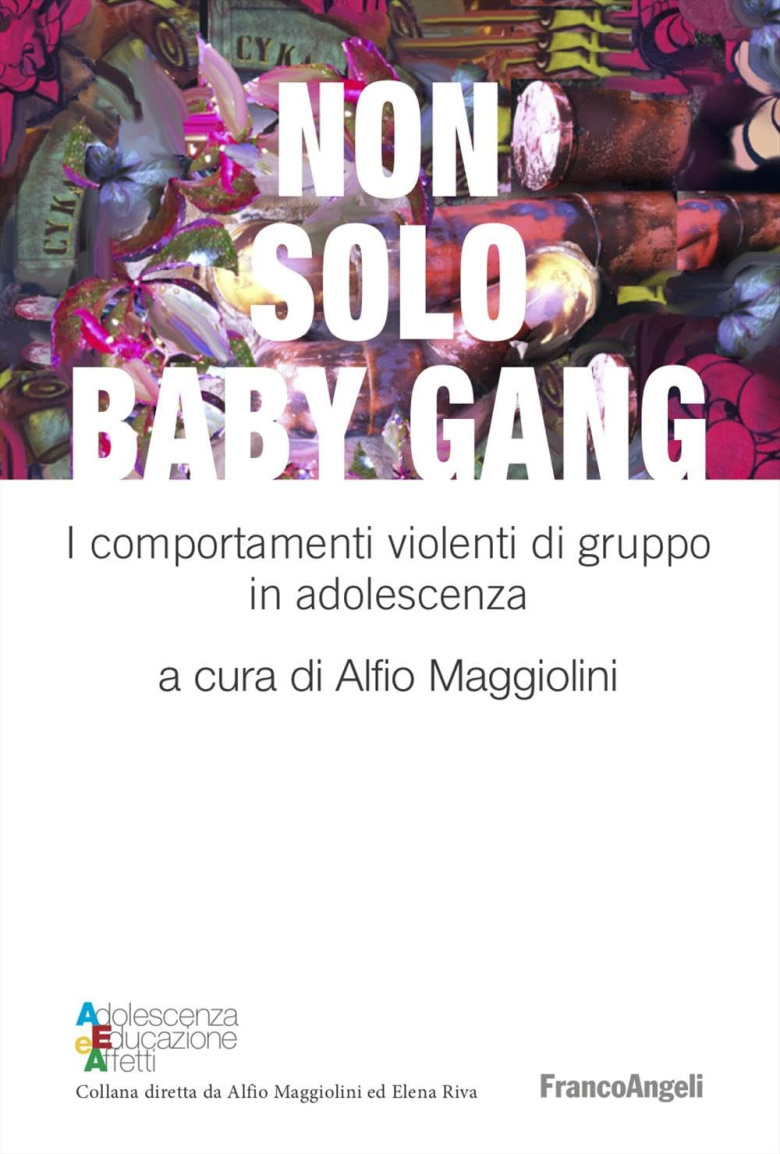
Capire questo fenomeno significherebbe interrogarsi – questa la prospettiva degli autori del libro – sulla relazione tra quei comportamenti violenti e i compiti di sviluppo degli adolescenti. Maggiolini – che da sempre si occupa di adolescenza, collabora con i servizi della giustizia minorile della Lombardia e per molti anni ha coordinato, nell'Istituto Minotauro, l'equipe di ricerca e intervento sui comportamenti trasgressivi e antisociali – mette al centro della sua analisi la necessità evolutiva per un adolescente di un senso di identità e di appartenenza. Focalizzarsi su questo non vale, evidentemente, solo per quegli adolescenti che mettono in atto comportamenti violenti, ma per gli adolescenti tutti; e chi oggi parla di loro, e ancor più chi ci si relaziona come educatore e insegnante, non può prescindere dal comprendere la qualità specifica della soggettivazione dell'adolescente nella presente ipermodernità. Lo psicoanalista Raymond Cahn definiva soggettivazione il processo di assunzione della soggettività che trova il proprio periodo privilegiato nell'adolescenza, in cui decisivo è “il rapporto tra il riproporsi dell’identico e l’emergere del nuovo”, e l'adolescente è chiamato a dar senso, organizzandoli, a tutti i cambiamenti che definiscono e ridefiniscono la sua identità. La soggettivazione, scriveva Cahn, è “un processo di differenziazione che, in virtù dell’esigenza interna di un proprio pensiero, consente l’appropriazione di un corpo sessuato e, nel migliore dei casi, l’uso delle capacità creative del soggetto in un movimento di disimpegno, di disalienazione del potere e del piacere dell’altro, cioè un movimento di trasformazione del Super-Io e di costituzione dell’Ideale dell’Io”. Il processo di soggettivazione consiste anzitutto in un movimento di differenziazione, dove si tengono insieme separazione (il sottrarsi al “potere” e al “piacere dell'altro”, disidentificandosi dai modelli genitoriali) e individuazione (chi sono io?” è la domanda: ci si riconosce come soggetto portatore di specifici desideri, e così facendo si può individuare il proprio Sé).
Ecco, questo processo, oggi, avviene in un contesto assai diverso dal passato, il contesto di una società prestazionale, (iper)narcisistica, in cui generalizzata non è più la colpa ma la vergogna, in cui lo sguardo dell'altro – che sia lo sguardo giudicante dei pari o le attese soverchianti dei genitori o dell'immaginario sociale – tiene sotto scacco l'adolescente, ipersensibile alla connessione con gli altri, sia nel male (sentire le ferite prodotte dal giudizio) sia nel bene (amicizia come protezione identitaria e come condivisione di ideali). La socialità adolescenziale è oggi più che mai caratterizzata dalla dimensione dell'orizzontalità, ovvero della relazionalità con i propri coetanei, con i pari, una questione talmente decisiva che lo psicologo e psicoterapeuta Fabio Vanni parla di una “repubblica degli adolescenti” (Forme della presenza sociale giovanile. Dialogo fra uno psicologo, un sociologo e un architetto, Mimesis, Milano, 2024, con Alessandro Bosi e Dario Costi): un mondo parallelo rispetto a quello in cui si gioca la relazione con gli adulti.
È in questo contesto che occorre comprendere quei gruppi chiamati impropriamente “baby-gang” su cui si concentra la riflessione del libro curato da Maggiolini. Nella “repubblica degli adolescenti”, i modelli di identificazione ricercati saranno sempre meno cercati e trovati nel mondo degli adulti e sempre più nel gruppo dei pari – sia quelli in carne e ossa, sia quelli del mondo social. “Oggi”, scrive Maggiolini, “sono gli stessi adolescenti a gestire i riti iniziatici, proponendo esperienze di coraggio, stati alterati di coscienza e stili d’abbigliamento che definiscono la loro nuova identità”. Il meccanismo si propaga come un vero e proprio contagio: l’adolescente è spinto a uniformarsi agli altri membri del gruppo. Maggiolini rileva la paradossalità di questo processo, che riporta al contesto della società individualistica e prestazionale, poiché uniformarsi agli altri, omologarsi, è il modo specifico per individuarsi: se tutto, nella società degli individui, impone di “essere se stessi” (dove essere se stessi significa produrre se stessi, performarsi), gli adolescenti “sono obbligati a essere se stessi e a realizzarsi, facendo quello che ci si aspetta che facciano tutti, in modo individuale”. L'adolescenza, oggi, si gioca anzitutto in questo paradosso, in questo instabile scarto tra identità e differenza: “l’ascolto della musica, per esempio, aiuta a dare un ritmo alle sue emozioni e a mettere in parole gli stati d’animo; un taglio di capelli, un certo stile d’abbigliamento, un tatuaggio servono a esprimere una personalità che è allo stato nascente, un modo di differenziarsi nello stesso momento in cui si assomiglia a qualcuno. La ricerca di personalità e originalità, cioè di differenziazione, si traduce nello stesso tempo in una domanda di riconoscimento tra uguali, un bisogno di appartenenza, che funziona grazie al contagio di gruppo”. L'effetto di contagio è particolarmente evidente per i comportamenti violenti: “un comportamento antisociale è contagioso per definizione”. È una questione di evitamento della responsabilità personale (è colpa di tutti dunque non è colpa di nessuno) e del senso di potenza che un gruppo trasmette, là dove fa valore assoluto il coraggio, che conduce a mettere in atto comportamenti rischiosi.
Il saggio di Maggiolini, e gli altri contenuti nel libro, identificano una serie di elementi ricorrenti in queste dimensioni gruppali. Anzitutto la presenza di una leadership. Il leader svolge una “funzione iniziatica”, esplora nuovi territori, nuove esperienze, mostrando un coraggio particolare, che è il segno della sua leadership.
Altro elemento fondamentale è la necessità di un collante, un vettore del riconoscimento reciproco, che accomuna i membri del gruppo. Nei gruppi trasgressivi, oggi, la subcultura egemone è quella trap, con i suoi temi “classici”, principalmente il radicamento nel quartiere e nella “vita di strada” e il valore attribuito agli oggetti di lusso come segno del successo. A questo proposito, pare importante riportare quanto scrivono Maria Martino e Lorenzo Giusti: “A una prima osservazione le canzoni, i testi e i video sembrano proprio confermare non solo il dilagare della violenza nelle nuove generazioni, ma anche una cultura della violenza e della sopraffazione. Eppure, parlando con i ragazzi che sono sottoposti a procedimenti penali e che muovono i primi passi nella musica trap o che già iniziano a essere famosi, emergono anche altri aspetti. Colpisce il bisogno di visibilità, di essere riconosciuti e di diventare famosi, tanto che l’esibizione e l’esaltazione della violenza sono spesso anche modi di colpire l’attenzione e lo sguardo dell’altro, un effetto teatrale più che una rappresentazione del reale”.

Come per ogni subcultura, l’appartenenza si mostra con dei segni specifici, che nel caso del “maranza” sono tuta e Nike Air Max TN Plus, cappellino e occhiali. Un gruppo in uniforme inquieta di per sé, e inquieta ancora di più se molti di loro sono figli di immigrati, che dalle periferie si muovono verso il centro delle città per prendersi la scena, quella scena evocata dall'immaginario sociale, la scena del lusso da cui loro sono esclusi. È il territorio che ci si prende con quelle incursioni: gli esclusi che attaccano i coetanei visti come privilegiati, per poi ritirarsi nel quartiere. Il quartiere è la marca identitaria principale – i gruppi sono molto spesso misti: figli di italiani, di maghrebini, di albanesi, di sudamericani –, produce un senso di appartenenza condiviso, attiva quella connessione profonda di cui i singoli membri del gruppo hanno bisogno – una connessione che condivide anche quel risentimento per il sentimento di essere esclusi.
Il movimento delle bande giovanili è fortemente legato alle dinamiche sociali dell'esclusione, a fronte di una cultura di massa che vede nel successo individuale la fonte di ogni possibile desiderabilità. Nella società in cui ognuno è responsabile del proprio successo in quanto imprenditore di se stesso, chi è inserito in contesti sociali marginali, a rischio, tenderà a percepire più che l'opportunità di quell'oceano di possibilità che la società promette e che i social mostrano ed esaltano, il limite che a lui lo vieta, la barriera che lo configura fin dall'inizio come un perdente, un loser, un escluso. Sarà naturale, per lui, cercare altri piani dove competere, altri campi di gioco, legali o illegali non importa: l’essenziale è poter competere e vincere. Soprattutto vincere.
Scrivono Mauro Di Lorenzo e Giulio Bertamini: “San Siro, Corvetto, Giambellino – solo per fare alcuni nomi di quartieri di Milano – sono zone nelle quali a poche centinaia di metri crescono bambini e ragazzi con esperienze diametralmente opposte: vite sacrificate in famiglie spesso numerose e complesse per i ragazzi svantaggiati, vite iper-investite sul piano dell’affetto, della relazione e del talento per gli altri. Vissuti traumatici, o di rabbia e fallimento accumulati nel corso dell’infanzia possono, nella costruzione del sé adolescenziale, portare a investire queste oggettive disparità sociali di forti proiezioni che, illusoriamente, perseguono la fantasia di riempire di valore il proprio Sé immaginando di poter svuotare l’Altro che ne è ingiustamente depositario”.
Svuotare l'Altro riprendendosi ciò che non si merita, essendo un “figlio di papà”: in questo senso, un ragazzo di un gruppo violento “racconta di come si senta in diritto di depredare chi non ha fatto niente per meritarsi condizioni di base così differenti dalle proprie. Se l’invidia rappresenta un’identificazione mancata, è evidente che quello di cui vorrebbe appropriarsi è il genitore che, nel suo immaginario, non solo non si arrabbia se il figlio torna a casa privo di un oggetto di valore, ma lo consola, se ne prende cura, gliene regala uno di valore ancora superiore perché se lo merita: insomma, lo rifornisce di tutti gli equipaggiamenti, reali e simbolici, che servono per affrontare la vita”.
Il dato dell'esclusione sociale non è sufficiente per comprendere il fenomeno dei gruppi violenti: non sono infatti pochi quelli che provengono da ambienti sociali e culturali di altro tipo, ragazzi che “si ritrovano a condividere a livello psicologico le stesse difficoltà della crescita, anche se possono avere una diversa condizione famigliare e sociale. Non vivono nelle case popolari, non hanno genitori in carcere, non hanno nulla delle storie che li renderebbero credibili in un video trap, ma sperimentano lo stesso vissuto di non avere le spalle coperte, di non potersi fidare di adulti che accompagnino la crescita, e di conseguenza di doversi affidare a un gruppo”. Le ferite nell’ambito della socializzazione che alcuni ragazzi, spesso toppo protetti, sperimentano, li portano “a interfacciarsi in prima persona con un mondo di pari molto diverso da quello che è stato presentato loro negli anni dell’infanzia. Alcuni vivono esperienze di bullismo o comunque di prevaricazione, non riescono a trovare nella scuola un contenitore che sostenga i processi di crescita, sono essi stessi immersi nella cultura del divertimento e della visibilità a cui, paradossalmente, proprio i coetanei ‘maranza’ sembrano indicare come accedere. Si è creato ormai un paradosso, per cui tra i preadolescenti i modelli ideali sono quelli rappresentati nei video trap, che invece di trasmettere un senso di disagio sociale, presentano un’immagine di forza, di qualcuno che anche grazie al gruppo non ha paura, è forte e capace di fare a meno dei genitori. Non solo nella musica, ma anche nell’abbigliamento i ragazzi svantaggiati diventano coetanei che sono nello stesso tempo temuti e idealizzati, da imitare negli atteggiamenti che assumono”.
Essere temuti e idealizzati, dunque desiderati.
In copertina, Illustrazione di © Giselle Dekel.
Leggi anche:
Elena Dal Pra | Jonathan Haidt: La generazione ansiosa
Vittorio Gallese | Haidt: quelli che... il digitale
Ivan Levrini | Meno cellulari e più trapani
Marco Rovelli | Adolescenza e disagio: figli perfetti
Alfio Maggiolini | Tutti in ansia e insicuri
Laura Porta | Gli adolescenti e il male
Enrico Manera | Studenti e docenti uniti nell’ansia
Marco Rovelli | Amelia C.: Adulti io vi accuso
Laura Porta | Gli adolescenti non vogliono essere capiti
Anna Stefi | Ma tu quando piangi? In dialogo con Pietropolli Charmet
Anna Stefi | Adolescenza: immagino dunque sono
Anna Stefi | Adolescenti: una conversazione con Massimo Recalcati