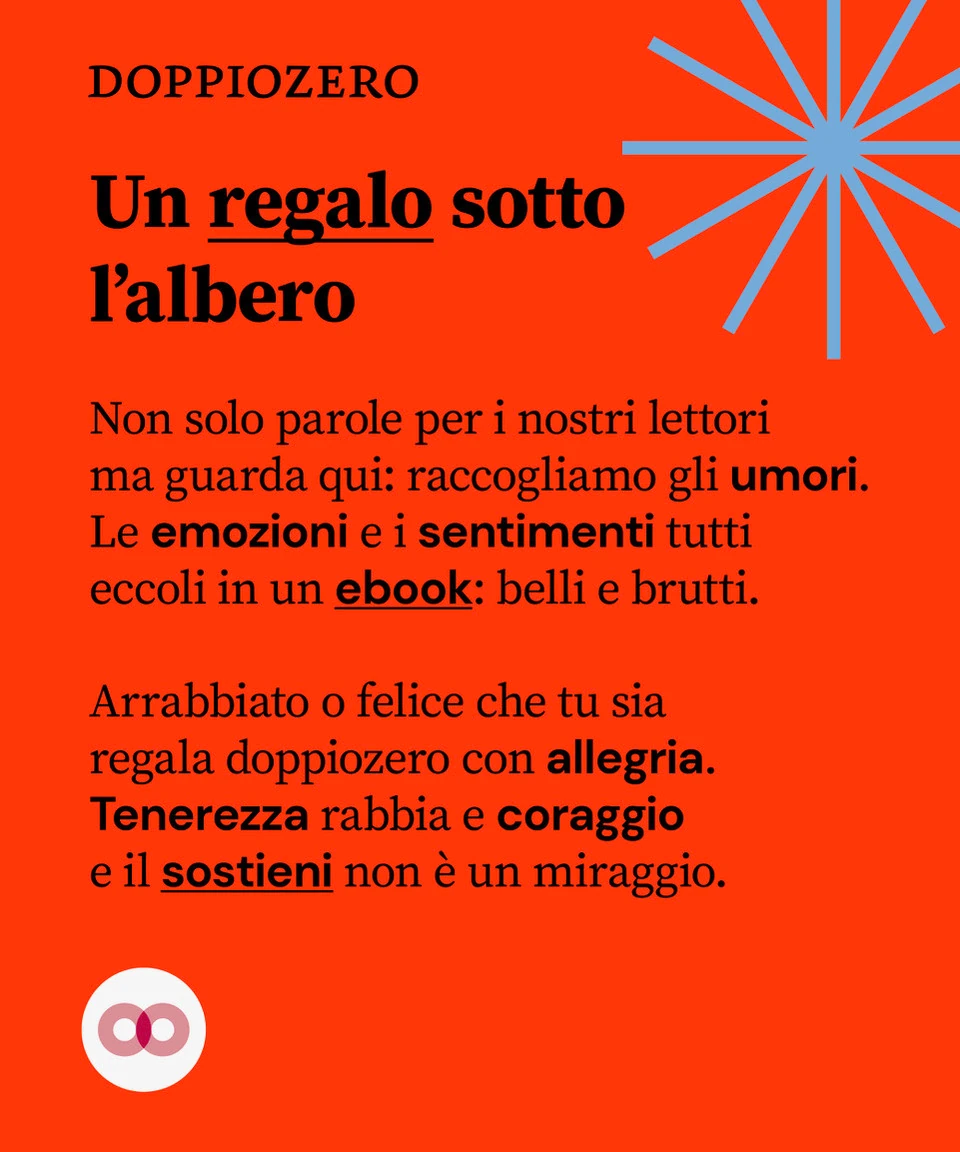Una conversazione con Norman Gobetti / I traduttori sono ladri innamorati
Traduttori, scrittori, studiosi e professionisti dell’editoria tutta si sono dati appuntamento a Urbino nell’ultimo weekend di settembre per la XII edizione delle Giornate della traduzione letteraria, a cura di Ilide Carmignani e Stefano Arduini.
Il calendario, molto fitto, prevedeva presentazioni, tavole rotonde e seminari su tematiche specifiche del mestiere in tutte le sue declinazioni, dai modi del tradurre alla figura professionale del traduttore e alla sua interazione con i professionisti dei diversi settori editoriali.
Tra i primissimi incontri, quasi a marcare fin dalla soglia l’importanza dell’aggettivo ʻletteraria’ non solo come definizione di ambito delle giornate ma anche nei risvolti creativi della traduzione, ha spiccato quello con Michele Mari che ha raccontato la sua recente esperienza di traduzione del romanzo di Andrew Motion Ritorno all’isola del tesoro (Rizzoli, 2012) e della nuova edizione italiana de L’isola del tesoro (BUR, 2012), soffermandosi sulle difficoltà poste dall’espressività stevensoniana, legata alla terminologia nautica e all’uso, da parte dell’autore scozzese, di un inglese smozzicato e sgrammaticato per la riproduzione del gergo marinaresco. Calarsi nella poetica di un autore significa anche imparare a riconoscere i tratti che caratterizzano le diverse varietà d’uso della lingua che si combinano e si annodano all’interno del sistema dei personaggi. Il traduttore, con il suo lavoro d’intarsio, ne è il primo interprete: a lui spetta il compito di scomporre e ricomporre nella lingua d’arrivo i suoni, ma anche le reticenze, quando non i silenzi, di ogni personaggio, attraverso l’ascolto e una presa di possesso per trasmutazione. A questo proposito, dialogando con Ilide Carmignani e Alberto Nocentini (Le Monnier), Mari ha rivelato che per la resa dell’idioletto del personaggio di Ben Gunn, “un delirio verbale causato dallo sfacelo mentale della solitudine”, si è ispirato alle traduzioni italiane di alcune opere di Witold Gombrowicz.
I segni della traduzione di Stevenson sono depositati nella scrittura di Roderick Duddle, nel senso che è rimasta nel romanzo “la traccia sonora di un ritmo che mi era entrato nelle orecchie e che ho dovuto assecondare".

Stare tra le lingue significa collocarsi tra la conflittualità e la negoziazione, tra ciò che è familiare e ciò che è straniante, arricchendo quella d’arrivo con gli echi, i riverberi e le corrispondenze di altre lingue non direttamente implicate nel processo ma nelle quali si è fatto più di uno scalo durante il tragitto. Della complessa relazione tra le lingue e i loro meccanismi interni che fa della traduzione un’esperienza della differenza, un viaggio d’avanscoperta dentro l’ignoto e, in ultima battuta, un atto di letteratura, hanno dato mirabolante prova Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni (Università per Stranieri di Perugia), impegnati nella traduzione, in corso d’opera, del Finnegans Wake, un testo la cui resa in italiano implica un costante gioco d’infrazione e la “licenza di delinquere” (Pedone) con più lingue contemporaneamente, muovendosi all’interno di vari universi culturali. In questa prova il senso di smarrimento davanti al testo è estremo, totale. Si è chiamati a fare delle scelte interpretative muovendosi tra le vie e le biforcazioni di una storia che è un sogno ricorrente fatto da un’infinità di storie di fronte alle quali bisogna imparare a cavarsela nell’impossibilità di dire l’ultima parola.
Nel tentativo di riuscire a trovare punti d’appoggio nella trama e di distinguere i personaggi dalle loro continue emanazioni e sdoppiamenti, i due traduttori si avventurano nella rocambolesca resa in italiano dei numerosi giochi lessicali, delle carambole musicali e delle allucinazioni sonore che “non si esauriscono con il segno scritto e che hanno a che fare con una spinta parodica portata all’estremo, fino all’oscenità, accanto ad un’erudizione mostruosa” (Terrinoni). L’oscillare della scrittura tra questi due poli obbliga il traduttore, che è il più attento tra i lettori, a dover guardare l’opera da una distanza siderale per poi, subito dopo, preparare gli occhi ad un’analisi microscopica, lettera per lettera.
Norman Gobetti, che ha tradotto opere di diversi autori, fra cui, per Einaudi, Philip Roth, Martin Amis, Pete Dexter, Philip Gourevitch, Aravind Adiga e Mohsin Hamid, e, per Neri Pozza, Uzma Aslam Khan e (insieme ad Anna Nadotti) Amitav Ghosh, ha invece dato l’opportunità ai partecipanti del suo seminario di cimentarsi in un’esperienza di traduzione collettiva di alcuni passaggi dell’opera di Philip Roth. Ha dato dimostrazione pratica di ciò che significa orientarsi in quel territorio sconosciuto che è il testo da tradurre, di cui è necessario sapere fare una cartografia per riuscire a interpretarlo senza imporre il proprio immaginario e le proprie aspettative. La lingua accoglie ogni tipo di invenzione e di esercizio, ma, per non abusare della sua ospitalità, è bene interrogarsi sul senso della strada intrapresa ogni volta che ci si incammina verso deviazioni ardite.

Con grande gentilezza, Gobetti ha accettato di rispondere per doppiozero a qualche domanda intorno ad alcuni aspetti del suo lavoro.
Come si diventa traduttori? Per quanto riguarda la tua esperienza, ti ricordi il momento in cui ha deciso di fare questo mestiere?
Nel mio caso, diventare traduttore non è stato il frutto di una decisione consapevole, ma l’esito di una proposta che mi è stata fatta, ormai quasi vent’anni fa, da Anna Nadotti, all’epoca già traduttrice molto affermata. È stata lei che, avendo avuto modo di conoscermi per altre vie (io mi ero appena laureato in storia del cinema, e all’epoca scrivevo di film e di libri), ha immaginato che sarei stato adatto a questo mestiere e mi ha proposto una prova di traduzione. E così è cominciato tutto. Va anche detto che in quegli anni non era frequente come adesso studiare traduzione all’università o in scuole postuniversitarie, perciò chi finiva a fare il traduttore di solito non aveva alle spalle una formazione professionale ad hoc. Oggi è tutto cambiato.
Una decisione consapevole invece l’ho presa quando, dopo che è nato il mio primo figlio, ho deciso di licenziarmi dal mio posto di lavoro per dedicarmi alla traduzione a tempo pieno, perché altrimenti, se volevo continuare a tradurre, non mi sarebbe rimasto abbastanza tempo per la mia famiglia. È una decisione di cui non mi sono mai pentito.
La traduzione è molto importante in un Paese dove più o meno due romanzi venduti su tre sono di autori stranieri. Questo mestiere è valorizzato in Italia?
Di sicuro oggi, almeno dal punto di vista dell’immagine, la figura del traduttore è più valorizzata che in passato (basti pensare alle numerose occasioni che oggi i traduttori hanno di mettersi in vetrina). Questo però non corrisponde affatto, come ben si sa, a una valorizzazione sul piano economico, soprattutto nel caso di chi si affaccia adesso a questa professione. Per quanto talento possano avere, mi sembra che oggi i giovani traduttori trovino molto difficilmente lavori pagati in modo anche solo minimamente dignitoso.
Quali ferri del mestiere non mancano mai sul tuo tavolo da lavoro?
Io amo molto i dizionari, e amo molto la cara vecchia carta. Per questo tendo a lavorare in biblioteche dove posso consultare molti strumenti diversi, anche perché sono sempre più convinto che i dizionari monolingue (sia inglesi sia italiani) siano altrettanto, se non addirittura più, utili di quelli inglese-italiano. Fra questi ultimi non ho particolari preferenze, secondo me ognuno ha i suoi punti di forza, dal vecchio grande Sansoni in due volumi al compatto e molto ben pensato Oxford Paravia, passando per il Picchi, il Ragazzini e l’Hazon. Poi, naturalmente, ci sono i dizionari analogici (ottimo quello Zanichelli, apprezzatissimo da chi fa questo mestiere), le enciclopedie, gli atlanti e tutto il resto. Insomma, direi che per me i ferri del mestiere sono tutto quel che si trova sugli scaffali per la consultazione di una buona biblioteca. E poi, in second’ordine, quando questo non basta, il mondo sconfinato e a volte disorientante che si apre dietro lo schermo di un computer collegato alla Rete (il mio non sempre lo è).
Traduci autori di grande rilievo nel panorama letterario mondiale, quali tra questi hai amato/ami maggiormente? Perché?
L’autore di cui ho tradotto più libri è Philip Roth. Sui suoi romanzi mi piace molto lavorare per diversi motivi: perché la forza della sua scrittura è tale che nella maggior parte dei casi per ottenere una buona resa basta lasciarsi prendere per mano e condurre da quel che c’è scritto nel testo originale; perché avendo lavorato su tanti libri suoi sono arrivato a conoscere bene il suo stile, e questo rende tutto più facile; perché i suoi romanzi sono molto letti, perciò a volte qualcuno mi dice di aver letto un suo libro tradotto da me, e questo attenua un po’ il senso di isolamento che solitamente provo.
Ma ci sono tanti altri autori su cui ho amato molto lavorare: la pakistana Uzma Aslam Khan, l’irlandese Eoin McNamee, l’inglese Pat Barker, ad esempio, scrittori che ho sentito particolarmente congeniali, particolarmente nelle mie corde. E poi Bernard Malamud, di cui ho avuto il grandissimo privilegio di tradurre un romanzo per i Meridiani Mondadori. E Amitav Ghosh, ai cui ultimi libri (libri di una grande complessità linguistica) ho lavorato affiancando Anna Nadotti, in traduzioni a quattro mani che sono state per me occasioni di crescita professionale (e anche umana) estremamente preziose.
Ti è capitato di avere un contatto diretto con gli autori che traduci? Ci puoi raccontare qualche aneddoto?
In alcuni casi ho avuto proficui scambi di e-mail, che a volte non sono rimasti confinati a questioni puramente traduttive (con Uzma Aslam Khan, ad esempio, ricordo un interessante confronto sull’atteggiamento statunitense verso il Pakistan). A Roth non ho mai scritto, ma tutte le mie traduzioni sono state riviste (oltre che dai redattori Einaudi) da una redattrice americana a lui vicina che conosce molto bene l’italiano. L’unico autore che ho conosciuto di persona è stato Amitav Ghosh, che è amico di Anna Nadotti e che quindi, attraverso di lei, ho avuto modo di incontrare in diverse occasioni. E devo dire che sono stati incontri bellissimi.
Come si fa a ricostruire lo stile di un autore e i diversi idioletti dei personaggi? Come fai a mantenere una coerenza?
Non sono sicuro di saper rispondere. Posso solo dire che di solito, quando traduco un libro, a un certo punto (spesso dopo diverse settimane) scatta qualcosa, e in qualche modo sento che da quel momento la voce che parla nel testo che sto scrivendo è davvero quella dell’autore e dei suoi personaggi, e non più solo un vago tentativo di riprodurla, il che naturalmente non mi mette al riparo da errori, goffaggini e bruttezze varie. Ma prima di arrivare a quel punto devo essere entrato in una profonda intimità col testo originale, e per far questo ci vuole tanta pazienza, e tanto lavoro dedicato alla comprensione del testo ai suoi vari livelli di significato.
A proposito di coerenza, in che modo è possibile mantenerla a livello lessicale per tutta la durata del romanzo? Costruisci tabelle? Elenchi?
Sì, costruisco tabelle ed elenchi in modo ossessivo, maniacale, al limite della follia. E costello il testo che traduco di sottolineature, segni a bordo pagina, rimandi incrociati eccetera. Però dopo tanti anni sono arrivato alla conclusione che la mia non è solo una perversione, ma davvero un metodo (certo non l’unico possibile) per arrivare ad accogliere dentro di me la voce dell’autore.
Imparare a tradurre e imparare a essere traduttori: è la stessa cosa?
No, forse non è la stessa cosa, perché “essere traduttori” comporta anche una dimensione esistenziale fatta di solitudine, routine e dubbi amletici, e comporta anche l’impagabile privilegio (se si è abbastanza fortunati) di poter vivere momenti di vera attenzione, momenti che per come la vedo io sono i più preziosi che si possano vivere.
Quanto tempo ti serve per tradurre un romanzo? Durante la revisione intervengono gli autori? A proposito di revisione: necessita di quanto tempo?
Io cerco di avere sempre a disposizione un mese per ogni cento pagine del teso originale (tempo necessario non solo per tradurre in senso stretto, ma anche per lavorare alla comprensione del testo, alla revisione e alla rilettura finale).
Per quanto riguarda la revisione, di solito nella mia esperienza gli autori vengono consultati solo in casi particolari, quando ci si trova di fronte a problemi che non si riescono a risolvere in nessun altro modo. Philip Roth, come dicevo, fa rivedere le traduzioni a persone di sua fiducia, ma questo mi è capitato solo con lui. Con Amitav Ghosh invece c’è uno scambio molto ricco già in fase di traduzione, sia per la sua amicizia con Anna Nadotti, sia perché i suoi libri a cui io e Anna abbiamo lavorato insieme, Mare di papaveri e Il fiume dell’oppio, presentavano difficoltà linguistiche molto particolari, e di conseguenza abbiamo dovuto prendere diverse decisioni riguardo alle quali ci è sembrato opportuno consultare l’autore. Sui tempi della revisione: se una revisione è fatta bene richiede tanto tempo, a volte non molto meno di quello necessario alla traduzione.
Proponi titoli o ti vengono commissionati?
Io non ho l’abitudine di proporre titoli da tradurre. Di solito, se posso, accetto ciò che mi viene proposto.
Degli autori che hai tradotto e stai traducendo quale opera è stata una sfida più delle altre? Perché?
Forse il libro più difficile (insieme a quelli di Ghosh, per i quali, però, mi sono potuto giovare dell’esperienza e del talento di Anna) è stato The Geometry of God di Uzma Aslam Khan (poi uscito col titolo italiano, a mio parere non molto felice, Mehwish parla al sole). Gran parte della complessa architettura linguistica del romanzo si basava infatti su ambiguità semantiche create da giochi di parole a cavallo fra l’inglese e l’urdu (per questo ho sentito il bisogno di contattare l’autrice). Però è stato un lavoro molto divertente e appagante (peccato che poi il libro sia passato pressoché inosservato: era un libro molto bello e molto attuale, e oggi forse è ancora più attuale).
Che rapporto hai con le note del traduttore? E con le traduzioni precedenti degli autori che stai traducendo?
Le note del traduttore mi sembra stiano diventando sempre meno necessarie, almeno per due motivi. Il primo è che, non esistendo più una “cultura generale” condivisa, è impossibile prevedere che cosa il lettore italiano del libro sarà o non sarà in grado di capire da solo. Il secondo è che, qualunque dubbio possa avere, presumibilmente il lettore sarà in grado di risolverselo da solo in pochissimo tempo rintracciando le informazioni necessarie. Rimangono le note a cui il traduttore ricorre quando non riesce a trovare una resa soddisfacente (talvolta, ad esempio, nel caso di giochi di parole cosiddetti “intraducibili”). Questa, come è ovvio, è sempre una sconfitta. Ma a volte sconfitti lo siamo, e allora sì, meglio ammetterlo.
Per quanto riguarda le traduzioni precedenti (e ultimamente mi è capitato spesso di ritradurre libri che erano già stati tradotti, soprattutto nel caso di Roth), mentre traduco non le guardo mai, ma poi, in fase di revisione, le studio attentamente, e a volte così facendo mi accorgo di avere commesso degli errori che il traduttore precedente non aveva commesso, e dentro di me lo ringrazio perché così li posso correggere. Quando invece mi accorgo di aver rimediato io a un errore presente nella versione precedente, be’, è una bella sensazione.
Come ci si libera delle goffaggini commesse? Con un revisore competente?
Il revisore è indispensabile, sempre e per tutti, anche per il traduttore più bravo del mondo, e secondo me è una vergogna che il nome del revisore non compaia quasi mai da nessuna parte (fanno eccezione, che io sappia, i libri di minimum fax). Chiunque traduca sa quanto il revisore interviene sul testo; quasi sempre, nella mia esperienza, in modo utile e opportuno.
Serve poi, più d’ogni altra cosa, l’attenzione. Ma l’attenzione è uno stato mentale faticosissimo sia da raggiungere sia da mantenere, ed è a questa difficoltà che vanno innanzitutto attribuite, io credo, le goffaggini, e anche i veri e propri errori, dei traduttori.
Che consiglio daresti a un giovane traduttore alle prime armi?
Gli direi di sforzarsi in ogni modo di coltivare l’attenzione, di non sottovalutarla mai, di non sprecare la grande occasione che questo mestiere ci dà: esercitare la virtù che conta più d’ogni altra.
Nel suo saggio All’ombra dell’altra lingua, Antonio Prete afferma: “la traduzione è anche un affrontamento audace dell’altro. Perché pretende di sottrarre all’altro quello che egli ha di più proprio, la lingua. [...] Eppure la traduzione si avventura in questo azzardo. E dispiega il suo faticoso esercizio come riparazione e compensazione di questo gesto che ha tanto osato”. Sei d’accordo?
Sì. È vero, come ogni mio collega sa per esperienza, traducendo un testo gli si porta via tanto di prezioso. Però il “faticoso esercizio” di cui parla giustamente Antonio Prete è anche un bell’atto d’amore. Io credo che non esista, e non possa esistere, lettore più profondo, attento e amoroso di un traduttore. Se fossi uno scrittore, io sarei molto contento di avere fra i miei lettori almeno qualcuno di quei ladri innamorati che sono i traduttori di un libro.