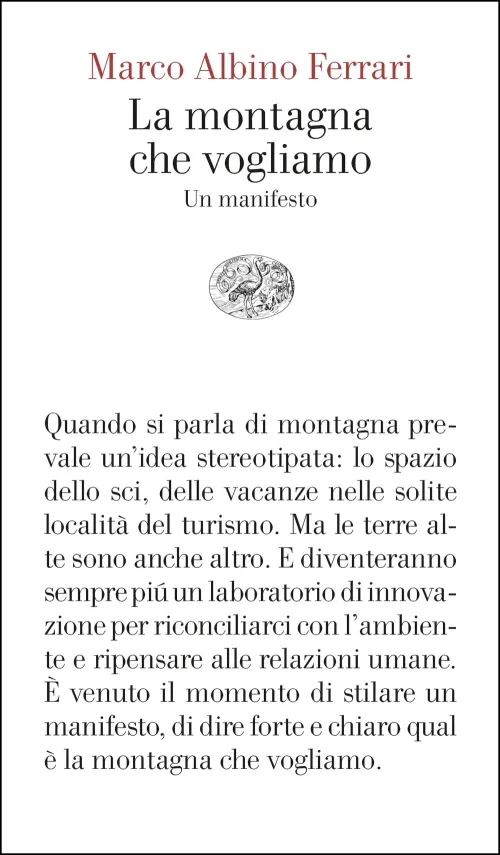In montagna, via dalla pazza folla
Possiamo dire che nei discorsi sulla montagna, culturali e politici, ci sia uno spartiacque: la pandemia da coronavirus 2019-2021. C’è un prima e c’è un dopo. Negli ultimi anni sono arrivati molti nuovi materiali importanti: ricerche scientifiche universitarie (antropologiche, sociologiche, geografiche), valutazioni di strategia politica nazionale, dati demografici, finanziamenti europei dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) successivi alla pandemia, l’aumento esponenziale dei disastri ambientali in Europa, dovuti all’innalzamento della temperatura media sul pianeta Terra. Abbiamo ormai in Italia almeno una decina di “scrittori di montagna” che nei loro libri e nelle loro conferenze vanno ben oltre l’abituale letteratura alpinista, assumendo responsabilità di denuncia e di proposta per il tema che oggi interessa: possiamo riabitare la montagna?
Toh, sono in un trend
Sin da quando la rivoluzione industriale di secondo Ottocento ha cominciato a ingigantire e moltiplicare le aree metropolitane, la qualità della vita in quelle aree è prima migliorata, per poi peggiorare in accelerazione a partire dal boom consumistico degli anni Sessanta. I contadini vivevano bene, nelle campagne? Sì e no: poveramente, duramente, ma con una loro civiltà. I montanari vivevano bene, nelle montagne? no, molto poveramente, molto duramente, ma con una loro civiltà. Durante tutto il Novecento, in Italia, si sono svuotati il Sud, le campagne e le montagne: se è accaduto è perché – come per ogni migrazione – le condizioni di vita da cui si partiva erano insostenibili, e quelle che si andavano a trovare erano indubbiamente migliori; mio padre è nato in una stalla a 1200 metri di altitudine in una vallata occidentale piemontese; orfano di madre in tenera età per una epidemia di tifo, fu l’unico sopravvissuto di una decina di fratelli; finita la Seconda Guerra Mondiale, è sceso in città, studiando di notte, lavorando in una officina meccanica di giorno, beccandosi la tubercolosi, guarendone, mettendo su famiglia, divenendo un impiegato comunale ed andando in pensione abbastanza giovane; è sempre tornato nel suo paese di origine, ha sempre portato noi suoi figli in lunghe, per noi bambini bellissime estati, ma non è mai tornato a vivere in montagna, neanche nei suoi decenni di pensionato. Io ora ho ereditato la sua casa natale, l’ho risistemata investendo molti soldi, dando lavoro a giovani ottimi artigiani della valle, e sono quasi certo che tutta la mia breve vita da pensionato la vivrò in quella casa, in montagna.
Perché voglio riabitare la montagna? Il mio non è solo un caso personale: leggendo alcuni dei recentissimi libri sulla montagna ho scoperto che sono in un trend culturale e sociologico. E ho appena fondato con 14 amici una associazione di promozione sociale che vuole operare lì per ricostituire lì una comunità possibilmente di residenti anche non originari di lì, in quel paese svuotato, pensando al futuro più che al passato, innovando la tradizione e non coltivandola in un culto del “bel tempo antico”; bel tempo antico un corno! La vita di mio padre bambino fu tremenda: me la raccontava.
Il mio amico di infanzia è contento di questa mia scelta, ma gli scappano spesso battutacce su “voi cittadini!”: perché metto un pietrone a bloccare lo pneumatico della mia auto nuova se parcheggiata in pendenza; perché non salgo nel weekend se nevica e ci sono -7° e il lunedì mattina devo essere in città al lavoro alle 8AM; perché scaldo troppo la casa quando vado su; perché “te ne stai sempre chiuso in casa al computer! Non so neanche se sei vivo o se sei morto!” eccetera. Lui è pensionato e fa l’oste nella trattoria che aprì sua mamma, e stiamo lavorando insieme nella nuova associazione. Chissà come andrà a finire.
Solitudine e comunità
Via dall'ignobile lotta della pazza folla
i loro sobri desideri non impararono mai a deviare;
lungo la fresca e appartata valle della vita
mantenevano il tenore silenzioso del loro cammino.
Thomas Gray, An Elegy Written in a Country Churchyard (1751)
Uno di questi versi di Thomas Gray diede il titolo al romanzo di Thomas Hardy Via dalla pazza folla (1874). Sin dai tempi delle Bucoliche di Virgilio si è idealizzata letterariamente come incantevole e perduta la vita agreste. Hardy nel personaggio del pastore Gabriel Oak vedeva tutte le virtù contadine che la Londra a lui contemporanea aveva dissipato: il duro e incessante lavoro manuale, la conoscenza della Natura, la lotta quotidiana in una Natura niente affatto idilliaca, le catastrofi, la comunità, la schiettezza dei sentimenti e delle passioni, il tramandare cose e stili di vita.
Questo passo di Hardy, dedicato a inquadrare Oak, ci riguarda: «Essendo uomo non privo di frequente consapevolezza che vi fosse un certo incanto nella vita che menava, ristette, dopo aver guardato il cielo come uno strumento utile, e lo contemplò con spirito di comprensione, come un’opera d’arte di suprema bellezza. Per un istante, parve impressionato dalla eloquente solitudine della scena, o piuttosto dalla completa astrazione, per tutta la sua estensione, dalla vista e dai suoni dell’uomo. Forme umane, intromissioni, preoccupazioni e gioie erano tutte come se non esistessero, e sembrava non vi fosse sull’emisfero oscurato del globo nessun essere senziente all’infuori di lui; e poté fantasticare che fossero tutti partiti per il lato soleggiato».
Questa “poetica della wilderness” non è propriamente quella più utile, in questi anni in cui per la montagna si cerca di fare veramente qualcosa di permanente. Lo stesso indiscusso padre della nostra nuova generazione di scrittori di montagna, Mario Rigoni Stern, non è mai scivolato in mielose celebrazioni della montagna-così-com’era; l’ha raccontata sobriamente come un luogo fortemente identitario, da non assaltare consumisticamente; non da colto cittadino alpinista, ma da montanaro che scriveva, e raccontava la montagna essendone parte. Nei libri e nei documentari sulla montagna (di Andrea Fantino, Silvy Boccaletti, Andrea Costa…) che stanno uscendo a frotte si dà la caccia agli ultimi veri montanari sopravvissuti: memorie, parole, saggezze che stanno sparendo così come sono spariti a milioni i montanari dalle montagne negli ultimi ottant’anni. E quando saranno morti tutti?
Il COVID-19 ci ha fatto rivivere per forza due cose fondamentali, per l’umanità: la solitudine e la comunità; il COVID-19, capitato nell’era dei viaggi globali ma anche della comunicazione digitale globale, ci ha fatto capire che non è più così importante dove stai, ma come stai. La maggior parte di noi passa il suo tempo libero in un piccolo appartamento di città collegato a internet, con connessioni ormai molto veloci; in montagna ho messo un’antenna Starlink e da quando ce l’ho mi sono accorto che lassù vivo esattamente come vivo in città: ma se esco l’aria è ancora pulita, la Natura c’è ancora, ma non c’è più la miseria montanara che soffrì mio padre; in auto posso andare a comprare il cibo e il pellet per la stufa, e in piazza incontro delle persone che hanno voglia di parlarmi. Da maggio a settembre non devo più accendere un climatizzatore a palla, spendendo soldi e inquinando il Pianeta. Perché mai dovrei ancora stare in città? Qui ci sono le mucche e le pecore. Ci sono i margari che fanno il formaggio. Io e il mio amico di infanzia potremmo recitare in un sequel di Il vento fa il suo giro (scritto 20 anni fa da Fredo Valla), o di Le otto montagne (scritto da Paolo Cognetti nel 2016).
Le parole le abbiamo: occorrono fatti
Da qualche mese è uscito Il richiamo della montagna, di Matteo Righetto per Feltrinelli, e da poco La montagna che vogliamo. Un manifesto di Marco Albino Ferrari per Einaudi e Diventare montanari. Viaggio tra i nuovi abitanti delle terre alte, editore People, in una collana curata da Ferrari e dal geografo Mauro Varotto per il quotidiano on line “L’AltraMontagna”, il più interessante think-tank disponibile oggi in Italia per provare a persuadere la politica nazionale e locale ad ascoltare il molto che ormai si è pensato e non si fa ancora.
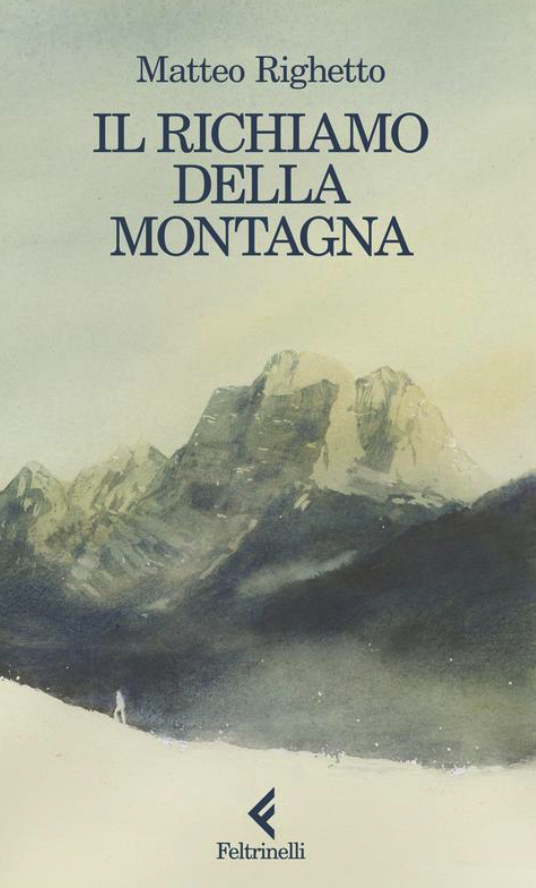
L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) da mesi sta presentando in mezza Italia il suo interessantissimo Rapporto Montagne Italia 2025; qui, con la forza dei dati, si cerca di ribaltare la lagna depressiva sulla inesorabile agonia delle “aree interne” italiane: negli ultimi cinque anni (tra 2019 e 2023), le persone che hanno trasferito la propria residenza in uno dei 3.417 comuni della montagna italiana hanno largamente superato quelle che hanno abbandonato quegli stessi comuni, con un saldo positivo che ha avvicinato le centomila unità (99.574). L’analisi qualitativa del mero dato è ancora più sorprendente: negli ultimi cinque anni i cittadini italiani che sono saliti a vivere in montagna sono stati 63.909 in più di quelli che la montagna la hanno abbandonata, e rappresentano quasi i 2/3 del totale del saldo positivo.
La questione è proprio questa: riabitare la montagna non è molto significativo se lo fa un pensionato che trasforma in prima casa la sua seconda casa; come possiamo invece portare a vivere e lavorare in montagna gli under 40? gli under 30? Perché facciano dei figli e stiano qui? Come possiamo rendere costante questo flusso indubbiamente spinto dal nuovo modo di pensare la propria vita maturato negli anni della pandemia?
Ferrari giustamente parte dal Manifesto di Camaldoli per una nuova centralità della montagna (2019) che in un passaggio recita: «Una montagna frequentata, abitata e produttiva, che presidia il territorio, preserva la piena funzionalità dei servizi eco-sistemici, riduce i rischi naturali, salvaguarda il patrimonio, contribuisce all'occupazione, al reddito nazionale, diventa un laboratorio di nuovi stili di vita e di integrazione sociale». Ci sono nuove leggi approvate nel Parlamento italiano (Legge 12 settembre 2025, n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”), varie nuove leggi delle Regioni alpine, residui del PNRR dall’Unione Europea. La situazione ha del potenziale. Ma quello che c’è già (la magistrale impresa forestale della Magnifica Comunità della Val di Fiemme, i rifugi rimasti rifugi autentici gestiti da giovani neo-montanari, i marchi di formaggi DOP e relativi margari, i ristoratori spesso giovani, ecc.) non basta ancora a rifare della montagna italiana una realtà vivente e soddisfacente.
Ferrari suggerisce strade: le leggi regionali che incoraggiano le associazioni fondiarie, ad esempio; le microproprietà di terreni montani, spappolate in decine e decine di microproprietari che le abbandonano al ritorno di boschi selvaggi e non sani, permette di metterle in comune per specifiche attività, forestali o pastorali: un esempio di successo è quanto è realizzato nelle Aree Protette Alpi Marittime dove l’ente di gestione di questi parchi regionali con sede a Valdieri, in provincia di Cuneo, ha rivitalizzato un’ampia zona di montagna dando lavoro a un pastore e al suo gregge, riportando a utilizzo e bonifica foreste selvatiche che si formano ovunque con l’abbandono dello sfalcio dei prati.
Altra strada è ripristinare una filiera del legno che rimetta a vitalità i boschi recenti, che tra l’altro con il riscaldamento climatico stanno salendo in altitudine riducendo le aree di pascolo: in una logica di riduzione dei consumi energetici, per evitare di bruciare gas nei riscaldamenti privati e pubblici, si può ricominciare a dare al taglio boschi oggi abbandonati, riportando nelle valli mestieri scomparsi come quello dei boscaioli, producendo legna da ardere o pellet, giù fino a valle riaprendo segherie, producendo da noi il legno che paradossalmente in Italia importiamo a tonnellate dall’estero.
Infine: nelle vallate alpine italiane ci sono centinaia, migliaia di ruderi ristrutturabili a costi non folli, ma anche crescenti ex ruderi ben ristrutturati, che rimangono però vuoti: seconde case di espatriati che le abitano una o due settimane d’estate, appartamenti in mano a consorzi di imprese della pianura che li hanno ristrutturati spesso con garbo per trarne un profitto limitato a brevi periodi estivi o invernali; molte coppie giovani che vogliono trasferirsi in montagna hanno difficoltà a trovare case abitabili per il loro restare: in questo senso occorre una politica della casa in montagna, che renda i paesi vuoti paesi pieni di abitanti.
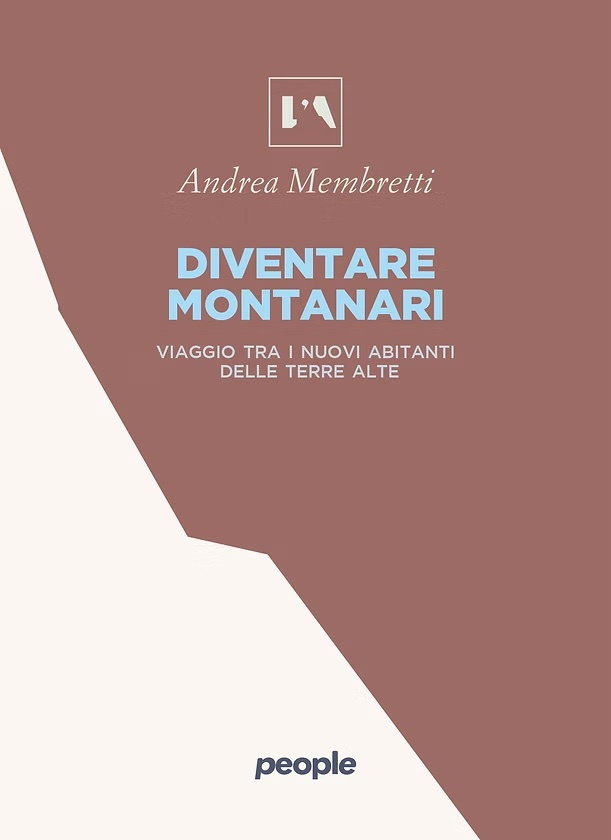
Sociologia dei nuovi montanari
Andrea Membretti insegna Sociologia del Territorio all’Università di Pavia e all’Università di Milano-Bicocca, è tra i pensatori dell’associazione Riabitare l’Italia; conduce stage con persone che dalle città vorrebbero andare a vivere in montagna: molti trentenni, molte donne; e molte delle persone che ha incontrato si sono trasferite poi veramente. In Diventare montanari Membretti censisce tre classi sociali di neo-montanari:
- L’upper class dei ricchi multinazionali che si rifugiano a vivere in (inquietanti) neo-città ad alta quota come Crans-Montana nella Svizzera francese;
- La middle class di giovani e meno giovani stufi di vivere in aree metropolitane sempre più degradate e costose, bollenti d’estate, inquinate d’inverno, chiusi in miniappartamenti lontani dai centro-città sempre più turistici e costosi;
- L’under class, ovvero i braccianti stagionali, che si vedono in bicicletta o monopattino sulle strade delle valli d’estate, al tramonto, lasciati i campi; i pastori, i margari che non vedi se proprio non vai a stanarli sempre d’estate su agli alpeggi, completamente soli con i loro armenti.
Io per Membretti sarei, con la mia storia personale, un middleclass proprio a fagiolo: «Il famoso ceto medio, il collo sempre più stretto della nuova clessidra sociale: ancora abbastanza benestante da non finire fuori, espulso dai luoghi del benessere, ma non più abbastanza ricco da rimanere stabilmente dentro. E quindi in ansia, privato com’è degli orizzonti di crescita infinita e di progressiva redistribuzione delle ricchezze a cui i boomer (ma solo loro) hanno potuto credere per qualche decennio. Stretto dall’assedio della pandemia, del caldo tropicale nelle metropoli di pianura, della crisi dei servizi di welfare, della perdita di garanzie lavorative, di senso, di relazioni, di prospettiva futura». Per i pochissimi che sono rimasti residenti (nel mio Comune di montagna, che ha un territorio sconfinato dai 1.000 ai 2.000 metri, i residenti sono 50) noi nuovi residenti siamo gente di cui diffidare, antipatica: “Dove sei stato in tutti questi anni? – mi gridano in faccia quando litighiamo – adesso torni su e vuoi insegnarci come vivere?”. Generalmente chi è restato è amareggiato, arrabbiato, scettico, conservatore se non reazionario. Ci vedono come dei progressisti rompipalle supponenti, neo-colonizzatori… penso che nel presente sarà difficile capirsi… ma ricominciando a considerare insieme che un futuro esiste, se non per noi per i nostri figli e nipoti, potremmo ricominciare ad abitare in modo intelligente e contemporaneo una Natura che non siamo ancora riusciti a distruggere. Tornare una comunità, come scrive Membretti: «Una comunità in cui inserirsi o comunque un insieme di relazioni sociali in minor numero rispetto alle tante spesso effimere vissute nella metropoli. Eppure, quelle che servono a darsi una collocazione nel mondo, un posto nel grande rimescolamento globale oggi in atto»