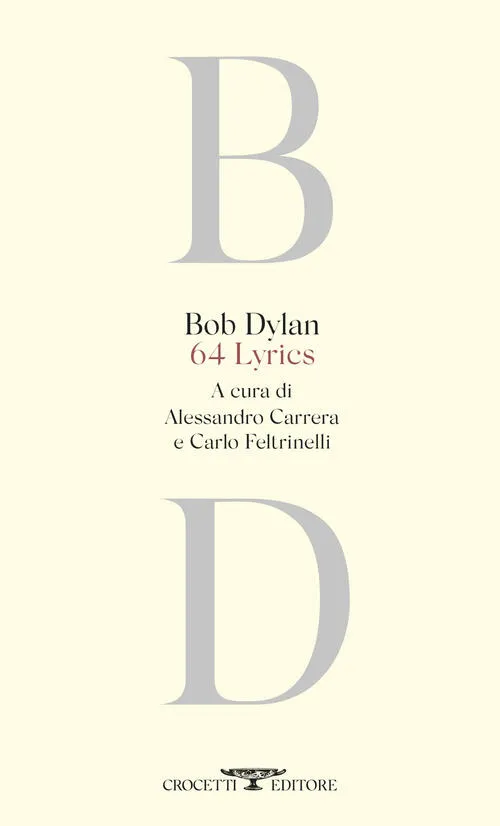Dopo la lirica: Bob Dylan
L’operazione editoriale di cui mi appresto a scrivere è destinata a far parlare di sé. Nella collana di poesia Crocetti, che nel solo 2025 ha accolto tra gli altri Jorie Graham e Anne Carson, Walt Whitman e Arthur Rimbaud, Raoul Schrott e Ruy Duarte de Carvalho, e che si è appena arricchita della monumentale Immortale parola. Antologia della poesia italiana dalle origini ai giorni nostri (per le cure di Milo De Angelis, Nicola Crocetti e Davide Brullo), è uscita una selezione di 64 canzoni (Lyrics) di Bob Dylan, tradotte da Alessandro Carrera. Si tratta in realtà di un lavoro a quattro mani: curatela e prefazione – insomma, il libro nella sua totalità (o quasi) – sono firmate dallo stesso Carrera insieme a Carlo Feltrinelli.
Lyrics è un falso amico – canzoni è una buona traduzione, ma lo sarebbe stato anche poesie (o liriche). E per chi si occupa di teoria e storia della poesia lirica, con un occhio e un orecchio (magari due occhi e due orecchie) rivolti a quello che fanno gli americani e i tedeschi, lyric e Lyrik sono due termini semanticamente e storicamente rilevanti: distinguono, categoricamente, la poesia lirica da altre forme di poesia (quella epica e quella drammatica, anche se nessuno scrive quasi più poemi epici e testi teatrali in versi), e si rifiutano di considerare quello che dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi è considerato comunemente come poesia (poetry, Poesie): una forma scritta, tendenzialmente breve rispetto alla prosa, dotata ancora di un apparato prosodico più o meno riconoscibile (anche quando il verso è libero), in cui una prima persona singolare – che in alcuni casi coincide con l’autore, in altri soltanto gli somiglia – si esprime in versi usando un linguaggio non ordinario, per lo più metaforico ed egoriferito, per dire qualcosa di sé e del mondo.
A questa premessa, però, ne va aggiunta un’altra: le lyrics sono anche le parole che si usano per scrivere una song (una canzone); e dato che nella prefazione Carrera e Feltrinelli parlano di canzoni e di poesia (ma non di lirica, il che è interessante) per Dylan, la volontà, autoriale (doppia, in questo caso, o tripla, se contiamo anche l’editore) di questa edizione si muove in un territorio plurale, dove parola scritta, canzoni e poesia diventano un unico strumento (tra il formale e il culturale), che permette a Carrera e a Feltrinelli di assegnare la patente di poeta a Dylan: “Secondo gli standard della poesia scritta, Dylan non è un poeta; scrive versi per la voce e non per la pagina. Ma la poesia non si fa confinare in una pagina, e la forza di quei versi scritti per la voce trascende la voce stessa. Sono versi che vogliono essere riascoltati dalla sua o da altre voci, imparati, interpretati, dibattuti, chiosati e infine letti, riletti e tradotti. Dylan è una singolarità, un’urgenza del linguaggio che ha piegato la lingua inglese a espressioni che nessuno aveva ancora sospettato che potesse contenere, o magari sì, ma nessuno aveva immaginato che si potesse incarnare nella forma canzone” (9). “Un bardo americano”, proprio come “Walt Whitman”.
La prefazione, per chi volesse leggerla per intero, mantiene questo tono epico, quasi sacrale nei confronti di uno scrittore – definizione che mi pare pacifica, e non solo in virtù del tanto discusso Nobel per la letteratura del 2016 – che ha sconvolto, travolto e cambiato radicalmente l’immaginario culturale della musica nel secondo Novecento (and counting), insieme alle possibilità stesse della musica: la possibilità, cioè, di essere altro da sé, di essere, insieme, musica e poesia: Dylan non è un “poeta confessionale” né scrive “canzoni di protesta” – compone “edifici verbali”; “è un poeta ultra modernista, forse il solo rimasto”; i suoi versi sono un “universo di suoni”, pieno di “frasi oracolari”, che come con l’I-Ching o con un mazzo di tarocchi, può contenere qualche “indicazione sorprendente e salvifica”.

Scrivere che Dylan è “un poeta anche se non è un ‘poeta’, così come è un ‘poeta’ anche se non è un poeta” è una formula efficace, in linea con la tensione iperbolica che attraversa l’introduzione (“le migliori canzoni di Dylan sono tutte le canzoni”), ma non mi convince del tutto. Non sarò certo io, parafrasando Carrera e Feltrinelli, a turbarmi per questa associazione – o sovrapposizione – tra musica e poesia; ma, per riprendere le parole dei due prefatori, sono piuttosto “le trasformazioni alle quali Dylan sottopone i suoi brani dal vivo [che] danno vita a creature metamorfiche la cui rassomiglianza con l’originale può essere piuttosto vaga”.
Tutti noi abbiamo una canzone e una poesia preferita. La mia canzone preferita di Dylan è Mr. Tambourine Man. La mia poesia preferita è Alle soglie di Guido Gozzano. Sono due oggetti molto diversi, e non tanto per questioni stilistiche o estetiche (ultramodernismo e crepuscolarismo, qualunque cosa queste etichette significhino), o addirittura formali (che per me costituiscono i veri discrimini tra musica e poesia), quanto per la loro testualità performativa.
Se apro a pagina 74, per esempio, non appena mi avvicino al testo sento – ascolto – tre suoni che sulla pagina non ci sono: il suono dell’armonica, quello della chitarra e quello della voce di un Bob Dylan insieme giovanissimo e già un po’ agé, che si attivano nella mia mente ancora prima che io legga le parole. E insieme riconosco il Newport Folk Festival (da un link su YouTube, 1964). È vero che in Dylan la voce può trascendere sé stessa (ma questo è un tratto di Dylan o, più in generale, della musica?); nella poesia, invece, come ci ricorda Eliza Richards, la “voce” è assente – o meglio: è un termine problematico e intrinsecamente metaforico, perché evoca l’oralità per descrivere e analizzare la parola scritta.
La voce di Dylan ha un corpo reale, quella di Gozzano – che per ovvie ragioni anagrafiche non ho mai sentito né visto – no. La performatività della musica agisce in un modo, quella della poesia in un altro: i corpi sono diversi, ma lo sono anche le intenzioni e le rispettive volontà autoriali. La voce di Dylan è costitutivamente metamorfica, cambia in continuazione (un po’ come il teatro, che è ogni volta diverso), mentre quella di Gozzano è necessariamente la nostra, un effetto di eco – o, appunto, di voicing, il testo che “produce una voce” – che si incastra nella memoria in base alla qualità prosodica del testo: se il testo è, cioè, capace di restare vivo, memorabile, di farsi ripetere – di essere poesia. E soprattutto diventa una voce che nasce dentro e attraverso il testo, grazie ai suoi effetti (che possono avere anche a che fare con la nostra presenza, come leggere Alle soglie in ospedale o durante una lezione all’Università), che sono veicolati dalla carta stampata, dalla sua impaginazione, dall’uso della punteggiatura, dalla divisione in strofe o in sezioni; insomma, da tutto ciò che permette a una poesia di essere ritualistica.

Mr. Tambourine Man, per esempio, presenta un uso parco di segni grafici (qualche punto esclamativo e poche, sparute virgole) e una divisione in quattro strofe che sinceramente ignoravo – o che avvertivo appena, nella canzone di Dylan – così come il ritmo e l’uso dell’inarcatura: il verso va a capo, ma ho l’impressione che Dylan faccia una pausa quando arriva a fine verso. Nella versione italiana, infatti, questo aspetto performativo viene restituito con un uso pressoché totalizzante di virgole e punti fermi a fine verso, cosa che non c’è nell’originale inglese. E in questo caso, chi devo seguire: la canzone che ascolto (e che conosco a memoria) o il testo scritto? E perché il testo italiano chiude con un punto fermo, mentre quello inglese rimane aperto? Non mancano, naturalmente, esempi di poesie prive di punteggiatura o con un uso peculiare dei segni grafici, che producono effetti di senso ancora prima che noi attribuiamo un significato al testo (che cosa fa, per esempio, una parentesi in una poesia? ci distrae? Attira la nostra attenzione? Attiva un’altra voce – e di chi?); ma proprio per questo, nella lettura di una poesia, bisogna tenere conto anche di queste assenze (di queste presenze).
Alle soglie è un testo insieme antico e moderno: Gozzano usa un doppio settenario (composto da due emistichi di sette sillabe ciascuno) con un complesso sistema di rime che produce un effetto fonico particolare – che può anche non piacere – e mette in scena la decostruzione dell’io lirico, che si chiama guidogozzano e parla della morte che è ormai, tautologicamente, alle soglie. Al netto di tutto ciò, la scansione è rigida: il testo è diviso in tre sezioni, i distici sono visivamente separati gli uni dagli altri, e il ritmo è imposto dal sistema metrico scelto da Gozzano, dall’uso non parco della punteggiatura e da una sintassi varia, che comprende dialoghi, monologhi, diverse figure retoriche e persino una significativa parentesi.
Mi è capitato, come a molti, di assistere a letture pubbliche di poesia, sia da parte degli stessi autori sia da parte di lettori che interpretavano testi altrui. Ma la testualità fissa della parola scritta – della poesia – pensata per stare sulla pagina (almeno dall’Ottocento, con l’affermarsi della cultura della stampa), limita non poco i margini di manovra di chi legge ad alta voce: ci sono regole da rispettare, così come accade nella musica. E è capitato anche, come a molti, di andare a un concerto di Dylan e di ascoltare varianti – spesso poco fedeli – delle sue canzoni, dal vivo o tramite altri mezzi di diffusione. E lì ho potuto esperire in prima persona un diverso uso del corpo e della voce, che si trasformano metamorficamente a seconda del tempo, dello spazio e del mezzo performativo: un testo scritto, una voce dal vivo, una playlist su Spotify, un vecchio vinile di mio padre.
Questo non vuole togliere di certo alcun valore qualitativo all’opera di Dylan, che rimane straordinaria, se presa nella sua singolarità (un verso, alcune immagini, dei suoni, lo sperimentalismo linguistico, un gioco metaforico) – la poesia fa altro ed è altro, oggi: per esempio, come dobbiamo considerare la ripetizione sistematica di interi gruppi storici in una canzone? Una poesia di quattro strofe che avesse come prima e terza strofa “Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me / I’m not sleepy and there is / no place I’m goin’ to / Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me / In the jingle jangle mornin’ I’ll come followin’ you”, non suonerebbe affatto bene. Ma non è questa credo, la forza, di Mr. Tambourine Man – non (solo) il testo nella sua totalità, bensì alcune sue porzioni e unità testuali (come l’impero della sera che torna nella sabbia, la stanchezza che stupisce, i sensi denudati, o l’incantesimo di danza con cui si chiude la canzone), certe immagini che la musica e la voce di Dylan hanno reso ancora più poetiche di quanto già non fossero e che fanno sì che la sua prosodia e la sua testualità – tanto nella dimensione performativa quanto in quella fissa – riescano come poche altre a tendere alla poesia restando musica, elevandosi così a qualcosa di diverso, unico e probabilmente irripetibile nell’immaginario culturale del nostro tempo.
Leggi anche
Alessandro Carrera, Bob Dylan, un illustre sconosciuto
Umberto Fiori, Bob Dylan: uno scrigno senza fondo
Alessandro Carrera, Dylan ha ottant’anni e mi ha stremato
Alessandro Carrera, Bob Dylan. Il discorso del cantante
Alessandro Carrera, Bob Dylan. Murder Most Foul
Alessandro Carrera, Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways
Alessandro Carrera, Bob Dylan eBook