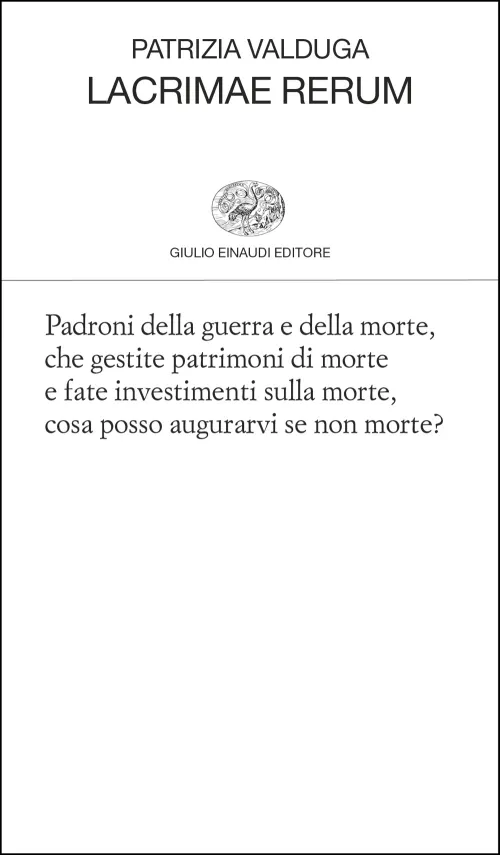Le lacrime di Patrizia Valduga
Le scritture dell’io, quale che sia la forma che effettivamente prendono nei nostri file Word, sono scivolose: fino a che punto possiamo dire quello che sentiamo in un saggio, in una poesia o in un racconto? Oppure in un romanzo autobiografico? La patente di espressività è garantita più o meno a tutti (voglio dire: viviamo ancora in democrazia), poi ci pensano lo stile, la consapevolezza delle forme, gli usi e i costumi che veicolano i modi in cui ci esprimiamo a circoscrivere i limiti dei nostri gradi di espressività e anche i temi (ma qui, invece, qualche forma di autocensura culturale talvolta si verifica). In ogni caso, nel multiforme mondo delle scritture del contemporaneo, nonostante gli avvisi, i cartelli, mettiamoci anche qualche indicazione dei cosiddetti Maestri, un desiderio mai del tutto risolto di confessionalità e una vocazione altrettanto irrisolta per l’etica (essere scrittori impegnati) attraversano, senza una direzione precisa, le intenzioni e gli esiti della poesia – e questo vale oggi, ma vale anche ieri: si pensi solo, tra gli esempi più alti che si potrebbero fare, alle “Rime non crepuscolari, / ma verdi, elementari” che Giorgio Caproni usa in Il seme del piangere per attraversare il lutto della scomparsa della madre, Anna Picchi. Ma non a tutti piace il primo Caproni, quello più confessionale, privato, patetico per alcuni, e per altri meno filosoficamente impegnato rispetto al (più) tardo Caproni, dopo Il muro della terra.
Chi scrive testi apertamente confessionali corre dei rischi (estetici: nulla di fatale, che io sappia), così come chi accetta e abbraccia gli slanci della poesia civile, che ancora più dei versi dell’io rischia di invecchiare male, o anche peggio, a causa della necessità temporale di intervenire subito in prima persona intorno alle grandi catastrofi del nostro tempo – almeno quelle che, per un motivo o per l’altro, stanno più vicine agli intorni ideologici delle nostre bolle mediatiche, e di cui i poeti si assumono la responsabilità di restituire un frammento attraverso una poesia civile: qualunque cosa possano essere, questo frammento e questa poesia. E qui la casistica contemporanea è ampia, per ragioni che a me sfuggono ma che non posso certo ignorare, vista la frequenza e la presenza di testi civili che attraversano l’immaterialità del web e poi finiscono in raccolte di versi, tanto delle piccole quanto delle grandi case editrici.
Eppure, proprio dove la convivenza formale e semantica sembra più innaturale – l’io che reclama il suo diritto al dettaglio, al corpo, all’umore; e la storia che reclama invece il suo tributo di urgenza civile e di presa di posizione – a volte la poesia fa quello che altrove non riesce: tiene insieme, senza creare però mediazioni nel centro, l’uno e il molteplice, in una dialettica tra le parti che non diventa mai sintesi né si arresta nella sua negatività, ma vive in questa spirale di movimento, di urti e di ritorni, tra l’interno e l’esterno, tra l’io e il mondo.
Tra gli esempi più riusciti di questa non facile coabitazione tra confessionale e civile c’è l’ultima raccolta di Patrizia Valduga, Lacrimae rerum, con la sua scansione di 59 testi più uno (Quasi un’appendice: un breve ma incisivo autocommento dell’autrice), per un’ideale raccolta di 60 componimenti che si presentano agli occhi del lettore senza partizioni paratestuali di alcun tipo, se non l’epigrafe con cui si apre la raccolta: “A chi ha fame e sete / di giustizia / dono / dedico / consacro” (più una data, “fine giugno 2025”, che si legge in basso a destra a pagina 61 nell’ultimo distico della raccolta). A meno che, giustamente, non si consideri la copertina della Bianca Einaudi come il primo testo della raccolta (poi di nuovo a p. 54): “Padroni della guerra e della morte, / che gestite patrimoni di morte / e fate investimenti sulla morte, cosa posso augurarvi se non morte?”. E dato che nemmeno Wittgenstein, nelle sue lezioni di estetica (1938), sapeva come leggere una poesia (“How should poetry be read? What is the correct way of reading it?”), rimaniamo così, in questo dubbio quasi matematico sui potenziali inizi e sulla fine di una raccolta: dove comincia davvero un libro di versi, e chi decide che cosa fa la poesia?
Non è che Valduga risponda, o si ponga esplicitamente, domande di questo tipo, ma la forma-libro che utilizza sembra andare in quella direzione. E se spesso l’unico appiglio, in casi sequenziali e aperti come questo, è proprio la materialità del libro – o meglio: la sua soglia –, allora è il titolo ad assumere un ruolo e una funzione programmatica, più che nominale: una specie di staging di ciò che la poesia può fare e della posizione che l’io va ad occupare all’interno di questo spazio fisico che chiamiamo libro di poesie.
L’Eneide, da cui Valduga trae il titolo latino del libro, è un libro di guerra, per di più postcoloniale (con un curioso cambio di paradigma tra vincitori e vinti, da Oriente a Occidente): all’inizio del primo libro, dopo il più che noto incipit canoro, Virgilio non perde tempo in troppi convenevoli e mette subito in scena questo fuggiasco, un profugus da Troia, nel viaggio guidato dagli dèi. E condere urbem (fondare la città), come si legge al verso 5, non è solo un atto fondativo, ma anche e soprattutto sostitutivo – un popolo al posto di un altro – per e attraverso la guerra. Enea uccide Turno nel dodicesimo libro e, per descriverne la fine, che altro non è se non l’inizio della nuova civiltà, Virgilio scrive: ferrum adverso sub pectore condit. Una chiusura ciclica (del resto, siamo pur sempre in un poema epico): affondare un’arma nel petto di un nemico e fondare la città sono atti equivalenti, simmetrici, necessari affinché si compia il destino degli dèi e del pio Enea.

Valduga sceglie l’empatia, per Enea (e non credo che sia l’unica, nel secondo Novecento, come ha ben dimostrato Laura Vallortigara nell’Epos impossibile): ci porta, alle soglie del testo, nel tempio di Giunone, mentre il futuro eroe – che ancora deve compiere il suo poema di formazione – guarda le pitture che hanno per oggetto la guerra di Troia; per catapultarci poi, in un distico di endecasillabi baciati a pagina 33, dove il calco latino non viene reso come parola straniera (compare in tondo): “Sunt lacrimae rerum… Piangi, Patrizia, / piangila l’ingiustizia, ogni ingiustizia!”.
Il mito non viene demitizzato (o addirittura estroflesso), reso meno sacro o meno epico, come buona parte della letteratura contemporanea ha fatto e continua a riproporre nel mare magnum delle riscritture del mito. Valduga non opera nemmeno una riscrittura: da osservatrice del mondo contemporaneo e, insieme, da lettrice di letteratura classica (insomma, da lontano, da quella posizione privilegiata che ha reso tutto l’Occidente immobile e responsabile: “il fracido Occidente è la fucina / di questa infamia di furia assassina”), riprende la postura dell’eroe sofferente, che ha subito l’ingiustizia e che, prima ancora di ripeterla ai danni degli altri, se la porta impressa addosso. E questa postura viene posta sullo stesso piano di chi, inerme, osserva in prima persona lo “sterminio che non trova fine” (p. 3): l’uccisione di decine di migliaia di palestinesi, indicata dall’autrice nell’appendice come esito dell’azione del governo di Israele.
All’esametro classico del verso epico Valduga oppone un endecasillabo declinato – e declinabile – in rima baciata, che conserva (o riprende, e insieme decostruisce) tanto il verso epico dell’antichità quanto quello narrativo della Commedia: il giambo, con la sua invettiva di biasimo e rimprovero (letteralmente, ψόγος). E un po’ come Archiloco nel celebre fr. 1 W (l’autopresentazione del poeta-soldato Archiloco, in un distico elegiaco, con cui si apre la lirica occidentale attorno a una soggettività esplicita(ta) – εἰμὶ δ᾿ ἐγὼ, “io sono”), Valduga si presenta più volte per nome, sdoppiandosi e triplicandosi (“Senza niente da perdere o da avere, / io mi sdoppio e mi striplo a mio piacere”, 8) per poi rimanere “sempre me stessa” (12); non si nasconde dietro una maschere (persona loquens) e lancia a più riprese versi al vetriolo e tipicamente giambici nella loro modalità enunciativa (“Ma vaffanculo!”, 4), rivolti ai nemici della pace (“Padroni della morte, spazzatura / del mondo”, 37) che usano la guerra come strumento di profitto (“è la vita il capitalo vero”, 9): “Qui ci snervano sempre con allarmi… / s’inventano un nemico e compran armi” (5).
Accanto, insieme e attraverso il mondo che ci accade dietro a uno schermo, l’io di Patrizia (Valduga) convive con l’altra parte di sé, quella più “egotista”, più “inconsistente”: un io che ha un corpo e dei desideri (del proprio corpo e di altri corpi) che cozzano contro il tempo storico di questa “indegna guerra” – di Israele, e “della mente” (29), come se le due componenti fossero entrambe vittima del mondo esterno e del tempo biologico: l’io che si sdoppia e si triplica vuole uscire da sé, da questa contraddizione del corpo e della mente che guarda al proprio corpo (“e mi decrepito… e a che velocità”), al tempo che le rimane (“qui”, “a Milano, capitale immorale”, 31), e insieme ai corpi delle vittime di Gaza che i media ci trasmettono (“martirio e morte di un popolo intero”, 51). Un io (ir)responsabile, per colpa e per grazia della propria incoerenza: sospeso tra il desiderio di vivere e quello – altrettanto impossibile da sostenere fino in fondo – di non vedere più morire gli innocenti.
L’ironia, forse più di Ipponatte che di Archiloco, non manca nemmeno nei giambi baciati di Valduga, e tocca tanto l’io confessionale – posto programmaticamente al centro di ogni enunciato – quanto il nemico dell’io (sé stessa, sì, ma soprattutto gli altri, tutti: “E qui? Qualche dissenso e un po’ di sdegno”). Patrizia e Raboni sono figure ricorrenti in questi frammenti di memoria, in queste lacrime delle cose che compaiono qua e là tra piedi arsi e tesi, insieme a un sentimento di stupore, di incredulità nei confronti di questa realtà distopica: “Possibile che accada per davvero? / È il sempre più impensabile pensiero” (57). O meglio: come possiamo far convivere i nostri desideri più privati con il peso degli anni che avanza e aumenta (delle “radici” e delle “cicatrici”, che l’io confessa di non aver mai nascosto, “perché non basta soltanto capire: le radici si devono… sentire!”, 21), nel segno della perdita e della consapevolezza di essere più vicina a una “scatola di legno” (39) che all’amore, a una nuova “amicizia amorosa” (18).
Nello stesso gesto metrico, nello stesso tono, nella stessa voce che si chiama per nome e, chiamandosi, si espone, convivono il confessionalismo aperto di Valduga – in quella disambiguazione sintattica che, più che in altre raccolte, rende nitidi oggetto e soggetto dell’enunciato – e, insieme, la tensione civile della poesia. Senza patetismi, né da un lato né dall’altro, e con la percezione (negativa, quasi programmatica) che tanto le parole dell’io, per sé, quanto quelle per Gaza siano in fondo inutili: fino a diventare indistinguibili e dunque superflue, come la parola morte, che, come un’eco, si moltiplica e si disperde nella quasi-identità semantica e fonetica delle rime con cui la raccolta si apre: morte, morte, morte, non morte. E così anche la fine coincide con una fuga: dell’io e delle sue parole, che si sfaldano in un congedo – “Va’ a Venezia, va’ a morire, Valduga!” (61) – e si disperdono, come se il libro non potesse chiudere davvero, ma solo lasciar andare, lasciarsi andare. Quasi morire: lontano dalla vita storica di Milano, verso l’isola distopica di Venezia e la sua ir-realtà.
Leggi anche
Marilena Renda | Tavoli| Patrizia Valduga