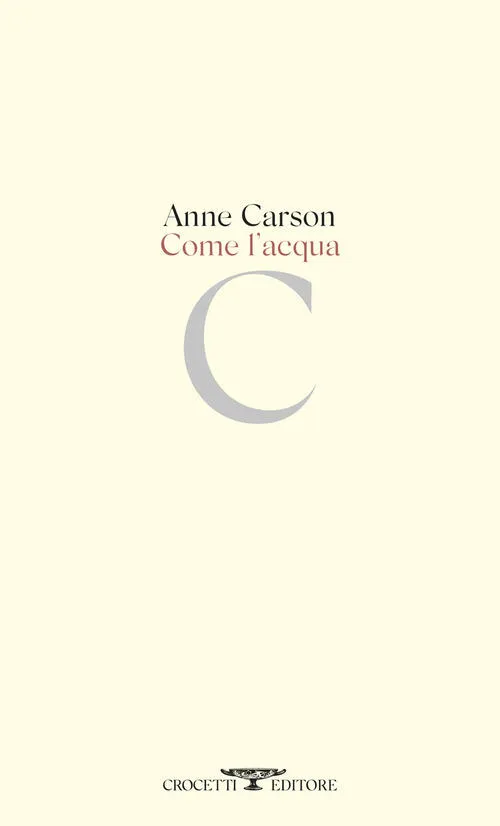Tutti figli di Ann Carson
In che direzione va la scrittura dell’iper-contemporaneo? Una buona risposta a questa domanda di rito potrebbe essere ‘verso Anne Carson’, e una migliore ancora “a partire da Anne Carson”. Entrambi gli orientamenti sembrano applicarsi, quasi per un principio di aderenza intenzionale, alla letteratura italiana, dato che tanto il piccolo quanto il grande pubblico continuano ad apprezzare l’opera liquida della scrittrice canadese, generando un curioso effetto a spirale tra lettura (dei curiosi) e imitazione (dei poeti), fino ai più (im)probabili processi di mimesis che i suoi testi sembrano innescare, consciamente o meno, in chi li legge – un contagio stilistico che attraversa i generi letterari, le tradizioni poetiche e persino le teorie che siamo abituati a utilizzare per vivisezionare i testi letterari.
‘Opera liquida’ non deve essere inteso qui come il più inflazionato dei sintagmi à la Bauman: Carson appartiene alla cultura postmoderna, ma la sua scrittura non assume mai la forma degli oggetti che accolgono i suoi versi, le sue prose oppure i suoi saggi; al contrario, Carson rifugge costantemente qualsiasi contenitore stilistico o formale, rifiutando senza esitazioni le etichette (anche sul piano professionale). Per questo, più che indugiare sui gradi di attrito statico e dinamico – e sui modi di uniformare il transito dei nostri corpi sulla superficie della letteratura – sposterei lo sguardo del lettore verso i confini marini della scrittura di Carson.
Fin dagli esordi saggistici – Eros the Bittersweet è del 1986 (una lunga e affannosa rielaborazione della tesi di dottorato discussa all’Università di Toronto nel 1981) – in Carson è già difficile tracciare un confine netto, per non dire formalmente efficace, tra poesia e prosa. Lo è ancora di più in Come l’acqua, bella ed intelligente traduzione di Plainwater (1995), uscita oggi sulla scia della “Carson-Renaissance” italiana per Crocetti (che insieme a Utopia editore ha introdotto e diffuso Anne Carson in Italia). Il volume arriva grazie al suo lettore e traduttore più attento, Patrizio Ceccagnoli, che restituisce alla poesia di Carson una presenza concreta: la riporta sugli scaffali – anche quelli più laterali e defilati, magari nascosti, nelle Feltrinelli della stazione o nei centri storici della provincia italiana – rendendo di nuovo visibile un libro ibrido come quello di Carson.
Ma in che senso “marini”? Perché, oggi, la letteratura va e riparte da Carson?
Perché la sua scrittura procede per coste (confini) e approdi (forme) provvisori: cambia di continuo formule prosodiche e sintattiche, accoglie nella poesia il racconto e nel racconto il saggio, unendo prosa e verso senza gerarchie assolute né scale di valore, o di genere. È, in questo senso, una lingua e un metodo che attraversa intenzionalmente l’acqua, scavando ai margini del linguaggio, tracciando nuove traiettorie temporali, per poi disperdersi negli effetti stessi di quella scavatura.
Le ragioni di questa operazione sono molteplici, o forse inesistenti; qui mi limito però a un’unità minima capace di tenere insieme questa pluralità “liquida” e la logica della letteratura – mai del tutto risolta, nemmeno da Käte Hamburger o da Hans Robert Jauss – tra una visione essenzialistica e una visione accidentale dei generi letterari.
Partiamo da una domanda tutt’altro che scontata: il verso e la prosa sono tratti distintivi che rispondono a una visione essenzialistica del mondo – e, rispettivamente, della poesia e della finzione – oppure sono pratiche culturali, o, con Klaus Hempfer, convenzioni sociali, attorno alle quali le scritture, dalle più tradizionali a quelle più sperimentali, si sono via via sedimentate fino a costituire, su scala nazionale e transculturale, quelle cornici “giurisdizionali” in cui i lettori (si) riconoscono (in) una poesia e un racconto?
Non saprei dire che cosa pensi Anne Carson, studiosa di letteratura e cultura classica – e, suo malgrado, filologa –, ma interrogarsi sulla scrittrice che abita il corpo della studiosa Carson mi sembra un’operazione ermeneutica meno azzardata, senza il bisogno di ricorrere a biografismi eccessivi né a letture storiciste (o di credere al valore assoluto, essenzialistico, delle forme).
I suoi testi, dalle prose liriche di Short Talks (1992) fino a Wrong Norma (2024), riflettono un’idea di letteratura e di scrittura come strutture liquide, dotate di un’autonomia irriducibile e non riconducibili né a schemi di matrice aristotelica (il mezzo, l’oggetto, il modo) né a categorie formali di ascendenza hegeliana (l’epica rappresenta la totalità del mondo esteriore, la lirica l’individualità del mondo interiore), che per secoli ne hanno circoscritto il campo d’azione e d’espressione. Del resto, come ci ricorda Franz Kafka – che Carson programmaticamente cita, dopo una serie di frammenti, nel saggio di apertura del libro, Mimnermo e i moti dell’edonismo –, il compito del poeta è “portare l’uomo isolato nell’infinito della vita, portare ciò che è contingente nel lecito” (43).
Ma è davvero questo il compito che si prefigge Carson?
Per avviare questo percorso verso l’infinito, Carson si rivolge ai suoi poeti classici: non però a Saffo, Pindaro o Archiloco, e nemmeno Simonide, bensì a Mimnermo – un elegiaco e, insieme, un lirico – come suo interlocutore privilegiato. È lui, letteralmente, a dialogare con Carson (I / io) in una intervista immaginaria, entro un tempo psicoanalitico in cui i due ’poeti’ si (s)confessano a vicenda, affrontando il problema della lingua e del linguaggio e il modo in cui l’antico e il contemporaneo guardano il mondo: per l’io, la “vista” del poeta è veicolo del “sapere”; per Mimnermo, invece, è la “cecità” a dare valore all’interpretazione del “reale”. E Carson? Quale postura adotta nella propria scrittura?
Le interviste (tra l’io, il sé dell’io e di Mimnermo) procedono con un ritmo piuttosto serrato (come le sticomitie della tragedia greca), senza che il botta e risposta, secondo la nozione postmoderna di dialogo (si pensi agli A e B di Giorgio Manganelli o al professor Y di Louis-Ferdinand Céline), approdi a una soluzione definitiva o a un reale scambio dialettico: non c’è, insomma, il desiderio reale di conoscersi, ma piuttosto di scambiarsi nozioni che colmano il tempo della conversazione. L’io riceve informazioni dal poeta greco e il poeta greco crede di riceverne dall’io; Lacan (per la logica del desiderio) e Freud (per la dinamica dell’inconscio) aleggiano sulle parole di entrambi, senza che il dispositivo conversazionale conduca a una sintesi o a una conoscenza effettiva – men che meno profonda – tra i due interlocutori: “I: Volevo conoscerla”. “M: Volevo molto di più” (71).
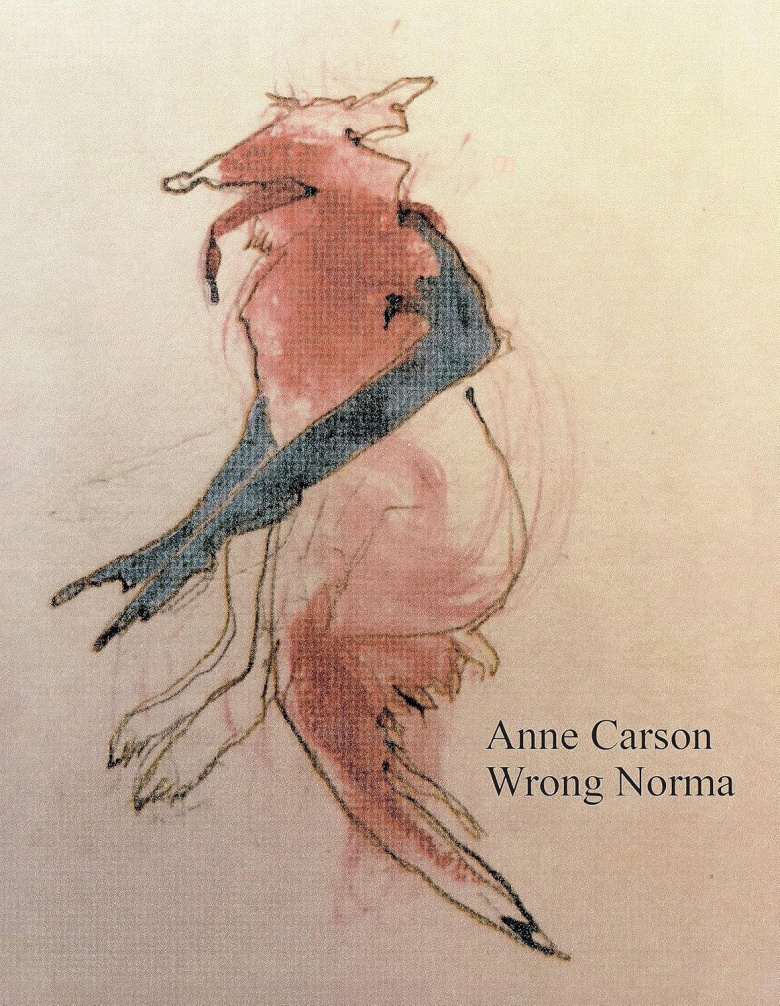
È l’acqua – con la sua antropologia estetica e anti-normativa – a imprimere alla parola questa in-consistenza materiale: inizio e fine, confini e limiti sono nozioni che Carson rifiuta apoditticamente e che, in qualche modo, rende del tutto assenti nei suoi mondi creativi. “L’acqua”, infatti, come leggiamo nell’introduzione alla sua Antropologia, “non si può trattenere. Come gli uomini. Ci ho provato. Padre, fratello, amante, amici sinceri, fantasmi affamati e Dio, uno dopo l’altro mi sono scivolati via dalle mani” (301).
Il paradigma dell’acqua, insieme oggetto e metodo di scrittura, occupa così una posizione centrale nella poetica di Carson: “I am to imitate a mirror like that of water”, si legge perentoriamente in The Glass-Essay (1995). Questo dispositivo imitativo – di ciò che è informe e, al tempo stesso, capace di assumere la forma di ogni cosa – consente al soggetto di emanciparsi da una dimensione puramente terrestre, e di ricongiungersi al suo stato (pre?)naturale, dove l’uno e il molteplice, l’io e l’altro sono presenze senza spazio e senza tempo, fuori dalla cultura del mondo tecnocratico e amministrativo: “la materia dipinta entro delle linee”, “l’illusione che in qualche modo le cose si tengano insieme, la mia pera, il tuo inverno” (223).
In questo senso, prosa e verso sono concepite come istituzioni culturali della città, della terraferma e di una visione antropocentrica che considera l’acqua e il suo mo(n)do subordinati all’uomo e alla terra (e ai loro mezzi canonici di rappresentazione: la scrittura e le sue forme simboliche – poesia, romanzo, saggio, teatro), e che ha cristallizzato tanto l’immaginario di chi scrive quanto quello di chi legge entro un binarismo tipicamente ‘orientale’ (io vs l’altro) o ‘occidentale’ (io vs non-io): “Una mattina presto le parole vennero a mancare. Prima di allora, le parole non esistevano. Esistevano i fatti, esistevano le facce” (75). E poco più avanti: “Iniziai a trascrivere tutto ciò che fu detto. Questi segni costruiscono gradualmente un istante della natura” (75).
Come nota Carson, questo processo creativo accade nel momento in cui chi scrive e percepisce il mondo esce dalla sfera dell’oralità – dall’immediata naturalezza dei codici comunicativi – per entrare in un sistema segnico stratificato, dove “non si sa mai abbastanza” e dove “non si lavora mai abbastanza” (75). Potrei, a questo punto, segnalare al lettore se le costruzioni sintattiche appena citate sono versi o brani in prosa, se appartengano a porzioni diverse di singole sezioni o se concorrano a una totalità che si espande progressivamente nel corso del volume. Non è questo il mio desiderio, né tantomeno quello di Carson: anche prendendo le poesie-frammento della prima sezione (22–39), i versi di Canicula di Anna (138–219), oppure i blocchi di prosa dei Discorsi brevi (74–138) e dell’Antropologia dell’acqua (299–448), ci troveremmo di fronte a strutture discorsive fatte di forme giustapposte, in cui elementi eterogenei – immagini, concetti, aneddoti, definizioni, fotografie, traduzioni – si susseguono senza soluzione di continuità, secondo una logica più associativa che paradigmatica.
L’acqua (la scrittura), come nelle peggiori tubature fuori norma, s’insinua nelle pareti del testo e lo incrosta, lasciando segni indelebili (e le relative forme di agency) che possiamo scegliere di riparare o occultare. Carson opta evidentemente per la seconda via: lascia che l’acqua scorra nei suoi testi, facendoli dilagare in una narratività quasi oceanica – si pensi alla lunga serie di poesie (1-53) che compongono Cosa abbiamo qui? – o, all’opposto, in una performatività icastica, delle sue prose brevi. In Tipi d’acqua, per esempio, registra, tra cronaca, diario e finzione, un saggio sul Cammino di Compostela scritto dal 20 giugno al 26 luglio di un anno sconosciuto; e tuttavia la prosa conclusiva di Finisterre è, inevitabilmente, senza data: “le parole non sono mai entrate in me” (372).
Il linguaggio, ancora prima della lingua, è il (s)oggetto della scrittura di Carson. Se l’acqua attraversa e plasma la sua opera, lo fa non come semplice figura tematica (l’acqua nella Milano di Milo De Angelis, l’acqua nella Berlino di Durs Grünbein, o la siccità nei paesaggi di Yves Bonnefoy), ma piuttosto come metafora del linguaggio stesso: un elemento corporale che non si lascia mai trattenere (“è possibile un superamento della soggettività”, 155), che muta stato e forma (“Modificare cosa?”, 191), e che abolisce la distinzione tra ciò che è solido e ciò che è fluido (“nelle ferite, / senza sangue”, 213). E come l’acqua, anche il linguaggio è una sostanza instabile, refrattaria alla forma poetica definitiva, fino a diventare un fluido pensante che fluttua, appunto, tra le forme storiche della letteratura, evitando però di coagularsi, cicatrizzarsi o cristallizzarsi in verso o in prosa: Water is something you cannot hold.
Ma proprio in questa fuga risiede la loro potenza: la parola, come l’acqua, è ciò che insieme unisce e separa i contorni delle cose, in attesa che assumano – agli occhi dei “tanti fenomenologi” (193) – una forma d’esperienza: “I segni ci vengono dati come voce nella carne, questa è la mia perplessità” (329); e insieme, la spinta della sua scrittura: una sorta di principio originario – quasi mistico, se messo a confronto con i progressi della tecnologia e la perenne reificazione delle nostre esistenze –, e inafferrabile, che fa e disfa il senso del nostro fluire (la vita biologica, racchiusa nei suoi atti fondativi: la vita e la morte, che Carson non sembra del tutto accettare in Come l’acqua: la demenza del padre, la depressione della madre).
Come l’acqua arriva forse in ritardo rispetto ai testi di Carson oggi disponibili in italiano, ma forse i tempi sono quelli giusti: i lavori ibridi di cui si compone questa raccolta consentono al lettore uno sguardo più consapevole—e in gran parte retrospettivo—su Economia dell’imperduto (1999 / 2020), Eros il dolceamaro (1986 / 2021), Vetro, ironia e Dio (1995 / 2023), Autobiografia del rosso (1998 / 2020), La norma sbagliata (2024 / 2025) e Decreazione (2005 / 2023), e di entrare così nel laboratorio liquido di Carson: in quel linguaggio che, un po’ come il suo lavoro di traduzione dal greco antico, è una costante riscrittura della parola attraverso la trasparenza e la densità dell’acqua – un “essere / fatto di suoni grezzi / uniti a monconi / e che si muovono / come una sola forma / laggiù” (193-195).
Leggi anche
Marilena Renda, Anne Carson e la bellezza del marito
Isabella Pasqualetto, Anne Carson, economia dell'imperduto
Alberto Comparini, Io è come leghiamo le cose