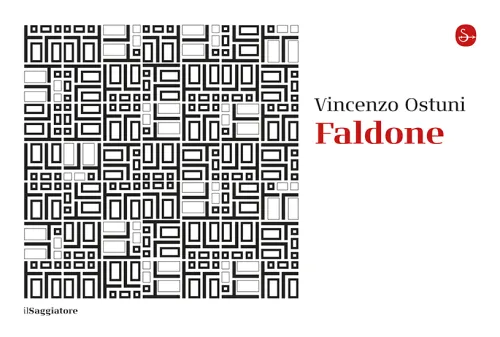Ostuni: il Faldone del nostro tempo
The Winter voice adjusts: “As I was saying
(before I was so rudely interrupted),
we don’t have to go downstairs and get the plants.
Some of them, at least, are already here.”
John Ashbery, Moon, Moon
Il Faldone di Vincenzo Ostuni è un libro che farà venire il mal di testa – ai lettori di poesia e agli aspiranti poeti (spesso le due figure coincidono; e quasi sempre, come vuole la norma, hanno un dottorato in letteratura); a chi si occupa di stilistica (e metrica: auguri) e a chi si occupa di filologia d’autore (e anche qui, i dolori non mancano). Paradossalmente, per chi invece si occupa di teoria della poesia, il Faldone è un libro che, più semplicemente, allargherà i confini della letteratura contemporanea. Ma proviamo a fare un po’ di ordine, in questa lista di categorie astratte (i lettori e i filologi), esperienze di poesia (i cosiddetti wanna be poets) e approcci al genere lirico (i teorici della poesia).
Il Faldone è un ipertesto (elettronico e cartaceo) che il 25 marzo 2025 è diventato finalmente un libro stampato dall’editore milanese il Saggiatore (di nuovo, dopo l’edizione provvisoria del 2019), e conta, in questa attuale versione, 761 pagine, cui si devono aggiungere, in coda, una breve nota dell’autore sulla composizione del libro (763-4) e, devo dire, un bel saggio di Luigi Severi (765-94).
Leggere un testo di queste dimensioni non è affatto un esercizio semplice, a tratti sembra pure impossibile, ma trovare un filologo che vada a studiare le varianti tra tutte le versioni che Ostuni ha scritto, pubblicato, reso disponibili in vari formati, del suo Faldone, credo che sia ancora più improbabile. Certo, basta anche solo aver bazzicato per errore i sacri recinti della filologia, rimanendo alle sue periferie (da pagano, sono rimasto fuori dal tempio), per essere al corrente dell’esistenza di un team guidato da Paolo Trovato che ha curato l’edizione critica della Commedia di Dante studiando tutti i manoscritti che comprendevano le tre cantiche (600, se la memoria non mi inganna); come esistono anche i filologi delle opere di Ralph Waldo Emerson (con i famosi sei volumi dei diari) e di Martin Heidegger (siamo a 102 volumi, and counting, dato che dopo la scomparsa di Friedrich-Wilhelm von Herrmann gli studi(osi) heideggeriani hanno visto l’ascesa di Peter Trawny, ma non dell’enfant prodige Markus Gabriel); in Italia, Franz Kafka e Thomas Mann stanno subendo una nuova vivisezione traduttoria e filologica per le cure (molto affidabili, e acuminate) di Luca Crescenzi; e, ipertestualmente, chi più ne ha, più ne metta.
Insomma, sulla carta nulla impedisce che un’operazione quantitativa di questo genere si verifichi anche per Ostuni – chi volesse studiare questo “libro di poesie che evolve nel tempo e viene continuamente ampliato e rimaneggiato” secondo un taglio filologico, troverà nel sito tutto il necessario per procedere in questa direzione d’autore (sia chiaro: ambasciatore non porta pena).
Ostuni non è Dante, né Heidegger – c’è qualcosa di emersoniano nella sua scrittura, ma non è di certo il nuovo Emerson, né tantomeno assomiglia o vuole assomigliare a Kafka e Mann. Ostuni (che personalmente non conosco), mi verrebbe da dire che non è nemmeno (più) Vincenzo Ostuni: ora (?) è il suo Faldone. Per due ragioni: un’opera di questo genere, monumentale per la sua volontaria e frontale rottura di ogni forma e parametro della poesia (italiana) contemporanea, comporta anche la morte paratestuale dell’autore. E proprio per questo regime di monumentalità, nel Faldone c’è anche, benché frammentario, frammentato, scheggiato, reso opaco e allo stesso tempo autoevidente, Vincenzo Ostuni.
Bene, ora che abbiamo messo da parte la massa dell’autore, possiamo prendere atto, invece, del peso del libro. E la quarta di copertina, come ogni parte di questo testo, ne restituisce già il peso simbolico, dato che voci critiche come quelle di Laura Pugno, Gabriele Frasca, Gabriele Pedullà, Marco Giovenale e Andrea Cortellessa non sono noti, nemmeno nei loro gruppi più ristretti, a lasciarsi scappare blurb di questo tipo: in ordine di apparizione, Ostuni “svela”; la sua opera “rimugina il mondo”, “non ti lascia più”; è “ultra-aperta” con una “pretesa luciferina”. Un cast importante, eterogeneo e poco legato tra loro (con qualche piccola interferenza, ma rimangono gruppi a sé, come delle monadi che ascoltano la voce degli altri), che ci riporta, con un carico di aspettative particolarmente elevato, alla copertina del libro.
Il faldone è, letteralmente, una grossa cartella nella quale raccogliere scritti o documenti: sistema chiuso e insieme aperto, destinato all’accumulo seriale di un mondo pre-binario, che mescola il virtuale con la materialità dei corpi e della carta – un po’ come fa anche il sito dell’autore, che tende a combinare, con una grafica anni Novanta, il mondo digitale con quello cartaceo, attraverso il suo privato Faldone. Un archivio della vita (1992-2024, anche se “l’esergo dell’intero volume e di ogni suo precedente estratto risale al 1975”, 764), ma anche un metodo: il faldone non è solo un contenitore – che di base si trova in luoghi accessibili ai pochi (gli archivi delle biblioteche, pubbliche o d’autore), o meglio, ai soli interessati – ma è anche uno sguardo sul mondo: è un oggetto che dispone le “immondizie d’Occidente” (16) secondo un principio di serialità progressiva e numerica (Faldone 1- Faldone 99, con un numero variabile di testi – alcuni faldoni sono vuoti, altri hanno foto o appunti) che solo in apparenza produce un regime lineare.
In primo luogo, perché il Faldone si deve (può?) leggere come un calendario: non da sinistra a destra, ma dall’alto verso il basso; e ci chiede, a suo modo, di cambiare punto di vista, di concepire l’orizzontalità della serie e della progressione degli eventi (la poesia, diceva Robert Lowell, è un evento, e questo è un libro di eventi) in termini verticali. E la verticalità, della parola, del linguaggio e della sua materia, è probabilmente il tratto distintivo del libro (anche se sul piano visivo la pagina è orizzontalmente occupata da un verso, da un lungo periodare dialogico, spesso perifrastico). In seconda battuta, perché nessuno, auspicabilmente, accede a un archivio per leggere tutte le carte di Eugenio Montale (o forse sì?) a Pavia o per leggere tutte le annotazioni che Guido Morselli lasciava sui libri che consultava alla Biblioteca Civica di Varese (ci ho provato, lo ammetto): di solito, negli archivi, si consultano i faldoni degli autori che ci interessano per ricavare delle informazioni utili, di servizio, per dare un senso compiuto a un insieme (la poesia di Montale, la prosa saggistica di Morselli) che di base sembra sfuggente e inarrivabile (capire la poesia di Montale, descrivere la prosa saggistica di Morselli). C’est à dire: il Faldone è un libro da scoprire attraverso una lettura non sistematica, o quantomeno non canonica, come non sono canonici la scrittura e la forma del libro di Ostuni.

Ma qui, per proseguire la lunga lista di paradossi, l’indice dell’archivio è assente, o incompleto, e chi vuole leggere Ostuni dovrà affidarsi alla cabala: faldone 1, faldone 2, faldone 3, faldone 4, et alii (anche se poi, andando a leggere effettivamente il libro, i titoli sono più descrittivi: Faldone 64 Studi per le filastrocche, oppure Faldone 44 Immagini malgrado tutto). Oppure credere che dietro la dialettica negativa tra l’uno e il molteplice si celi, invece, un principio evolutivo che se non è hegeliano, gli assomiglia molto.
Io non credo in nulla, però credo che questo sia un libro di poesie (o accetto il patto formale che Ostuni fa, in rete, con i suoi lettori: “Il Faldone è un libro di poesie”), e credo anche che un buon modo per capire cosa fanno i libri di poesie sia leggere l’ultimo testo (le poesie incipitarie, dal fr. 1 V di Saffo al Che cosa si può usare di Ostuni, continuano a essere programmaticamente paratestuali). Il faldone novantanove non si chiama faldone, ma novantanove, e diversamente da altri faldoni ha due testi numerati non consecutivamente (0. e 0.) e, credo, sono gli unici che hanno il testo posto fuori dalla parentesi (761):
0.
(«»). Fuori?
0. Se ti piacciono queste regole, usale come vuoi.
Il Faldone è un libro parentetico: dentro c’è letteralmente di tutto (gli unici oggetti certi che mi sento di riconoscere senza il rischio di incorrere in brutte figure sono le epigrafi – per i miei gusti, troppe – e le fotografie), anche uno schema sulle relazioni concettuali (Faldone 90) che si dispiega in maniera grafica con delle frecce che legano vari concetti (dal limite fino alla cancellazione) da p. 713 a p. 721. Ma tutta questa testualità, qualunque cosa sia, è scritta tra parentesi, tranne nei testi 0. e 0. del faldone 99.
Si può dire qualcosa tra parentesi? La risposta di Ostuni è in corsivo, posta temporalmente al grado zero, come la domanda precedente; e l’invito dell’autore è di usare queste regole a proprio piacimento. Non so se leggere questa definizione in chiave pragmatica o operativa, ma in entrambi i casi l’invito (fuori dalle parentesi) è di usare il Faldone a proprio uso e consumo – s’ei piace ei lice, direbbe Tasso.
Ora, l’ultimo testo, vuoi per la sua brevità, vuoi per la sua eccentricità rispetto all’insieme, e vuoi per la dimensione pragmatica o operativa attorno a cui si chiude il libro, rimarca ulteriormente i due tratti formali del libro: la dimensione parentetica e quella dialogica.
Le parentesi, come ci insegna Luca Cignetti, sono un segno pragmatico di eterogeneità enunciativa, il cui uso è estraneamente variabile di cultura in cultura (in inglese si preferiscono gli hyphens, non i dashes, alle parentesi) e particolarmente sconsigliato dalle grammatiche nazionali, a meno che il linguaggio settoriale che stiamo utilizzando (il linguaggio matematico, per esempio) non ne richiesta l’uso: tutti, o quasi, sappiamo come svolgere questo tipo di operazione, 3+5 * (6-4), e anche i decostruzionisti più fedeli a Derrida riconosceranno la funzione operativa delle parentesi (che altro non fanno che assegnare un ordine alle operazioni, in matematica).
La Recherche di Proust, però, fa un uso abbondante delle parentesi (lineari e non lineari), e anche dei trattini a essere più precisi (cfr. Isabelle Serça, Les Coutures apparentes de la Recherche, 2010), e nel Seme del piangere di Giorgio Caproni, Anna Picchi sembra davvero “ancora viva tra i vivi”, tra parentesi. Eppure, così vogliono le norme morfosintattiche delle lingue moderne, l’uso delle parentesi deve essere parco nella scrittura, perché, in fin dei conti, le parentesi “introducono una discontinuità enunciativa dai caratteristici effetti polifonici”; e ancora, sempre nella lettura di Cignetti, “ogni sequenza di testo o di segni tra parentesi deve tuttavia essere sempre espletiva, ossia poter esser rimossa senza che la frase restante risulti sintatticamente danneggiata”.
Occupandomi, a tempo perso, dei rapporti tra poesia lirica e parentesi, ho notato due cose: che non se ne parla quasi mai (e spesso, in maniera del tutto a-critica) in poesia, mentre per la prosa ci sono varie monografie dedicate a questo argomento; e che i poeti del Novecento ne fanno un uso eccessivo (quasi depistante, come accade in tutta la produzione di John Ashbery), in termini sia visuali (E.E. Cummings), sia performativi (Paul Celan).
Ostuni ha deciso di parlare in versi tra parentesi, di costruire un intero archivio cartaceo e digitale, secondo una modalità enunciativa che crea forme di discontinuità rispetto al corpo del discorso principale e che è, ontologicamente (culturalmente?), espletiva. Seguendo questa lettura, e impersonando i panni di uno storico della lingua italiana, sarebbe interessante fare un esercizio di rimozione, e in tal caso, dell’intero libro rimarrebbero solo la dedica alla figlia, le epigrafi, le fotografie, e l’ultimo faldone.
Ma Ostuni non solo ha creato un libro, ma anche una lingua adatta per/a questo libro: parentetica e dialogica. Le parentesi sono uno spazio fisico, materiale, non-semantico, dove si possono attivare i meccanismi enunciativi della poesia – una voce, che di base non è materiale, diventa soggetto enunciativo tra parentesi insieme ad altre voci, e dunque ad altri soggetti, che prendono parola e attivano il proprio corpo parentetico nel Faldone, tra parentesi e tra caporali bassi. Più che utter, allora, i soggetti speak: non si limitano a pronunciare un enunciato isolato, ma si espongono sul piano comunicativo attraverso un dialogo, costituendosi come voce nell’atto stesso dell’enunciazione.
Per esperienza, per lo più in-diretta, ho notato che nel linguaggio quotidiano scritto (whatsapp e facebook: sono nato nel 1988), le persone usano le parentesi per dire qualcosa sottovoce (lo fa anche Celan, leggendo le proprie poesie; lo dice anche Montale, commentando un suo famoso mottetto) – qualcosa di cui sono estremamente convinti e che vogliono comunicare all’altro, e che per farlo, per non esporsi troppo e direttamente (ma dall’altra parte dello schermo, la persona conosce meccanismo, lo accetta e accetta la maschera del gioco – spesso seduttivo), usa le parentesi tonde per separare la propria parola dal mondo (dal suo giudizio), e per ricevere una patente di libertà espressiva; tra parentesi, infatti, possiamo cambiare il tono della voce, e spesso lo abbassiamo per dire qualcosa di importante all’interno di un sistema relazionale (io-tu, io-noi, io-mondo). Si tratta di una scelta enunciativa, che offre una determinata immagine del soggetto di enunciazione e del suo modo di agire sul piano linguistico con chi abita il suo spazio comunicativo: il Faldone è, in questo senso, un’orchestra di voci a cui l’autore ha dato pieni poteri enunciativi, senza limiti formali o contenutistici.
L’espressione “romanzi massimalista” è da qualche anno molto abusata, e la tenuta formale del discorso massimalista tiene e non tiene (ma io non ho fede filologica né formale), ma oggi per dire qualsiasi cosa in qualunque modo abbiamo una forma simbolica piuttosto consolidato (il romanzo moderno), uno stile (la prosa enciclopedica e l’intermedialità semiotica), e dei modelli noti (Proust e Joyce, più i loro epigoni iper-contemporanei).
Ostuni, però, ha scelto la poesia come forma simbolica e la parentesi come tratto stilistico, enunciativo e semiotico: dentro le parentesi, e non fuori (la dedica, le epigrafi, le fotografie, la nota di commento, il saggio di Severi), l’autore può esprimersi come crede, affrontando in maniera plurale, discorsiva e conflittuale (l’interazione con le varie posture del soggetto enunciativo è agonistica), qualsiasi argomento. Lo spazio materiale sicuramente gioca a favore dell’intenzionalità discorsiva della raccolta, ma è il modo in cui Ostuni usa questo spazio, cambiando la prospettiva dell’insieme (verticale, non necessariamente progressiva) e l’idea che abbiamo della poesia (polifonica, non più monologica), che è possibile fare quello che fanno i saggisti e i romanzieri, in versi.
Ma il Faldone rimane un libro di poesia, e non diventa mai un saggio o un romanzo. E non perché il verso è un verso, e non un periodo sintattico (anche se la sua sintassi ammicca più alle forme della prosa che a quella della poesia), ma perché ogni testo, e ogni suo faldone, rimangono una tessera lirica del libro (un evento linguistico in mezzo ad altri eventi linguistici, legati dalla matrice archivistica del faldone), senza aderire programmaticamente alle strutture diegetiche (temporalmente narrative) del romanzo, né alla programmaticità analitico-argomentativa del saggio.
E, alla fine, è un invito a entrare nel mondo del Faldone: a leggerlo, liberamente, muovendosi, tra le sue temporalità asincrone, in uno spazio tematico che tocca e (af)fonda ogni aspetto del contemporaneo. Ogni pagina diventa così un tempo a sé, dove possiamo fermarci e scoprire qualcosa del nostro ampio presente, e scoprirci come parte integrante di questo ipertesto (e di questo mondo, if any).
Chiudo, così, nel modo in cui ho letto – e nel modo in cui credo vada letto il Faldone – questo libro nelle ultime settimane, aprendo, ogni giorno, a caso una sua pagina: “(«Porta via Storia, o destino, tutti quanti – lascia a qualcuno i nostri resti e spiega / che cosa ci sopravvive, che cosa c’identifica, ci nega»).” (309).