Conoscete Sebald poeta?
Se c’è uno scrittore che ha saputo incarnare l’ambivalenza o la duplice accezione del termine Dichter, questo è certamente W.G. Sebald. Se, infatti, Dichtung indica sia poesia sia letteratura (ma questo già in Aristotele, dove la poesia era la letteratura), Dichter designa al tempo stesso il poeta e lo scrittore. Certo, in tedesco non mancano le varianti: Schriftsteller – letteralmente, colui che mette per iscritto qualcosa – è lo scrittore in senso generale, mentre Erzähler – meno romantico, come termine: dal verbo erzählen, che significa ‘raccontare,’ ‘narrare’ – si riferisce più precisamente al narratore. Eppure, in un modo o nell’altro, Sebald è (stato) tutto questo: poeta, scrittore, saggista e narratore.
Sarebbe tuttavia difficile e riduttivo ricondurre la sua opera, per sua natura indefinibile, a una sola di queste categorie. Sebald, infatti, è riuscito nell’ardua impresa di essere il poeta che Platone non avrebbe mai cacciato dalla città ideale: lirico e civile, senza cadere nel patetico; sperimentale e innovativo, senza eccedere nella ricerca ossessiva di una nuova forma; visivo e verbale, senza aver aderito a una rigida scuola di pensiero.
Non (ci?) sorprende quindi che nel 2003 sia uscito, in tedesco, un volume che racchiude, interamente, la complessità semantica della vita artistica di Sebald, quasi a voler suggellare e, insieme, sospendere i molti fronti critici (spesso conflittuali) aperti intorno alla sua opera: Unerzählt – “inenarrato”, come traducono i germanisti italiani (Unrecounted, nella versione inglese tradotta da Michael Hamburger), è il titolo, postumo ma autoriale, di una raccolta di 33 poesie dell’autore e di 33 litografie del pittore Jan Peter Tripp, e di 2 poesie di Hans Magnus Enzensberger. “33 brevi testi per accompagnare 33 coppie di occhi. Ne è nato un lascito molto erratico, tanto erratico quanto la morte prematura di Sebald, avvenuta un anno fa. Erratico come le vite dei senzatetto e dei perdenti tedeschi di cui ci ha riportato i racconti nelle sue storie. Erratico come era lui stesso”, si leggeva sulle pagine del quotidiano Die Welt all’uscita del libro.
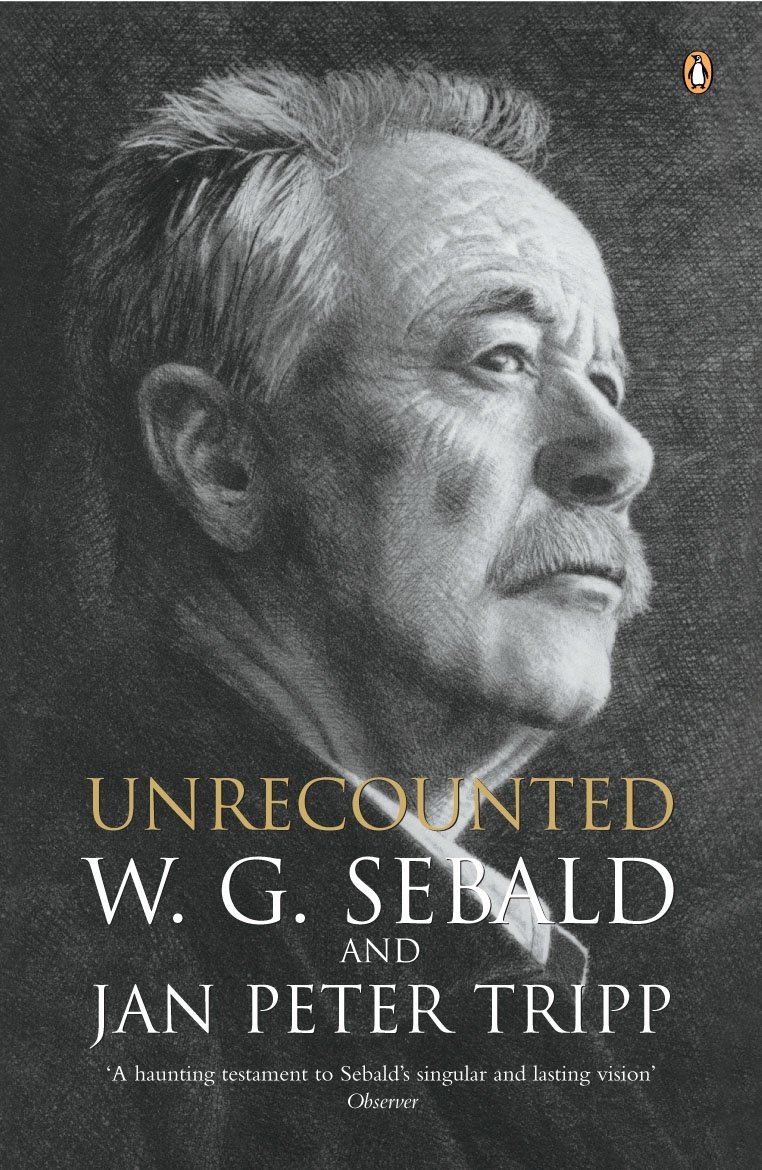
Basta leggere Austerlitz o Gli anelli di Saturno per trovarci di fronte a un poeta che scrive prosa, o leggere Secondo natura per trovarci di fronte a un narratore che scrive poesia. Nella sua breve e intensa carriera di scrittore, interrottasi tragicamente a 57 anni a causa di un incidente stradale (o meglio: di un attacco di cuore che lo portò a perdere il controllo del veicolo) nei pressi di Norwich, nel dicembre del 2001, Sebald ha attraversato senza soluzione di continuità il dominio della poesia e quello della prosa, costruendo in parallelo un intreccio che, come nei suoi romanzi, era privo di un plot definito e poco canonico rispetto a ciò che tanto il lettore comune quanto quello più esperto si aspetterebbero da un testo narrativo.
Ben diverso, invece, è l’apparato poetico (o meglio: lirico) di Sebald, che costituisce il nucleo fondante della sua opera, come se la narrativa fosse, in dei conti, il secondo mestiere. Fin dal suo esordio assoluto, infatti, Sebald si è presentato al grande pubblico come poeta, con Secondo natura. Un poema degli elementi (Nach der Natur. Ein Elementargedicht, 1988), un libro in cui già si intravedono i tratti distintivi della sua scrittura: l’attenzione alla memoria, alle rovine della storia e alla fragilità dell’esistenza, il problema del tempo, il lutto e l’identità, la colpa e lo sradicamento.
Ma la poesia – sia essa lirica, narrativa, anti-lirica o, per usare categorie forse improprie ma più familiari al pubblico italiano, come poesia in prosa o prosa in prosa – è soprattutto ciò che ha accompagnato Sebald per tutta la vita, come testimonia il volume Über das Land und das Wasser, uscito postumo nel 2008, che raccoglie poesie scritte tra il 1964 e il 2001, alcune delle quali già pubblicate in vita (tranne quelle uscite in Secondo natura e Unerzählt), cui si aggiungono quindici componimenti inediti conservati al Deutsches Literaturarchiv di Marbach. E che ora è finalmente disponibile in lingua italiana nella bella traduzione di Ada Vigliani (per Adelphi): Sulla terra e sull’acqua. Poesie scelte (1964-2001).
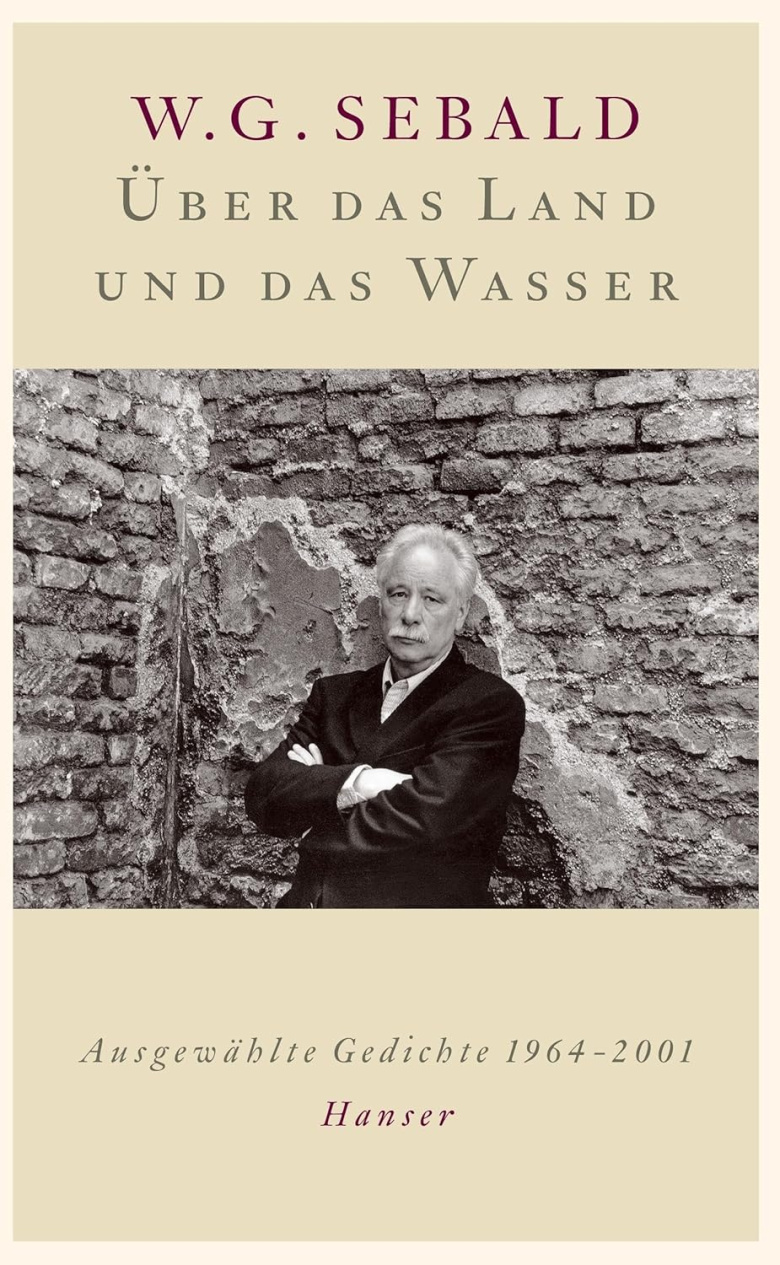
Il libro si compone di tre sezioni – Latinetti, Sulla terra e sull’acqua, Due anni or sono – ed è accompagnato da una utile nota critica di Sven Mayer (Ritratto involontario. Il poeta W.G. Sebald), e da un breve apparato di note e fonti che dovrebbe quantomeno ovviare all’assenza del testo tedesco a fronte – unico vero difetto di questa nuova edizione delle poesie di Sebald.
Il dato linguistico non è affatto un problema secondario: il poeta è, etimologicamente, colui che crea – quale che sia la sua base di partenza (il nulla, la materia, l’estasi) resta una crux attorno alla quale il fronte di guerra tra filosofi del linguaggio e storici della filosofia dibatte tuttora, tra trincee metodologiche e inespugnabili torre d’avorio accademiche. Che poi, linguisticamente, la poesia abbia a che fare con la creazione laica di un mondo storico è già un buon punto di partenza per capire cosa faccia la poesia (a way of happening, a mouth, diceva Auden, parlando di Yeats), e soprattutto per capire cosa (ci) fa Sebald con la poesia, anche quando non abbiamo davanti (a fronte) i segni grafici originali.
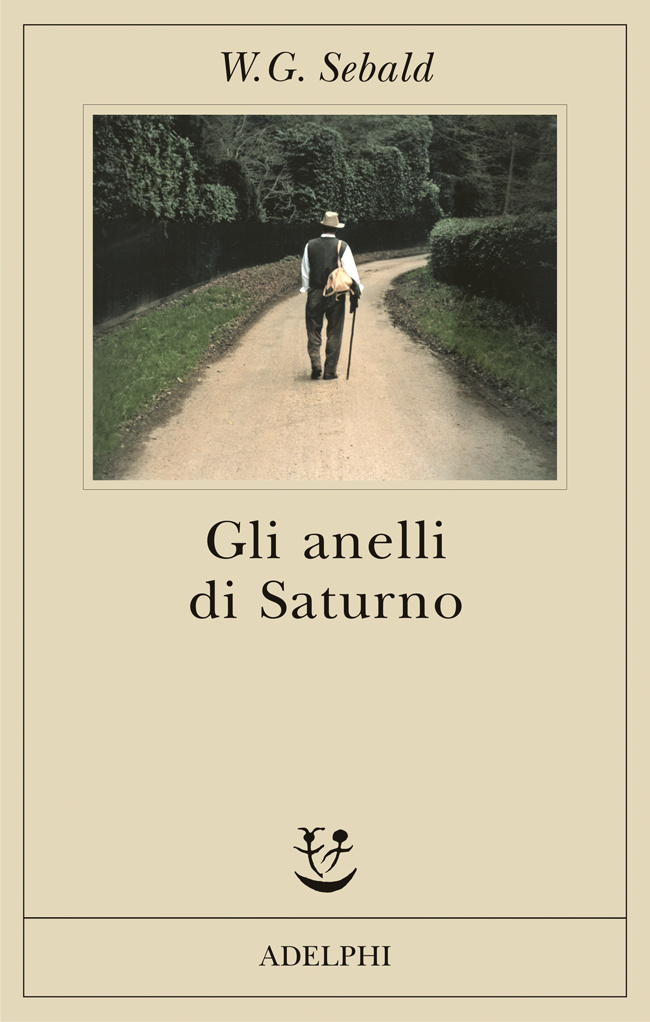
Ma senza addentrarsi in questioni troppo astratte (o problematiche), Sebald, come i suoi personaggi – narrativi e poetici –, ha passato la propria vita a sperimentare linguaggi diversi (dal visivo al verbale). La sua lingua si muove necessariamente in un nucleo germanico tra l’inglese e il tedesco, si nutre costantemente di questa incertezza, un po’ come la vita di Austerlitz, che era animata dalla perfetta consapevolezza di essere se stesso come un altro (come avrebbe detto Paul Ricœur, se avesse avuto il desiderio di scrivere di Austerlitz).
La raccolta procede secondo un ordine cronologico, in un arco temporale che va verosimilmente dagli anni universitari di Manchester fino alla morte dell’autore, e procede incessantemente come la sua punteggiatura (parca, quasi assente, e quando presente sembra non necessaria), suggerendo un flusso continuo di pensiero e percezione, e una incessante interrogazione di sé e del mondo.
Se il ritratto – una sorta di moderno idillio senza soggetto, che qui possiamo definire come un fotografo: “Stampati in fotocomposizione / gli spazi bianchi del mio atlante storico”, leggiamo in Inesplorato, l’ultimo testo della prima sezione – caratterizza la prima stazione di Sebald, la seconda e la terza parte del libro sembrano invece avvicinarsi maggiormente al modulo narrativo di Secondo natura (e ai suoi tre tempi); non tanto per la costruzione o la progressione di una storia, dotata sì di tempo narrativo ma priva dei suoi dispositivi più marcati (ossia i nessi logico-causali: la poesia happens, per riprendere Auden, senza che qualcosa scateni necessariamente il salto da un evento all’altro), quanto per la lunghezza e la disposizione grafica dei testi, e per gli inevitabili rimandi (ex post) o anticipazioni (ex ante) a ciò che Sebald avrebbe (ha) scritto nei suoi racconti o romanzi.
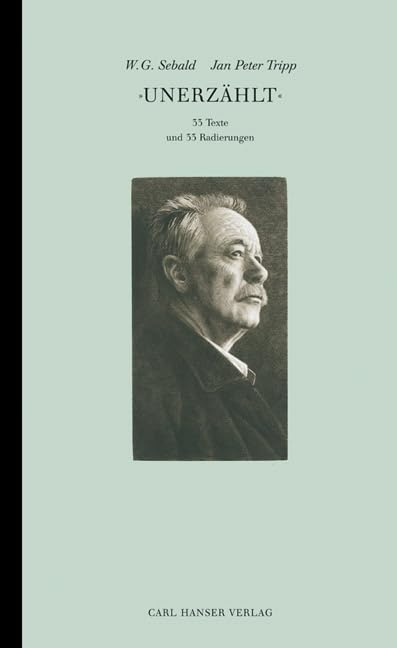
Nel 2008 Mayer scriveva che un’edizione critica delle opere di Sebald è in corso d’opera – chi ama le varianti, gli esercizî di filologia e la de-costruzione dell’autore che lavori di questo tipo comportano (di chi è questo libro? di Sebald o di Mayer? il genitivo è soggettivo o oggettivo?), tra qualche anno troverà le risposte che cerca (ma le note al testo in parte soddisfano la nostra esigenza fisiologica di sapere tutto, di Sebald). A questa altezza, però, possiamo ragionare in termini interdiscorsivi e intertestuali, per usare le categorie testuali di un filologo che si occupava di ermeneutica del testo attraverso gli strumenti della semiotica, per entrare nel laboratorio di uno scrittore che mescolava continuamente poesia e prosa, vita e finzione, collocando in maniera del tutto obliqua gli elementi centrali della propria poetica ora in un verso senza metro, ora in un periodo sintattico in prosa senza punteggiatura.
È così, credo, che possiamo entrare nell’“abisso dell’infanzia” della poesia, in Treno freddo:
In mezzo a madri
tedesche e figli chiamati
alla leva con la Bundesbahn
verso casa. Sbilenca la
torretta prima di Landsberg
il delitto all’Hotel Hahn
il caseificio a Buchloe
i pazzi di Kaufbeuren
le finestre della scuola conventuale
l’abisso dell’infanzia
E nell’oscurità
santa Elisabetta
le gonne sollevate
che cauta avanza
sui vomeri ardenti
In Secondo natura ritroveremo interamente la terza strofe, mentre nelle prime due ci troviamo, paradossalmente, in un territorio di mezzo tra Gli emigrati e Austerlitz, tra la Storia pubblica della Germania e quella privata dell’omonimo personaggio dell’ultimo romanzo di Sebald: la seconda guerra mondiale, lo spettro di Hitler e dei campi, il tema della giustizia e della colpa – insomma, tra l’abisso della storia e dell’inconscio, tra ciò che rimane inenarrato e ciò che emerge nella superficie della parola, non appena il mondo fisico (la topografia, l’urbanistica, l’onomastica: la Storia che prende forma attraverso i suoi simboli materiali) entra nell’orizzonte visivo del soggetto, sia esso lirico, narrativo, o che vesta gli abiti dell’osservatore o del fotografo degli eventi.
Le note al testo e la memoria del lettore possono facilmente allargare questo spazio intertestuale. Ma qui il punto è un altro: Sebald non costruisce materiali preparatori per i suoi racconti o romanzi, bensì desidera attraversare lo spazio che il verso o una frase possono offrire per liegen, per appoggiare su un materiale fisico il flusso discontinuo della sua memoria. In questo senso, essere sulla terra e sull’acqua, come recita il titolo della raccolta, indica precisamene questa duplice dinamica, tra ciò che può essere afferrato e delimitato attorno a un confine stabile (lo spazio) e ciò che invece sfugge continuamente al nostro tentativo di legarci a qualcosa di definitivo (il tempo). Ogni ritratto, che siano Ricordi di un viaggio a Bruxelles, la Baviera, Norfolk, Gerusalemme o il 9 giugno 1904 – tutto compare sull’atlante dell’inesplorato –, è così destinato a finire Nell’insonne ricordo delle “ombre / dei migranti”.
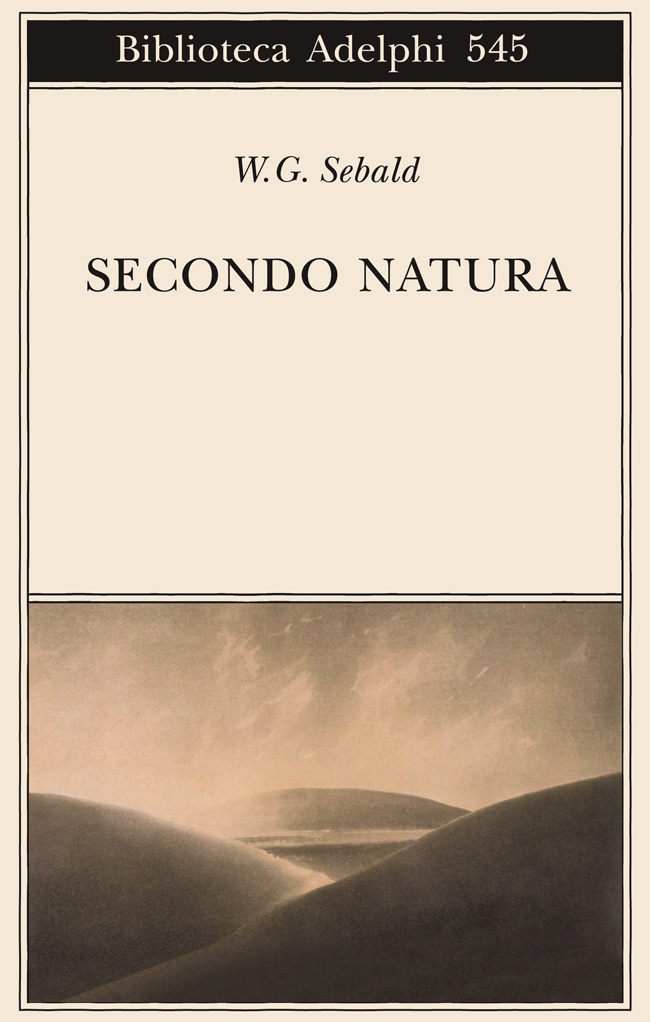
Prendiamo una strofa di Day Return, dalla seconda sezione del libro:
Who knows the noises
made by the animals
in Romford at night
and who will teach
the King’s starling
to whistle a new song
Capita, non di rado, di imbatterci in questi noises, l’inglese e il tedesco (per noi, l’inglese e l’italiano) di cui non si conosce esattamente l’origine; sappiamo che si mescolano, in Sebald, senza che l’apparato grafico debba distinguere una lingua dall’altra attraverso l’uso del corsivo, e che ciclicamente questi rumori possono diventare suoni (quindi, ripetibili), come una nuova canzone.
La poesia, come il romanzo – insomma: la letteratura –, parla più lingue. Ma se nella narrativa di Sebald il plurilinguismo serviva a restituire la mimesi del parlato e una forma di aderenza al tempo storico della vita e della finzione, nei suoi versi l’inglese e il tedesco riflettono la vertigine del presente il cui l’io e il lettore si trovano a convivere con i suoni e i rumori del mondo.
Ma c’è di più, nei versi di Sebald: “sono giunto da molto lontano / e penso d’essere morto //
Open these pages, he says, and step smartly into hell”. La poesia, per Sebald, esprime la sua (in)capacità di coniugare e di abitare simultaneamente il tempo e lo spazio, senza che l’una dimensione sovrasti o cancelli l’altra. Il poeta, o l’osservatore, il fotografo o il viaggiatore, attraversano i paesaggi della memoria (“La meta d’un pellegrinaggio una pietra nella memoria una montagna spostata”) e della storia contemporanea (“leggo con i gangli vitali della / nostra economia nazionale / sistemi radio, telematici, / difensivi, comunicazione / amministrativa, componenti / per la ferrovia & l’edilizia”), rimanendo sulla superficie delle cose (“e già quasi spenta / la luce si riversa / sulla piana del Reno”) e di fronte al loro abisso (“Attraverso il sonno lasciano / traccia i caratteri / d’una lingua che / tu non comprendi”).
Ed è proprio qui che si rivela un profondo paradosso nella mancata registrazione del tempo attraverso lo spazio, un po’ come accade nelle trame temporali della meccanica quantistica e della meccanica newtoniana: essere qui ma non ora (o ora, ma non qui), da un lato, ed essere insieme spazio e tempo, dall’altro.
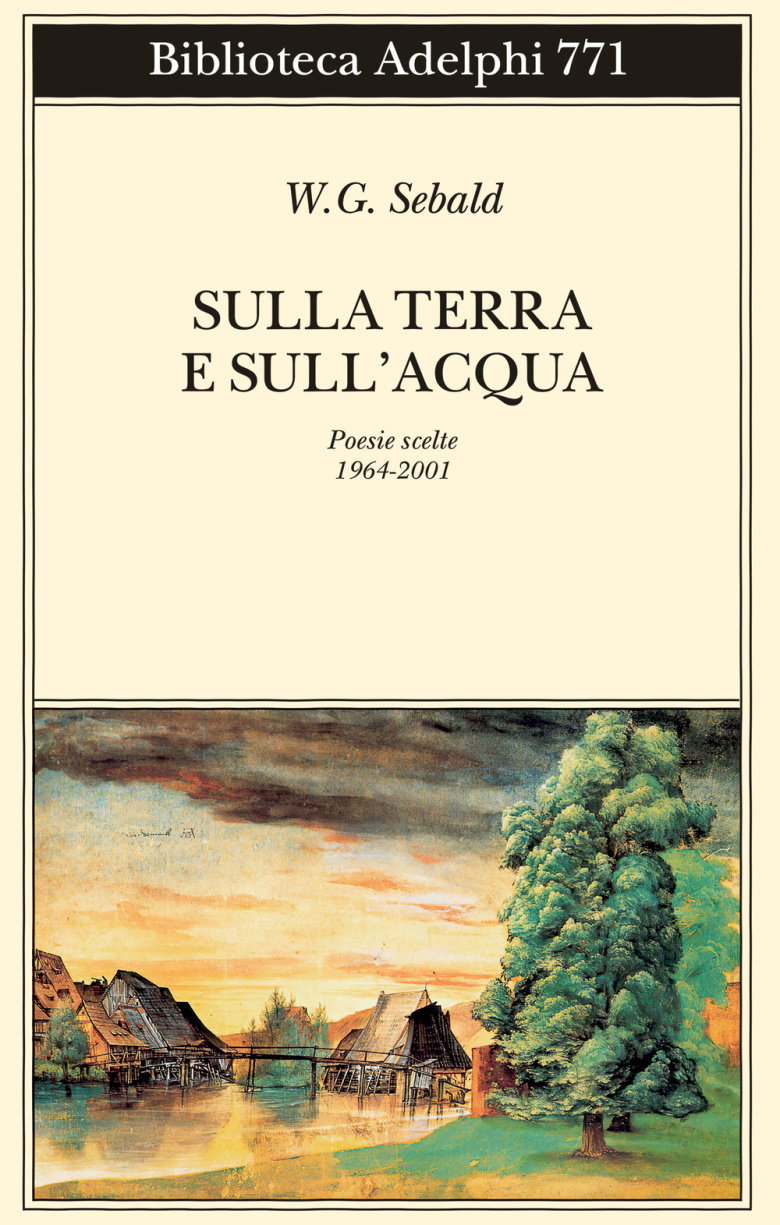
Ma mentre la prosa, per Sebald, ambisce a una ricostruzione architettonica del tempo, la poesia rimane sospesa tra questi due stati dell’io, quello della terra e quello dell’acqua, affidando alla parola il compito di essere insieme lirica e narrativa, di esprimere l’evento e di raccontarlo, per poi fotografarlo, rendendolo così eterno e fermo, senza tempo – l’aion (αἰών) degli antichi greci – attraverso gli spazi della memoria: delle vere e proprie tracce memoriali che, in questa raccolta senza fine, senza linearità macrotestuale e senza autore, sono lasciate a noi lettori di Sebald attraverso i suoi luoghi e i suoi elenchi, popolati da persone note e ignote, da ricordi e storie, tra realtà e finzione.
Proprio come accade nel testo che chiude l’esperienza lirica dell’autore – alle soglie di questi paesaggi, in Distogliendo lo sguardo:
l’occhio del cane
tutto vede
come se fosse
ancora all’inizio
Non mi stupirebbe, a questo punto, di leggere tra qualche anno nell’apparato critico dell’edizione tedesca delle opere di Sebald la ‘voce’ Zyklus (ciclo) per descrivere la sua poesia: uno spazio e un tempo in cui i motivi ritornano e si trasformano, intrecciando memoria individuale e storia collettiva in un verso che, anche quando sembra finire, torna su se stesso, cercando ancora una volta un nuovo inizio negli spazi vuoti della pagina bianca, tra le fotografie di un archivio, nei pressi di una stazione, nei suoni e nei rumori, degli uomini e degli animali.
Leggi anche:
Rinaldo Censi | Austerlitz
Christian Scholz | Sebald. L’esistenza nomade della fotografia
Roberto Gilodi | Conversazioni / Sebald. Anatomia della memoria
Roberto Gilodi | Ritratto di W.G. Sebald
Muriel Pic | Lo scrittore tedesco e l’uso delle immagini / W.G. Sebald e le farfalle







