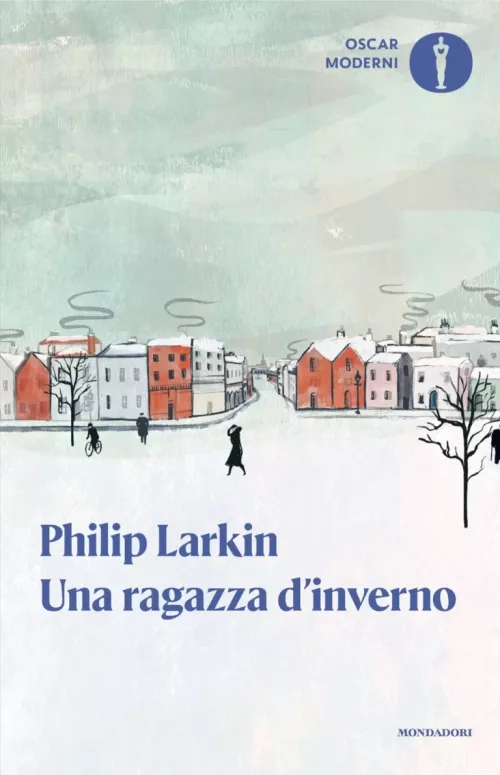Philip Larkin: "volevo essere un romanziere"
Nella mia tutto sommato modesta esperienza di lettore, il 1947 ha sempre esercitato un fascino particolare su di me: La peste di Camus, Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, Sotto il vulcano di Lowry, Doctor Faustus di Mann. Senza contare, poi, la prima edizione olandese del Diario di Anna Frank e, soprattutto, l’edizione De Silva di Se questo è un uomo di Primo Levi. E non che per la poesia sia stato un anno da dimenticare, anzi: L’età dell’ansia di Auden e il Diario d’Algeria di Sereni sono due libri imprescindibili.
Curiosamente, facendo i conti in tasca a Camus, Calvino e Levi, ci troviamo di fronte a tre debutti assoluti – e che debutti. Ma anche i secondi tentativi (i più difficili, di solito) sembrano mantenere, e addirittura superare, le aspettative nate dagli esordi di Lowry (e qui la distanza tra Sotto il vulcano e Ultramarine è abissale) e di Sereni (io preferisco Frontiera, ma il Diario è un libro migliore, forse solo meno bello).
Il 1947, però, è anche l’anno delle scritture eccentriche: nella collana “Saggi” di Einaudi spuntano i Dialoghi con Leucò di Pavese, una raccolta che solo di recente è stata riscoperta dopo decenni di goffi tentativi che avevano provato a leggere il suicidio di Pavese attraverso le parole di Prometeo o di Odisseo. Oppure, possiamo imbatterci nella dialettica dell’Illuminismo del duo francofortese Horkheimer-Adorno, nella lettera sull’umanismo di Martin Heidegger, e nella morale dell’ambiguità di Simone de Beauvoir.
Wittgenstein parlerebbe di “somiglianze di famiglia”, Benjamin di “costellazioni”, Gumbrecht userebbe il concetto di Stimmung per raccontare quell’effetto di presenza che certi corpi producono come epifanie sincrone di un liquido senza contenitore: fiction, lirica, saggistica, letteratura di testimonianza, modernismo, sono tutte categorie che fanno più un favore ai manuali che a noi lettori per comprendere questa inaspettata convergenza estetica del 1947.
Ma se vogliamo aggiungere un’altra goccia a questo caos senza contenitore per far traboccare il suo invisibile vaso, il secondo romanzo di Philip Larkin (1922-1985), A Girl in Winter, sembra fatto apposta per incrinare definitivamente quella rete provvisoria che l’atmosfera l’immediato dopoguerra sembrava, almeno in apparenza, garantire.
Ma qui il caos, più che formale o storico, è culturale: nell’immaginario collettivo Larkin è un poeta, e non un romanziere; e se ci avventuriamo nella torre d’avorio degli studi di poesia, Larkin è addirittura il poeta di riferimento del più strenuo difensore della tradizione lirica occidentale, Jonathan Culler, il quale si appella ogni volta che può al “bard of Coventry” per ricordarci che la poesia lirica è un evento, è anti-finzionale e anti-mimetica; che la poesia lirica è forma, giochi di suono e ritualismo. E che Philip Larkin è un poeta (anche se la sua lapide recita ironicamente “writer”).
Durante gli anni universitari a Oxford, tuttavia, un giovanissimo Philip Larkin sperimenta in maniera del tutto obliqua la poesia e la prosa, la prosa e la poesia: nel 1945 esce la raccolta di versi The North Ship, nel 1946 (a distanza di soli tre mesi dall’esordio poetico) e nel 1947 Larkin pubblica due romanzi, Jill (Mondadori 2024) e Una ragazza d’inverno (Mondadori 2025). Cui poi seguiranno altre tre raccolte: The Less Deceived (1955), Le nozze di Pentecoste (1964) e Finestre alte (1974).
Dunque, come Lowry, Larkin ha scritto un romanzo sulla natura “pura e semplice, quasi atemporale”, e sulla “misura” (150) del tempo. Anzi, a voler essere ancora più precisi, come Lowry, Larkin ha scritto un romanzo di una giornata – una sotto forma del romanzo moderno, che ha origine nell’Ottocento ma che esplode ufficialmente con i cronotopi novecenteschi, costruito intorno a un tempo della storia che tende a non superare le ventiquattro ore. Ma rispetto a Sotto il vulcano, dove lo spazio (Quauhnahuac, in Messico) e il tempo (2 novembre 1938) sono categorie riconoscibili e esplicitate quasi ossessivamente negli undici dei dodici capitoli del romanzo (il primo capitolo si svolge il 2 novembre 1939) che raccontano (tra le molte cose) la vita e la morte del console inglese Geoffrey Firmin, Una ragazza d’inverno ha un cronotopo più rarefatto, volutamente tenuto sottotraccia, come ogni dettaglio privato che viene svelato in maniera del tutto casuale senza che il narratore si senta in dovere di caratterizzare più del necessario i suoi personaggi nei tre capitoli del libro.
In corso d’opera, allora, scopriamo che il romanzo è ambientato durante la Seconda guerra mondiale e che la narrazione ha luogo in Inghilterra (in una città non troppo distante da Londra, ma che rimane ignota), dove la ventiduenne Katherine Lind ha vissuto (e vive da “due autunni”, 245) in due temporalità diverse: in un imprecisato sabato d’inverno, dove si svolgono le sue vicende lavorative (Katherine è una bibliotecaria con un contratto a tempo determinato) e private (l’incontro non previsto con un suo vecchio amico), rispettivamente nella prima e nella terza parte del libro; e in una (im)precisata ellissi estiva – il secondo capitolo si svolge sei anni prima dell’evento principale – presso la residenza della famiglia Fennels nell’Oxfordshire, dove Katherine passa tre settimane, per lo più in compagnia dei loro figli (Robin, suo coetaneo, e Jane, di nove anni più grande).
Il grimaldello narrativo è molto semplice, e lineare, come la prosa di Larkin (pungente ma priva di sbavature e eccessi retorici; una lingua piana che progressivamente lascia il piano zero del linguaggio per attraversare il corpo e la mente della protagonista): un sabato d’inverno Katherine Lind scopre che la figlia di Jane Fennels è morta; decide così di riprendere i contatti con quella famiglia inglese che l’aveva ospitata sei anni prima in qualità di “amica di penna” di Robin. Attraverso questo frammento s-connesso della vita di Katherine, il romanzo inizia, evadendo dalla riproducibilità meccanica del lavoro e della vita uniforme della provincia inglese, dove le azioni e i pettegolezzi, le invidie e le gelosie sembrano essere tanto rigidi quanto destinati a essere costantemente riprodotti senza soluzione di continuità.
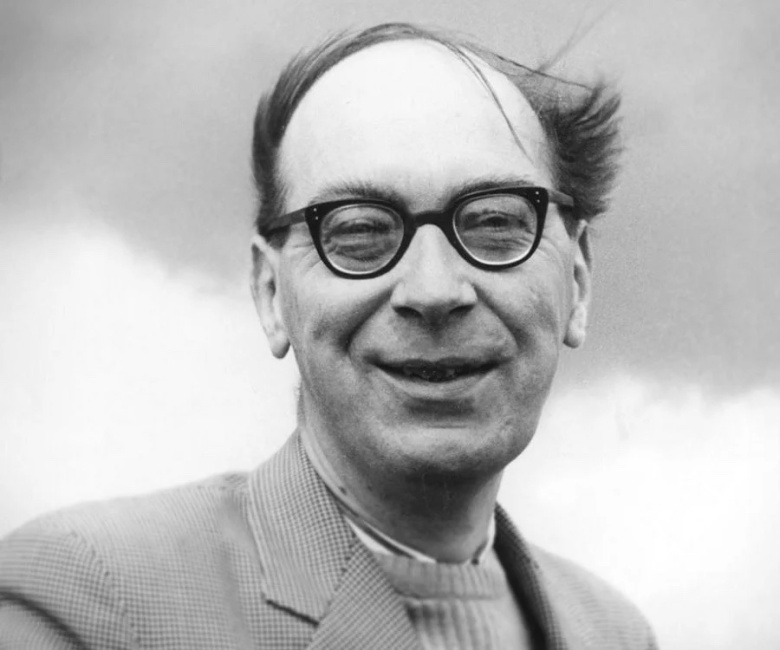
Solo il tempo sembra essere in grado di sfuggire da questa dinamica plastica (“le macerie della giornata”, 228), a patto che a una determinata ora della giornata si associ un evento che rompa, narrativamente, il tempo della storia: la notizia del lutto di Jane, un telegramma di Robin, il mal di denti di una giovane collega creano uno svasamento temporale della mediocrità temporale e umana del lavoro, a tal punto che anche gli eventi storici (la guerra, la crisi economica, l’incertezza del futuro) che caratterizzano la vita dei personaggi vengono posti sullo sfondo (l’Inghilterra, le relazioni, gli individui sono, per Larkin, un’isola), lasciando ampio spazio al narratore per indagare la vita psichica (i sogni, le speranze, le aspettative) di Katherine Lind.
Il termine, me ne rendo conto ora mentre lo scrivo, è improprio: parlare di tempo e vita psichica per Larkin è un false friend, dato che si potrebbe pensare a Una ragazza d’inverno come al tipico romanzo modernista del Novecento. Diversamente dall’Ulisse (ma anche dalla Recherche), gli eventi privati non sono epifanie o intermittenze del cuore, ma servono a sciogliere la meccanicità del tempo senza che la narrazione si trasformi in una serie irrelata di flussi di coscienza e discorsi liberi indiretti. Un algoritmo o un attento esame quantitativo del romanzo renderebbero conto di quanto balza immediatamente agli occhi, ossia il numero elevato, a tratti strabordante rispetto al corpo del testo, del discorso diretto (che alterna forme brevi a periodi più lunghi e articolati). Tuttavia, nella migliore delle ipotesi i dialoghi di Larkin tendono a uno scambio di informazioni, svolgendo, complessivamente, una funzione riempitiva. Ogni personaggio sembra appartenere unicamente alla propria monade; quando prende parola, lo fa per dire eventualmente qualcosa di sé, per aggiungere materiale umano, psichico e informativo alle proprie esistenze.
Questo meccanismo dialogico potrebbe anche riflettere un’incomprensione linguistica tra i personaggi del romanzo, poiché il punto di vista del romanzo e il suo luogo enunciativo sono stranieri (il narratore è esterno ma osserva il mondo attraverso gli occhi di Katherine), mentre il mondo del lavoro (e della vita nell’Oxfordshire) è inglese. Katherine, infatti, rimane una straniera in terra straniera per volontà degli sguardi altrui ma anche per sua stessa volontà: “era restia a sbarazzarsi dei suoi vecchi abiti per indossare roba inglese” (194-5). Ciò detto, la lingua di Larkin non restituisce del tutto questa mimesi del parlato (a meno che la protagonista non fosse già piuttosto eloquente in inglese a sedici anni, ma il fatto che lei avesse bisogno di un “English boy” per migliorare il suo inglese esclude apriori questa ipotesi), e per tutta la durata del romanzo Katherine parla come Robin e Jane.
Una ragazza d’inverno non è un romanzo modernista (nemmeno alla maniera di Virginia Woolf) né un romanzo sul tempo come la Montagna incantata. È però un romanzo che fa i conti con gli effetti del tempo negli immediati dintorni della guerra (Larkin finisce il romanzo prima del 1945), un po’ come farà Raffaele La Capria in Ferito a morte (1961), dove troviamo una struttura narrativa simile a quella di Larkin: due temporalità (di cui una di una giornata), lontane nel tempo ma speculari. Oppure come Heinrich Böll in Opinioni di un clown (1963), in cui l’ossessione per la materialità del tempo riduce l’azione del romanzo a poche ore.
Come La Capria e Böll, anche Larkin costruisce un romanzo in cui il tempo si ripete ciclicamente attraverso la sua materialità e la sua ripetizione meccanica, soprattutto nei luoghi chiusi – gli uffici, lo studio del dentista, le camere da letto, i soggiorni –, dove sono gli orologi a segnare lo “scorrere delle ore”. Sono proprio questi orologi a ricordare che Katherine lavora con un contratto a tempo determinato, che le sue giornate si consumano in azioni ripetitive e che il tempo a sua disposizione è ridotto. Allo stesso modo, anche Robin ha poco tempo per stare con lei dopo il lavoro: “Robin era stato l’energia che aveva messo in movimento quella giornata, la cui velocità era aumentata” (228). E, poco più avanti: “finalmente giunse l’ora in cui il lavoro, per quella sera, era quasi terminato” (233).
Questo è ciò che Larkin fa con il tempo, nel primo e nel terzo capitolo, qualcosa che si muove tra Chaplin e Freud, tra la meccanicità del lavoro e la coazione a ripetere gli schemi del nostro inconscio. Diversamente, nella seconda parte, il tempo appartiene a un passato remoto che non sembra più avere alcun contatto o ripercussione diretta nella vita di Katherine. È un tempo estivo, aperto all’esperienza e alla narrazione delle possibilità, disteso lungo tre settimane e modulato secondo ritmi che cambiano in base ai sentimenti di Katherine: la novità della scoperta di un paese straniero, l’interrogazione e poi l’esperienza dell’amore per Robin si accompagnano a una percezione dilatata del tempo, non più misurabile attraverso l’intervallo regolare delle ore o dei giorni (“l’amore di quattro giorni”, 166). Al contrario, la noia delle azioni quotidiane – l’ora del tè, le escursioni, i momenti conviviali, le partite a tennis, le gite in punt – scandisce un tempo che agli occhi di Katherine appare “indifferente”, “inattuale”, “banale” e “neutro”.
Tornati al presente, leggiamo che Katherine “viveva alla giornata, teneva lontano il passato, ma anche il futuro, e trasformava il presente in un’unica, effimera, precaria esistenza” (195). Da quando si è trasferita in Inghilterra come rifugiata di guerra (di più non sappiamo: l’età, qualche dettaglio fisico e vaghi cenni biografici; la città d’origine è situata lungo il Reno, ma il Reno è lungo 1326km e attraversa sei Stati), Katherine “mangiava, dormiva, lavorava, e si rifiutava di paragonare ciò che faceva, mangiava, o dove dormiva, con qualunque lavoro o cibo o casa avesse conosciuto in passato” (194). Un passato che, significativamente, rimane confinato unicamente nel secondo capitolo del romanzo.
Nel terzo capitolo Larkin rimuove ogni possibile traccia di memoria, riproponendo meccanicamente l’incontro tra Robin e Katherine, come se i due ragazzi non si fossero mai separati. Per Robin, infatti, il tempo sembra essere sospeso, così come la sua vita – è un soldato in licenza, potenzialmente destinato a morire in guerra –, ed è ancora legato agli eventi di quella lontana estate inglese. Appena rivede Katherine, Robin la bacia con la stessa inesperienza e foga di un ragazzo di sedici anni, trascinato anche, come suggerisce Larkin, dal desiderio, poco celato, di interrompere il proprio del lavoro con una notte di sesso – il cui esito, però, rimane avvolto in un alone di ambiguità: nelle pagine finali non è chiaro se Katherine abbia ceduto ai desideri di Robin, anche se le pause temporali tra un dialogo e l’altro – segnate da degli spazi bianchi (che Larkin usa solo in questa circostanza) – lasciano intuire che i corpi si siano effettivamente intrecciati.
“Il futuro sembrava un terreno depresso, insignificante e poco profondo” (198): nell’universo narrativo di Larkin, il tempo della vita non può che coincidere con il tempo presente del lavoro: anche nel momento di massima intimità – che altro non è se non una prossimità fisica tra due s-conosciuti – c’era un “orologio che ticchettava. Tanti fiocchi, tanti secondi. A mano a mano che il tempo passava, fiochi e secondo sembravano mescolarsi nelle loro mente, ammucchiandosi a formare una grande sagoma che poteva essere un tumulo mortuario, o la parete di un iceberg la cui cima non fosse visibile. Alla sua ombra si affollavano i sogni, pieni di pensieri e correnti di freddo” che “se ne andavano in lenta ordinata processione”, “senza dar modo di pensare che il loro ordine potesse mai venire infranto” 267). Nulla può scalfire la meccanicità degli eventi. Non c’è spazio, a questo punto della narrazione, per uno spiraglio da cui guardare il mondo con un altro occhio o in un altro tempo (come nella finestra alta di High Windows). Solo il tempo regge e regola quelle vite individuali che si moltiplicano e si reificano nella loro speculare identità di genere e di ruolo, esattamente come scriveva T.S. Eliot nel suo ritratto della dattilografa della Terra desolata (testo che Larkin detestava, insieme all’intero modernismo europeo, ma il principio mimetico è identico).
Dopo l’inverno di Katherine Lind – A Girl in Winter inizialmente doveva intitolarsi The Kingdom of Winter –, Larkin aveva abbozzato l’idea di un terzo romanzo (che avrebbe dovuto formare una trilogia insieme a Jill), abortito in più occasioni e poi definitivamente accantonato. Con il definitivo abbandono della prosa di finzione per la poesia, Larkin ci ha lasciato dei racconti giovanili (postumi), delle prose giornalistiche, e diverse lettere che ci restituiscono l’immagine di un uomo di destra, un po’ razzista e un po’ misogino, schivo e disinteressato (che dire: un uomo del 1922 nato a Coventry e che ha vissuto tutta la vita nell’ombra della provincia inglese). Eppure, procedendo a ritroso da High Windows (1974) fino a A Girl in Winter (1947), la parola di Larkin sembra riflettersi in un quadro cinico e disincantato, di cui Katherine e Robin sono la perfetta espressione nell’ultima immagine del romanzo: nudi e uniti, indistinguibili e identici nei loro gesti, quando smettono di resistere (“protestare”) all’“inesorabilità degli eventi”, accettando – ed essendo persino “contenti, alla fine” – che “quell’ordine, quel destino esista” (267).
E questo, più che il poeta, ce lo racconta il writer Philip Larkin.