Speciale
Un libro discutibile / Mastrocola e Ricolfi: quale è il vero danno scolastico?
Nella relazione sulla Scuola normale maschile di Bari redatto nel 1885 da Antonio Labriola, ispettore del Regno d’Italia, possiamo leggere quanto segue: «Tutti gli scolari, e specie i convittori, mi fecero una sgradevole impressione. Pare che abbiano scritto su la fronte la pigrizia e la negghienza. Portamento fiacco e svogliato, nessuna emulazione. Subirono la ispezione senza parteciparvi con lo spirito, mentre in alcune altre scuole, e specie nella femminile di Bari, anche negli alunni e nelle alunne di poca cultura trovai cortesia e volontà di far buona figura. Il direttore non dissentì da me in questo giudizio. Quali le cause di questa decadenza della scuola? La facilità, dicono, delle ammissioni, perché di anno in anno il numero degli alunni va diminuendo».
Quasi un secolo dopo, nel 1976, la rivista specialistica Tuttoscuola, nata un anno prima, promuove un dibattito sulla necessità, avvertita come improrogabile, di ricomporre la distanza tra istruzione formale erogata e saperi realmente posseduti dagli studenti. Tra i partecipanti alla discussione figurano Giovanni Gozzer, democristiano, collaboratore del ministro Gonnella per la riforma della scuola media del 1962 ma feroce oppositore ai Decreti delegati del 1974, e Franco Ferrarotti, sociologo di formazione internazionale che era vicino alle posizioni di Adriano Olivetti. Chi ha paura della selezione? titola l’intervento di Gozzer, che critica la deriva “formativa” della secondaria superiore e contesta a Ferrarotti un modello democratico sperimentale che, se attuato sino in fondo, non avrebbe dovuto rilasciare diplomi.
Come si evince, il tema di una maggiore selettività della scuola come argine al suo declino culturale che sarebbe un esito della scolarizzazione di massa è, quindi, piuttosto ricorsivo. Le tesi esposte ne Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguaglianza (La nave di Teseo, Milano 2021) di Paola Mastrocola e Luca Ricolfi, da tempo nomi noti nel dibattito pubblico sulla scuola e al centro di opposte valutazioni anche molto polarizzate, meritano attenzione oltre per la vasta eco che suscitano perché articolano una strategia retorica abbastanza usuale negli attuali discorsi liberal-conservatori sull’istruzione: in base a questi solo un modello di scuola e università rigoroso e selettivo promuoverebbe reali percorsi di emancipazione coerenti con l’articolo 34 della Costituzione, che al terzo comma stabilisce come i “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
Entriamo dunque nel vivo degli argomenti. Nel primo capitolo del testo, organizzato in quattro capitoli, è esposta l’ipotesi di partenza, nonché la tesi che si intende difendere: ovvero, il progressivo abbassamento della qualità dell’istruzione ha acuito le disuguaglianze scolastiche a svantaggio dei ceti popolari. Occorre attendere il quarto capitolo in cui vengono mostrati i risultati della ricerca della Fondazione Hume (di cui Ricolfi è presidente) perché l’ipotesi sia giustificata. Il corpo centrale dell’opera intreccia invece una ricostruzione della istruzione superiore e della formazione universitaria italiana a partire dagli anni Sessanta narrata attraverso il racconto in prima persona di chi ha lavorato nei licei (Mastrocola, III capitolo) e nell’università (Ricolfi, II capitolo) e si è opposto, vanamente, alle politiche scolastiche elaborate negli ultimi decenni.
Ora, il libro solleva questioni e problemi diffusi e sentiti da tempo e a più livelli nel mondo dell’educazione e della cultura, senza però inquadrarli adeguatamente e offrendo risposte che paiono semplificanti, errate e consolatorie. Senza dubbio intercetta e canalizza un disagio diffuso tra quanti lavorano nel settore dell’istruzione ma offre una lettura di comodo degli attuali problemi scolastici senza affrontare un’autocritica sulle modalità del lavoro in classe e senza l’onere di proporre un’articolata controproposta che sia diversa dalla nostalgia di un passato immaginario.
Come l’istruzione vera sarebbe divenuta una farsa
I due capitoli centrali, in particolare, sono un fulgido esempio della messa in pratica di una nota fallacia argomentativa, l’argomento fantoccio (straw man argument), che consiste nel riformulare una posizione avversa in modo tale che appaia assurda o non sostenibile, per poterla meglio attaccare. Il termine “progressista” che compare nel titolo riferito alla scuola (leggasi democratica e popolare) è, infatti, sinonimo di falsamente democratico, culturalmente dequalificato, scarsamente selettivo, sostanzialmente iniquo e inutile. Questo avverrebbe perché la scuola (a) non riduce le disuguaglianze delle opportunità educative ma le vela dietro la retorica del “successivo formativo”; (b) produce alta dispersione scolastica implicita, cioè studenti privi delle risorse culturali per poter affrontare con ragionevoli probabilità di successo l’università. Per citare direttamente le parole degli autori, «se il figlio dell’idraulico non diventa notaio forse non è soltanto perché è figlio dell’idraulico; forse non arriva a laurearsi perché non ci riesce, perché ha fatto una scuola che non lo ha preparato» (p. 87).
Progressista, in sostanza, diviene una etichetta per designare politiche scolastiche prodotte in tempi differenti, animate da ragioni ideali spesso opposte, che hanno risposto a esigenze sociali molto diverse tra loro. La lunga marcia dell’abbassamento avrebbe avuto un certo numero di soste: la riforma della scuola media del 1962; il libero accesso all’università del 1969: i decreti delegati del 1974-75; l’attività riformatrice elaborata tra il 1997 e il 2000 dal ministro Berlinguer sia a livello universitario (3+2) sia sull’autonomia scolastica e il (mai attuato) riordino dei cicli; la riforma Moratti del 2003, parzialmente inapplicata; il taglio delle spese all’istruzione voluto dal ministero Gelmini; la buona scuola di Renzi.
Quali sono gli elementi problematici di questa ricostruzione? Il primo è di metodo. Il racconto in prima persona è giocato su un ammiccamento continuo nei confronti del lettore cui è chiesta una partecipazione emotiva e non riflessiva. Espressioni quali “quel che osservo è qualcosa di più”, “ricordo distintamente”, articolano un discorso che confonde sistematicamente percezione e realtà, memoria e storia.
Agisce, come ha ricordato Vanessa Roghi, un tratto caratteristico di molta saggistica sulla scuola: l’assenza di elementari nozioni di pedagogia, di sociologia dell’educazione e di psicologia dello sviluppo, nonché di un più generale inquadramento della storia della scuola nella storia sociale e politica del paese. Nell’idea di scuola di Mastrocola e Ricolfi l’insegnamento corrisponde alla conoscenza della propria disciplina, l’ignoranza di altro da parte dei docenti pare giustificata da una passione permanente nei confronti della disciplina amata e insegnata. Sempre attuali, su tale entusiasmo, le parole di Antonio Gramsci: nel Quaderno 13 (XXX, § 8) esso è definito come «una condizione di orgasmo e di spasimo, che determina inettitudine all’operare». Una condizione che giustifica ciò che non può essere giustificato, e che confonde e identifica la conoscenza di qualcosa con la capacità di saperlo insegnare a soggetti diversi, con specifici bisogni e in diversi contesti di apprendimento.
Il secondo problema è relativo alla qualità della spiegazione. Mastrocola ritiene che l’abbandono di una prassi didattica centrata sulla parafrasi e sul costante esercizio scrittorio sia la causa della regressione cognitiva che ha osservato nei suoi studenti. «Si studiava scrivendo alle medie che ho fatto io. È la cosa che ricordo più di ogni altra. […] Forse quel nostro studiare scrivendo oggi lo chiamerebbero ‘metodo’» (p. 100). Spiace dover constatare una trattazione così superficiale di problemi complessi quali l’oggettiva difficoltà nella padronanza dell’italiano standard per larghe fasce studentesche anche universitarie (che tra l’altro non tiene neanche conto delle competenze linguistiche generali di altri segmenti di popolazione e generazionali). Qui le questioni di didattica della lingua s’intrecciano con i mutamenti culturali profondi descritti da Raffaele Simone nella Terza fase. Le tecnologie digitali – ha spiegato Luciano Floridi – danno forma e influenzano il modo con cui comprendiamo il mondo e ci rapportiamo ad esso: ciò non può non avere ripercussioni sull’idioletto degli studenti. Senza spingersi necessariamente verso le teorizzazioni di un sensorio digitale, un discorso che voglia essere qualche cosa di più di una geremiade sul presente volta a celebrare non meglio precisati livelli scolastici precedenti non può non nutrirsi di sociologia della cultura o delle acquisizioni delle neuroscienze in questo ambito (come ad esempio Demenza digitale di Spitzer). Qui, spiace rimarcarlo, il senso comune si sostituisce alla fatica dell’analisi e il discorso sulla scuola prescinde dal confronto e dalla conoscenza dell’intero dibattito sociologico sulla scuola. Esemplificativo è il modo in cui (non) si discute la relazione tra scuola e territorio.
L’autrice, coerentemente con quanto scritto nei diversi precedenti interventi sulla scuola secondaria, afferma di non aver ancora capito cosa questo significhi né che ragioni abbia. Eppure varrebbe la pena informarsi, mostrando maggior disponibilità a studiare prospettive differenti. È, infatti, stato ampiamente evidenziato da numerose ricerche empiriche che un’alta disponibilità di capitale sociale si traduce, fra l’altro, in una bassa percentuale di dispersione scolastica e che le scuole con i migliori risultati in termini di riduzione del tasso di abbandono sono quelle operanti in un circondario dove la comunità territoriale (famiglie, comunità, enti locali ed istituzioni, ecc.) assegna grande rilievo all’educazione ed è conseguentemente operativa in tal senso; al contrario, i risultati negativi corrispondono a scuole non adeguatamente correlate con la comunità territoriale e le famiglie e da queste non sufficientemente sostenute.
Altrettanto superficiali sono alcuni giudizi come quelli sull’operato del ministro Luigi Berlinguer, trasformato nell’esecutore materiale di un omicidio culturale che avrebbe – secondo un luogo comune assai diffuso di natura ideologica – le sue radici in Don Milani e nel Sessantotto. Per quanto riguarda l’università leggiamo che «Berlinguer è stato l’esecutore decisivo della distruzione dell’università, ma ha avuto i suoi precursori, e anche i suoi continuatori più o meno entusiasti, come i ministri De Mauro, Moratti e Gelmini» (p. 65). Per quanto riguarda la scuola secondaria si può osservare un’analoga modalità di tenere insieme aspetti diversi e non chiaramente correlati: «La riforma Luigi Berlinguer. Per non farla tanto lunga, direi che allora entrarono tra ingredienti decisivi: i progetti extracurriculari, la valutazione oggettiva (i test), e il diritto al successo formativo. Cambiava la sostanza: la scuola diventava un’impresa» (p. 150).
Colpisce in effetti, in un testo che intende giudicare così severamente l’impoverimento culturale inflitto agli studenti dall’attuale modello di scuola, il fatto – facilmente verificabile – che Luigi Berlinguer sia ritenuto il fratello del “mitico Enrico” e non, come è, il cugino. Sorprende maggiormente l’inconsistenza dell’argomentazione: ridurre l’intero operato del primo governo Prodi a fedele esecutore di politiche scolastiche neoliberiste decise altrove è quantomeno semplificante, pena la trasformazione del neoliberismo a categoria onnicomprensiva che riducendo gli elementi dell’analisi pare buona per una critica capace di trovare consensi tanto a destra quanto a sinistra. Naturalmente si può e si deve discutere sul significato che l’autonomia scolastica ha assunto, sulle modalità competitiva con cui è stata declinata, sulle ricadute che ha comportato in termini culturali e di organizzazione del lavoro dei docenti. Ciò che dovrebbe essere evitato è la riduzione al grottesco di provvedimenti con cui si è in disaccordo, senza segnalare le profonde differenze interne di diverse stagioni di governo e le discontinuità con ciò che viene dopo. La riforma Moratti, ad esempio, ha abolito la normativa Berlinguer sul riordino dei cicli. E certe pratiche di sperimentazione di progettualità che hanno ormai vent’anni di trasformazioni sono state animate nel tempo da altri intenti rispetto a iniziative come l’Alternanza scuola lavoro e i percorsi di Pcto, al punto che vederli frutto di una medesima ratio sembra davvero difficile.
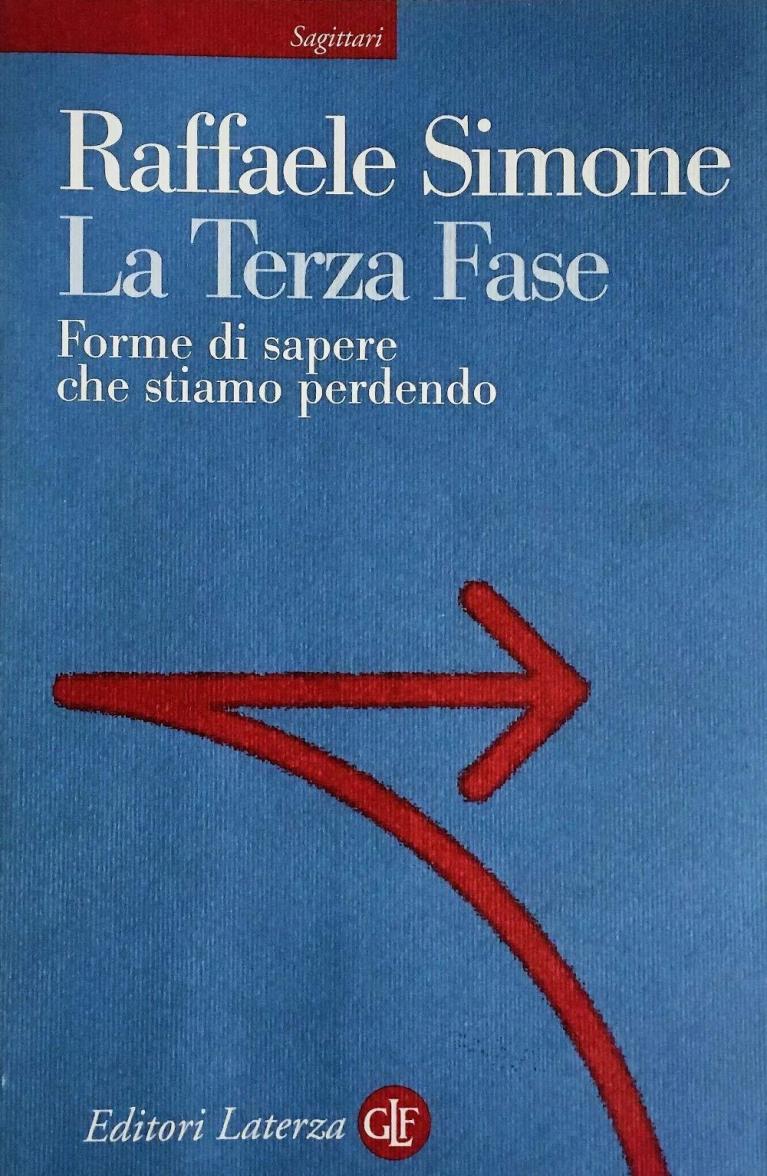
Il tutto sembra, insomma, pregiudizialmente informato dalla tesi di partenza e funzionare più per le strategie retoriche che per gli argomenti addotti. Cosa significa una scuola di qualità? «La scolarizzazione di massa è stata accompagnata da un continuo, inesorabile, abbassamento degli standard a tutti i livelli, dalla scuola elementare all’università» (p. 54). L’affermazione è piuttosto impegnativa, soprattutto se rapportata alla documentazione prodotta per supportarla. Qui le risposte sono ancora una volta sorprendenti: sono prove il ritrovamento di diari e quaderni scolastici, ciò che viene osservato in sede di esami universitari (Ricolfi), la vastità dei programmi che i “miei” docenti svolgevano o che “io” effettuavo all’inizio della mia carriera (Mastrocola). Sarebbe lecito attendersi qualcosa in più, anche in termini di onestà intellettuale.
Proprio il confronto tra studenti di epoche diverse risulta assai problematico per molteplici motivi: diversità del quadro orario, differente distribuzione delle discipline, diversità delle richieste, differenza del contesto storico-culturale di riferimento. Il racconto che l’autrice fa dei suoi pomeriggi in cucina a svolgere “pagine e pagine” di parafrasi con sua madre accanto intenta a svolgere forme di lavoro a domicilio, se da un lato ci dice qualcosa del suo mondo e della sua biografia forse, non riflette le attuali configurazioni familiari. Nella scuola media dal 1963 al 1977, le materie cosiddette umanistiche impegnavano il 42,6% dell’orario settimanale di prima, seconda e terza che era di circa 25 ore settimanali. Al termine delle modifiche ordinamentali volute dalla ministra Gelmini le medesime discipline oggi valgono sulle tre classi il 31% in un quadro orario minimo di 30 ore a settimana. Di questo processo si possono dare letture diverse: Alfonso Scotto di Luzio ne ha discusso in termini negativi giudicandolo un tributo pagato al mito sociale dell’innovazione curricolare, in cui la scuola è «stata di fatto considerata negli ultimi trent’anni come un magazzino dove stoccare di volta in volta la disciplina del momento». Simone Giusti, invece, ha rivendicato che l’inserimento alla fine degli anni Settanta delle ‘educazioni’ (tecnica, artistica, musicale) voleva essere uno strumento di emancipazione culturale delle classi subalterne, in un contesto di didattica laboratoriale attenta al piano esperienziale dell’apprendimento.
Un progetto che se si vuole vedere come fallito deve essere correlato all’irrigidimento delle educazioni in discipline anche per responsabilità di un corpo docente in larga parte inadeguato al compito.
Come osservato da Francesco Rocchi pur ammettendo una migliore preparazione degli studenti di cinquanta anni fa – ma il dato dovrebbe essere verificato – questa migliore qualità non può essere separata dal fatto che la scuola italiana non era una formazione di massa. Nel 1984 si iscriveva alle scuole superiori soltanto il 55% degli studenti licenziati dalle medie (dati Istat). Il 45% degli studenti usciti dalla scuola secondaria di primo grado quell’anno, dunque, non è andato oltre la terza media, mentre un ulteriore 25% di quegli iscritti ha più tardi comunque abbandonato (15% del totale dei quattordicenni del 1984). «Se nel 1984 fosse esistito l’Invalsi e avesse fatto una rilevazione degli apprendimenti di tutti i quindicenni italiani (cosa che oggi l’Invalsi può fare perché i quindicenni italiani sono quasi tutti nella scuola superiore), quali livelli di apprendimento avrebbe trovato? Quali risultati sarebbero venuti fuori da una generazione che per il 60% rimaneva con la terza media? Certo è che se questo ipotetico Invalsi avesse testato soltanto quel 40% di studenti ancora presenti a scuola, avrebbe trovato probabilmente livelli molto alti. Concludere da questo che la scuola italiana funzionava bene è però un errore statistico banalissimo, chiamato pregiudizio di sopravvivenza, che Ricolfi conosce molto bene per mestiere» (Rocchi, Distruzione scolastica).
Un altro aspetto problematico riguarda il fatto che la definizione di qualità scolastica sia ricondotta a ciò che le prove Invalsi misurano. Ricolfi stesso ammette che tale aspetto sia un “nodo spinoso” perché si sarebbe dovuto disporre d’informazioni molto dettagliate sulla qualità degli insegnanti, sui programmi effettivamente svolti, sulle votazioni riportate lungo la carriera universitaria. Inoltre dovrebbe essere possibile «distinguere tra istruzione impartita dalla scuola e il livello di apprendimento conseguito dagli studenti che ovviamente dipende da fattori economico-sociali» (p. 186). Anche se fosse stato possibile disporre di tali dati, gli indicatori appaiono problematici in sé. Relativamente al primo, la qualità degli insegnanti, la letteratura sul tema non ha raggiunto conclusione condivise nonostante l’esistenza di filone di studi l’Educational Effectiveness Research, praticato dagli economisti dell’istruzione. Il secondo non è indicatore significativo: fare il programma, completarlo, garantisce forme di apprendimento significativo? Inoltre sarebbe bene puntualizzare come il programma non esista più, mentre esistono le singole programmazioni vincolate alle Indicazioni nazionali. Nonostante queste criticità si ricorre comunque ai dati Invalsi che, però, presentano limiti importanti proprio nell’accertamento di quelle competenze sulla base delle quali stabilire indici di qualità. Quindi, pur denunciando la deriva mercatista dell’istruzione contemporanea, pur teorizzando la legittimità della valutazione soggettiva di prove (temi) e esami, a pelle, gli autori per definire cosa sia qualità dell’istruzione ricorrono allo strumento che più di ogni altro, per come è utilizzato, ha contribuito a appiattire la cultura della valutazione sulla misurazione, in piena coerenza con la pedagogia bancaria denunciata da Paulo Freire.
In definitiva il temine “qualità" sembra diventare ciò che è funzionale per accedere al livello d’istruzione successivo con ragionevoli probabilità di superamento. Il che è insopportabilmente riduttivo. Inoltre qualità di quale scuola? Il testo opera, da questo punta di vista, una ulteriore riduzione dei segmenti dell’istruzione superiore al Liceo classico e scientifico secondo un usuale pregiudizio reputazionale non messo a tema e implicitamente accettato, che è poi uno dei principali problemi del discorso pubblico sulla scuola fatto da chi la scuola sembra conoscerla poco nella sua totalità. Ne è una spia significativa il fatto che quando, di sfuggita, nel libro viene effettuato un riferimento al liceo linguistico se ne parli come di una realtà “degradata”…
A fronte di una più equa e ragionata disamina bisogna ammettere come in realtà la scuola italiana non sia mai stata progressista. Oasi di attivismo pedagogico, per lo più nella scuola primaria, hanno avuto un importante valore di testimonianza in alcune stagioni e in specifici contesti territoriali ma hanno avuto uno scarso peso a livello nazionale, soprattutto nella scuola superiore che – in questo ha ragione Mastrocola – è rimasta identica a sé stessa nel tempo sino al 2000 e ben oltre. Spiace dover constatare che nonostante le innovazioni normative introdotte, didatticamente sembra essere la medesima scuola che l’autrice ha esperito come studentessa e contribuito a costruire come docente.
I capaci e i meritevoli
Il quarto capitolo del libro è il luogo in cui Ricolfi, dismesso gli abiti del polemista, ritorna sociologo e spiega gli esiti della ricerca promossa dalla Fondazione Hume che ha inteso misurare, sulla base dei dati provenienti dalla rilevazione campionaria Famiglia e soggetti sociali promossa dall’Istat a partire dal 1998, se e in che modo le opportunità educative in un regime di opportunità limitate siano distribuite in modo equo e se la qualità dell’istruzione ricevuta possa limitare il condizionamento socio-familiare. Se ne ricava che la qualità della scuola esercita due effetti distinti. Il primo, chiamato parametro di meritocrazia, stabilisce che l’aver frequentato una scuola di qualità aumenta per tutte la classi sociali le “chance di successo” (del percorso scolastico intrapreso); il secondo, denominato parametro di emancipazione, misura l’impatto che una scuola di qualità possiede nell’attenuare lo svantaggio dell’origine. In questo contesto l’“indulgenza” nei sistemi di valutazione avrebbe esiti negativi sulla riuscita sociale ed è per tale motivo che l’autore ha recentemente dichiarato, provocatoriamente, che occorrerebbe introdurre il principio di responsabilità certificativa: come un perito è responsabile della perizia che firma così il docente deve essere responsabile delle competenze che attesta, pena una imprecisata sanzione.
Come già rilevato in precedenza l’opacità dell’indicatore qualità rende assai debole la costruzione modellistica e pericolosamente liminare a ciò che è già noto: una scuola a scarsa intensità culturale accentua i suoi caratteri classisti. Tuttavia quest’ultima sezione del lavoro è interessante perché impegna in una riflessione su alcune coppie concettuali: diritto all’istruzione\disuguaglianze educative, eguaglianza\merito, inclusione\selezione. Il perimetro teorico dell’opera è racchiuso nella frase seguente: «L’istruzione superiore è democratica se il suo livello viene tenuto alto, e se per accedervi contano solo il talento e l’impegno, anziché – allora come oggi – la ricchezza e il potere della famiglia o appartenere a qualche minoranza protetta». (p. 216)
Sorvolando l’esplicito disprezzo nell’espressione minoranza protetta che reca con sé un evidente giudizio di valore rispetto a quelle azioni antidiscriminatorie in campo universitario note come affirmative actions, l’autore difende una certa nozione di eguaglianza: non conta quanti raggiungono “i più alti gradi degli studi” ma chi. Le politiche pubbliche italiane non avrebbero dato attuazione al principio fondamentale di una società genuinamente democratica: mettere “i capaci e meritevoli” in condizioni di raggiungere “i gradi più alti degli studi” attraverso una generosa distribuzione di borse di studi e legando l’accesso alle università alla carriera scolastica, non a fumosi test d’ingresso. “Preveniamo una loro scelta sbagliata”, afferma l’autore in un passaggio del libro. Se fosse realmente applicato, tutto questo sarebbe davvero sufficiente per promuovere i più capaci e meritevoli? La nostra idea è che si tratti di fumo negli occhi.
Gli studi sulla mobilità sociale, a partire da quello di Boudon (Istruzione e mobilità sociale) utilizzato da Ricolfi contro la scuola sociologica bourdesiana, hanno in realtà mostrato come lo sviluppo dell’istruzione non porta con sé la riduzione diseguaglianza delle opportunità sociali, anche quando essa si accompagni a una riduzione della disuguaglianza delle opportunità scolastiche. Un’alta scolarizzazione non implica automaticamente una maggiore mobilità sociale. Inoltre una vasta letteratura sulle disuguaglianze educative continua a documentare che nelle coorti più giovani perdurano forti differenze nelle opportunità di raggiungere un titolo di studio diverso da quello del proprio genitore in un contesto di sostanziale peggioramento segnato dalla recessione economica prodottasi a partire dal 2008. Affinché anche i figli delle famiglie meno istruite e con vincoli di liquidità stringenti possano accedere a titoli di studio superiori sarebbe necessario mettere in atto interventi veramente incisivi sulle disparità economiche, offrendo così agli individui ‘capaci e meritevoli’ ma ‘privi di mezzi’ le risorse necessarie a raggiungere un livello di istruzione almeno adeguato. Lo rileva – tra le mille voci in questa discussione – Irene Brunetti.
«Validi strumenti a sostegno di una maggiore equità delle opportunità di istruzione sono le politiche che comportano un’allocazione dei fondi alle scuole più equa, la possibilità di offrire metodi di insegnamento flessibili, un reclutamento degli insegnanti che riesca ad attrarre i professori migliori anche nei contesti più svantaggiati e una maggiore attenzione alle attività extra-curriculari. Con riferimento alla scuola secondaria nel dibattito politico e accademico si parla della limitazione di quel processo che obbliga gli studenti a scegliere troppo presto fra percorsi successivi (ad esempio, fra licei e istituti tecnici), e di un’attenzione specifica per gli studenti a rischio di abbandono scolastico» (Brunetti, Istruzione e mobilità intergenerazionale, p. 60)
In un contesto caratterizzato (dati Istat 2021), dal profondo mutamento occupazionale e strutturale dell’economia italiana, in un regime di progressivo invecchiamento demografico, gli strumenti individuati ne Il danno scolastico non sono soltanto insufficienti ma si mostrano l’espressione di una precisa ideologia, reazionaria e regressiva in termini di eguaglianza sostanziale e non solo formale. Il “figlio dell’idraulico” – peraltro un'espressione infelice stereotipica e pregiudiziale – non potrà mai arrivare all’università.
Sembra significativo riflettere sul diritto all’istruzione richiamando alcuni considerazioni elaborate da Anna Maria Poggi che nel recente Per un "diverso" Stato sociale ha letto le politiche scolastiche di età repubblicana come scarsamente meritocratiche in quanto una certa interpretazione dello Stato sociale, lontana dalle intenzioni dei Costituenti, ha privilegiato gli interventi di assistenza, di protezione, indebolendo progressivamente quelli di promozione. Le due prospettive – rileva l’autrice – comportano ricadute molto diverse sul diritto all’istruzione sancito all’art. 34. «In una concezione dello Stato sociale assistenziale lo Stato ha il dovere di garantire l’istruzione nelle situazioni di bisogno e le persone hanno il diritto di riceverla. In uno Stato sociale di “promozione” lo Stato non ha solo il dovere di garantire l’istruzione ma ha anche il diritto di pretenderla; le persone non hanno solo il diritto di istruirsi ma hanno il dovere di farlo» (p. 27-28).
Il che – occorre ribadirlo – implica l’attuazione di politiche di pubbliche volte al contrasto della povertà educativa soprattutto nella fascia tra 0 e 10 anni. La sfida più urgente del sistema formativo ed educativo italiano, con buona pace di Mastrocola e Ricolfi, si gioca dunque sul terreno dell’equità delle opportunità educative a sostegno di quegli allievi e di quelle famiglie che, soprattutto in questa fase emergenziale, hanno sperimentato una ulteriore condizione di esclusione sociale.
Cose da fare e da non fare
L’incapacità di ragionare seriamente sulla relazione tra scuola e società finisce per essere il limite strutturale de Il danno scolastico. Esiste una crisi dell’educazione che è attribuita alla scuola perché questa fatica ad adeguarsi ad un Novecento terminato; ma esiste una crisi nell’educazione che deriva dalle caratteristiche peculiari della contemporaneità. Le questioni cognitive poste dagli autori non si risolvono con l’esigere lo studio o in tasso di selettività maggiore. La realtà è che non si risolvono nei perimetri dell’attuale sistema dell’istruzione. Ha scritto lucidamente Walter Tocci: «Il contemporaneo implica una ricomposizione complessa del rapporto tra formazione e vita. Emerge l’esigenza di un’educazione integrale per formare le persone di ogni età, per superare le classificazioni disciplinari e organizzative, per inventare la didattica del nuovo mondo, per riconoscere la molteplicità delle agenzie formative, per accogliere ciò che è già nelle mente dei giovani, per liberare il mondo vitale della scuola dalle bardature della burocrazia. Non è facoltativo imboccare questa strada, è una stringente necessità. L’educazione novecentesca ha raggiunto il suo apice e ora rischia di declinare se non ripensa il suo paradigma» (p. XII).
Si tratta allora di guidare il cambiamento e di non esserne sommersi, di tenere assieme l'istruzione di massa, con quella realmente democratica e inclusiva – il che richiede un cambio di passo e di mentalità in diversi segmenti e contesti –, che sia capace di rispondere ai bisogni educativi speciali non solo per via amministrativa e burocratica – il che richiede un’ulteriore disponibilità al cambiamento, formazione e ricambio generazionale nella classe docente. Attribuire alla scuola un progetto culturale autonomo, rigoroso e dialetticamente dialogante con il territorio, è possibile se e solo se si abbandona definitivamente il falso e infondato mito di un’età dell’oro che avrebbe vissuto l’istruzione in tempi remoti.







