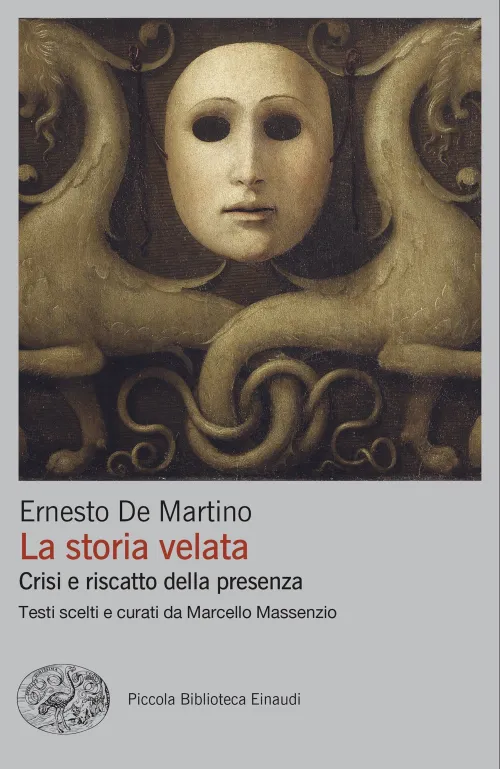Ernesto De Martino, l'angoscia della storia
Alcuni anni fa Goffredo Fofi ripropose nella sua collana Piccola Biblioteca Morale tre saggi di Ernesto De Martino (Oltre Eboli. Tre saggi, a cura di S. De Matteis, E/O, Roma 2021, che recensii su “Il manifesto” del 4 aprile 2021). In uno di essi, Note lucane, de Martino scriveva: “se la democrazia borghese ha permesso a me di non essere come loro, ma di nutrirmi e di vestirmi relativamente a mio agio, e di fruire delle libertà costituzionali, questo ha un’importanza trascurabile: perché non si tratta di me, del sordido me gonfio di orgoglio, ma del me concretamente vivente, che insieme a tutti nella storia sta e insieme a tutti nella storia cade… provo vergogna di aver io consentito che questa concessione immonda mi fosse fatta, di aver lasciato per lungo tempo che la società esercitasse su di me tutte le sue arti per rendermi ‘libero’ a questo prezzo, e di aver tanto poco visto l’inganno da mostrare persino di gradirlo”. Mentre nel saggio Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, osserva: “Il mondo popolare subalterno costituisce, per la società borghese un mondo di cose più che di persone, un mondo naturale che si confonde con la natura dominabile e sfruttabile… tale mondo, per la società borghese, forma problema quasi esclusivamente (e in ogni caso fondamentalmente) per conquistatori, agenti commerciali e funzionari coloniali, per prefetti e questori..”. Riporto qui queste considerazioni, pubblicate subito dopo (1949-50) Il mondo magico (1948) e nel periodo che intercorre tra questo libro e Morte e pianto rituale (1958), periodo in cui De Martino scrive gli appunti che Marcello Massenzio ripropone in E. De Martino, La storia velata. Crisi e riscatto della presenza (Einaudi, Torino 2025, pp. 181). In essi De Martino si interroga sulla presenza e sulla perdita della presenza.
Che cos’è la presenza? È la capacità di sapere mettere insieme nella coscienza tutte le memorie e le esperienze necessarie per rispondere a una determinata situazione storica. Questo implica il rovescio della medaglia e cioè la capacità di sapere escludere dalla coscienza ricordi che, rispetto all’azione in gioco, risultano essere inutili o addirittura dannosi (cf. La storia velata, p. 59).
Che cos’è la perdita della presenza? L’incapacità di sapere scegliere nei momenti di svolta storica dell’esistenza, nelle crisi come la nascita o la pubertà, la malattia e la morte, l’impulso sessuale, ma anche i conflitti morali, quelli poetici, il dubbio logico (cf.Ivi, p. 50).
Oggi e a partire dagli anni ’80 del ‘900, di fronte a una presenza che nega la stessa possibilità di una sua crisi e di una sua perdita, quelle autoriflessioni di De Martino apparirebbero inutili o addirittura dannose. La nostra, almeno fino al conflitto tra Ucraina e Russia e allo sterminio che Israele continua a perpetrare nei confronti dei palestinesi, è stata l’epoca della “fine della storia” e della “fine delle ideologie”, l’epoca cioè della negazione in un Occidente dove la democrazia (non a caso oggi in pericolo) e l’economia erano costruite al prezzo del dominio sulle civiltà non occidentali. Ironia della storia: Hegel parlava di una storia del mondo (Weltgeschichte) che da Oriente stava andando verso Occidente. Oggi assistiamo a un’inversione di marcia e, nello stesso tempo, a destra e a sinistra continuiamo, aggressivamente ma pateticamente, nella negazione di ciò che il vituperato ma lettissimo Spengler nel 1918 aveva chiamato Il tramonto dell’occidente.
L’umanità ha sempre cercato i modi per superare la perdita della presenza con i miti e con le religioni e con quel processo che Ernesto De Martino chiamò destorificazione, cioè un modo di resistere e di affrontare l’angoscia della storia che ha a che fare con la fine dell’esistenza e dunque con la morte e tuttavia nel solco della ricerca di una via d’uscita in avanti (a differenza del terrore della storia di Eliade, che invoca un ritorno). Come rispondere a ciò? Attraverso i miti e i riti che permettono l’uscita dalla storia e dal senso della sua irreversibilità per poi rientrarvi assicurando la reintegrazione delle donne e degli uomini nell’ambito di quella stessa storia da cui ci si era distaccati. Il Mondo magico viene pubblicato nel 1948, in un periodo cioè in cui l’interrogarsi sulla storia appariva come un compito filosofico prioritario. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l’Olocausto, dopo Hiroshima e Nagasaki, dopo la sconfitta del nazismo e del fascismo, cominciano a uscire libri come Origine e senso della storia di Karl Jaspers (1949), dove si teorizza il cosiddetto periodo assiale, Il mito dell’eterno ritorno di Mircea Eliade (1949), dove emerge il tema del terrore della storia organizzata secondo il tempo lineare, Significato e fine della storia di Karl Löwith (1949), dove emergono i temi dell’apocalittica. Un anno prima, il 1948, viene pubblicato appunto Il mondo magico che si potrebbe interpretare a sua volta anche come un interrogarsi sulla storia e sui rapporti che questa instaura nell’esistenza umana. Sono anni di riflessione creativa da parte di De Martino, e Marcello Massenzio lo fa vedere molto bene. Si tratta di appunti di grandissimo interesse, che erano stati pubblicati originariamente (e il curatore lo segnala) in E. De Martino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, sempre a cura di Marcello Massenzio (Argo, Lecce 1995). A ciò si aggiungono in appendice due saggi (Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto e Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni, il primo del 1953, il secondo del 1957). Queste riflessioni demartiniane andrebbero messe in relazione con gli Scritti filosofici (a cura di R. Pastina, Il Mulino, Bologna 2005), anch’essi appunti e citazioni da testi. L’insieme aiuta a capire un nodo centrale della sua ricerca che si caratterizza in quella che a prima vista può essere considerata un’ambivalenza fra elementi in apparenza inconciliabili: lo storicismo di Benedetto Croce da un lato e un Heidegger (lo Heidegger di Essere e tempo), che, filtrato da Paci e da Abbagnano, oscilla tra la fenomenologia e l’esistenzialismo (e la psichiatria esistenziale). Ma si tratta in realtà di un’ambivalenza tesa a dare unità all’interpretazione che De Martino offre del rapporto drammatico tra presenza e crisi della presenza, tra storia e destorificazione come processi che portano alla reintegrazione degli uomini nel mondo, proprio ciò che veniva in fondo negato dalla filosofia nichilista. Qui la riflessione filosofica si intreccia con la riflessione politica. I miti e i riti sono stati la risposta a quella condizione del nulla che è la morte individuale la quale viene reintegrata socialmente e storicamente proprio nel momento in cui se ne riconosce il senso di annientamento e lo si trascende con la creazione simbolica e collettiva. La riflessione di De Martino, inutile sottolinearlo, è straordinaria e Marcello Massenzio ha finora fatto un grande e ben riuscito sforzo per cercare di restituire al meglio la complessità del suo pensiero.
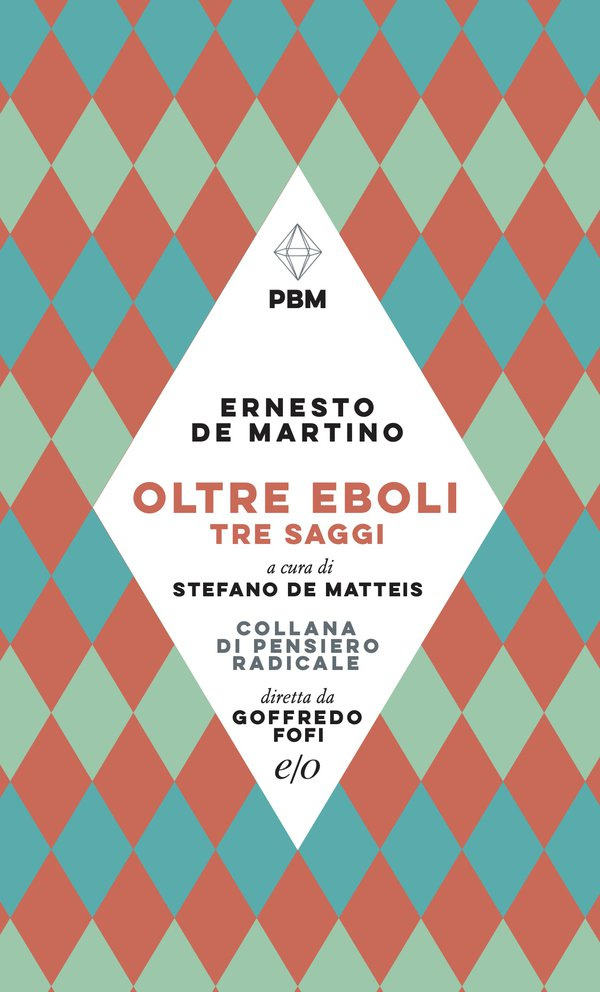
Ma proviamo a uscire dall’epoca storica in cui operava De Martino e torniamo al qui e ora, nel bel mezzo delle ideologie che, a partire dagli anni ’80 del ‘900, hanno dominato, nell’Occidente e in particolare nell’Europa protetta dalla NATO e quindi dagli USA. Ideologie, quelle del feroce e terreo ottimismo neoliberista, della fine della storia, come si è già detto, del “non c’è alternativa”, che ora sembrano dissolversi in un vuoto di pensiero alternativo, dopo così tanti anni di pace nel proprio territorio (ma non altrove), messe in crisi dal ritorno al tempo della guerra. Ideologie della libertà e della democrazia governate e dominate dal successo e dell’individualismo che mostrano l’altra loro faccia, quella del cinismo verso i più deboli e più fragili, quella dell’indifferenza verso la morte di bambini innocenti, annegati o trucidati o fatti morire di fame.
Che ne è oggi della crisi della presenza? Che ne è oggi della morte individuale come fatto collettivo? Che ne è oggi della destorificazione? Prendiamo la crisi della presenza. Nel nostro tempo attuale essa è nell’ansia, nell’angoscia e nel panico che colpisce donne e uomini, adulti e adolescenti, ma donne e uomini, adulti e adolescenti sono tutti isolati e connessi. Solo che la connessione non è la relazione. È invece quel tipo di legame che sorge quando è sparito il senso di appartenenza e di comunità e può mantenersi grazie all’isolamento individuale. L’ansia, l’angoscia e il panico non hanno più a che vedere con la collettività e meno che mai con la storia. Sono forme di sofferenza individuali che si curano, se si curano, nella solitudine. E quest’ultima ha bisogno della negazione della morte come fatto sociale e collettivo. La negazione della morte, in una società come la nostra che ha impoverito la drammaticità collettiva di quei riti di passaggio di cui parlò Arnold Van Gennep trasformandola nell’ansia degli esami e dei concorsi, rituali di passaggio sì, ma nel quadro della nostra cultura basata sull’idea che il sapere si identifica con il culto della competenza e con il principio dell’esattezza. Esami e concorsi sono il sintomo della miseria spirituale della nostra epoca dove i curricula degli studenti sono misurati dai crediti e dai debiti, perché tutto deve essere misurato dal denaro. Arriviamo a pensare che l’infelicità sia una malattia e pensiamo di curarla con i farmaci, perché abbiamo bandito l’idea che la sofferenza è una inevitabile condizione della vita e non qualcosa da negare così come si nega la morte. Niente apocalissi dunque nella nostra epoca e nessun bisogno apparente di essere reintegrati ritornando alla presenza dopo l’esperienza della sua crisi. La stessa crisi della presenza è negata. Del resto se si è realizzata la fine della storia e se la si è realizzata senza apocalissi, non abbiamo più bisogno di passato né di futuro. Possiamo vivere in un eterno felice presente alla ricerca del successo e della ricchezza.
Non abbiamo più bisogno di De Martino dunque? O forse è vero il contrario? Ne abbiamo più che mai bisogno! Perché questo accecamento occidentale collettivo che ci sbarra il futuro in quanto non c’è alternativa e ci chiude il passato in quanto non riusciamo ad accettare l’irreversibile, cioè la morte, sta trasformando la nostra civiltà nella peggiore barbarie. Abbiamo cominciato il secolo scorso con il fascismo e il nazismo, e stiamo continuando a perpetrare la nostra ferocia capitalista in nome della libertà e della democrazia. De Martino cercava di comprendere quali erano le forme di reintegrazione sociale di fronte al dramma della crisi della presenza, in una chiave che protendeva verso l’idea di una società futura, libera e egualitaria, capace di confrontarsi con la storia anche quando ne usciva attraverso i miti e i riti. Ma queste forme oggi sembrano scomparse oppure, come le religioni, sono in crisi e in difficoltà. Annaspiamo nel presente come tra i flutti di un mare inquinato, perpetrando violenze non dichiarate, eppure stiamo lì tra una pubblicità e l’altra a rappresentarci un mondo come un supermercato dove puoi soddisfare ogni bisogno e ogni desiderio. Ma non è così. Eppure continuiamo a negare, partecipando a riti che non sono avvertiti come tali. Come i prigionieri della caverna di Platone non sappiamo di non sapere e continuiamo ad assistere, come il Serafino Gubbio di Pirandello che riprende ciò che accade senza intervenire, allo spettacolo della riduzione degli uomini a merci.
Se vogliamo riprendere l’insegnamento di Ernesto de Martino, dobbiamo tornare a essere osservatori criticamente interni al nostro contesto di osservazione, prendere partito come faceva De Martino e recuperare il senso della storia nel suo conflitto permanente tra collettività e individualità. Riprendere da Vico ciò che mancava a Croce: l’idea che la storia è storia collettiva e ricollegarla alla complessità delle storie individuali. Comprendere il richiamo a Heidegger come riflessione sulla crisi della presenza al cui interno si gioca il dramma del rapporto tra condizione collettiva e condizione individuale dell’esistenza. Dopo il disastro del cosiddetto socialismo reale che ha distrutto le libertà individuali e nel marasma del capitalismo reale che sta devastando ogni possibilità comunitaria e collettiva, le considerazioni di De Martino sul drammatico rapporto tra storia collettiva e storia individuale restano un punto di vista di cui non dovremmo fare a meno.
Leggi anche:
Claudio Piersanti | De Martino, ritorno alla terra del rimorso
Giovanni Pizza | Pavese e De Martino. Lettere sulla Collana viola
Pietro Pascarelli | Il mondo deve continuare, ma può finire