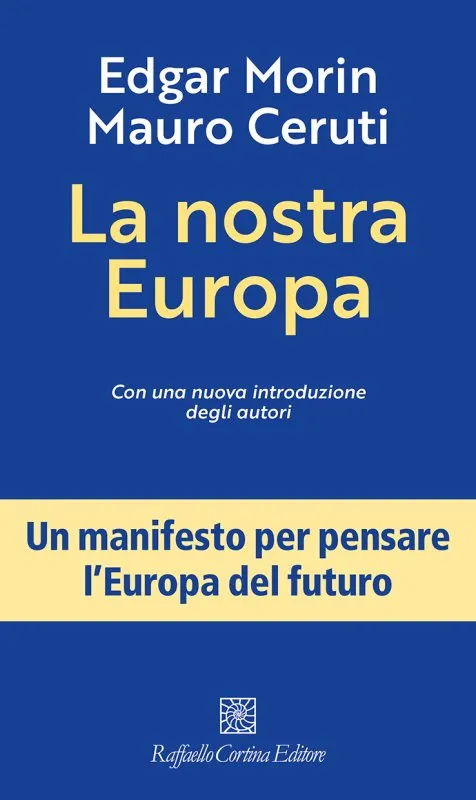Morin, Ceruti: l’Europa multicolore
Il destino dell’Europa si è sempre deciso e si deciderà ancora nella lotta tra le forze di dissociazione, di rottura, di esasperazione degli odi nazionali, etnici, religiosi e le forze di associazione, di solidarietà e di confederazione. L’ultimo teatro in cui si è consumata questa lotta è stato, negli anni Novanta, la ex-Jugoslavia e, in particolare, la Bosnia-Erzegovina, che per l’integrazione multisecolare della sua varietà religiosa ed etnica appariva la prefigurazione concreta del sogno europeista, e, più di recente, l’Ucraina, dopo l’invasione della Crimea nel 2014 fino all’offensiva del 2022.
Dopo la tragedia di Sarajevo e di fronte alla tragedia di Kiev, si tratta di tenere vivo il senso della missione dell’intelligenza europea. La missione dell’intelligenza europea è di dire sì nel contempo alle sovranità e alle associazioni. L’Europa “una e molteplice” deve coniugare e mai dissociare: il diritto dei popoli; il diritto delle minoranze; il diritto degli individui; il diritto dell’Europa stessa che è quello dell’associazione.
È il messaggio fondamentale che ci consegnano Edgar Morin e Mauro Ceruti, gli autori di La nostra Europa, riproposto da Raffaello Cortina in una nuova edizione, a dieci anni dalla prima, con la consapevolezza del rischio di dismissione che corre sempre l’intelligenza europea.
Dal Trattato sulla Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) del 1951, l’Europa post-nazionale è in cammino da più di settant’anni. Per lungo tempo, si è posizionata tra due mondi: il mondo collettivista dell’Unione Sovietica e dei suoi satelliti e il mondo individualista degli Stati Uniti d’America. Ha raccolto tanti successi, ha subito anche battute d’arresto, ma, soprattutto, ha garantito che quei due mondi non precipitassero in una collisione fatale per l’umanità.
Oggi, la “barca” europea si trova a fluttuare in un mondo dove risorgono pulsioni autoritarie e imperiali, sia a Oriente sia a Occidente. Nel ribadire il rifiuto di ogni forma di dittatura o autocrazia, di suprematismo culturale o egemonia, anche al suo interno, l’Europa post-nazionale si trova a interrogarsi sulla necessità di riaffermare coraggiosamente e consolidare la propria esistenza, per se stessa, ovvero per gli Stati che la compongono, e per il mondo, o a rischiare di perire, con conseguenze catastrofiche per se stessa e per il mondo.
E, preliminarmente, deve difendersi dal contagio di quelle pulsioni esterne a essa, non tanto per la propaganda “euroscettica” che può alimentare, ma per gli effetti di disgregazione e di decivilizzazione che produrrebbe il ricomparire di “mostri” sopiti del Novecento nella forma di demagogismi illiberali, populismi xenofobi e di fanatismi nazionalisti.
Di fronte al pericolo di regressione si deve rammentare che uno dei meriti storici del progetto dell’Unione europea, nell’Europa occidentale, poi allargato a una parte dell’Europa centro-orientale dopo il crollo del Muro di Berlino, è stato di voler superare non le patrie o gli stati nazionali di cui si trattava di limitare i poteri, ma di voler superare le due malattie che avevano portato l’Europa al rischio dell’autodistruzione: la purificazione etnica e la sacralizzazione dei confini.
Ogni “ripartenza” dell’Unione europea, ogni riformulazione ambiziosa del suo progetto, non può prescindere allora, anzi può solo giovarsi, dal ripercorrere la memoria storica della sua identità culturale complessa e del suo patrimonio di valori e di ideali. Da questa convinzione nasceva questo libro, scritto dieci anni fa, e da essa nasce il senso della sua riproposta.
La nozione di Europa deve essere concepita secondo una multipla e piena complessità. L’Europa è una nozione geografica senza frontiere con l’Asia e una nozione storica dalle frontiere cangianti. È una nozione dai molteplici volti che non si potrebbero sovrapporre l’uno sull’altro senza creare l’indistinto. È una nozione soggetta a trasformazioni che si è metamorfosata due volte in modo stupefacente dopo la caduta dell’Impero romano, la prima nel XV-XVI secolo, diventando l’Europa delle nazioni, la seconda esattamente a metà del XX secolo, passando, anche se in parte, dall’Europa all’EU-ropa. L’Europa possiede unità solo nella e attraverso la molteplicità. Sono le interazioni tra popoli, culture, classi, Stati, che hanno tessuto una unità essa-stessa-plurale e contraddittoria.
Nel corso di tutta la storia d’Europa, non è mai esistito nulla di simile a una “fortezza Europa” o a invalicabili barriere che separassero l’interno dall’esterno. Al contrario, la storia d’Europa è tessuta dalle tante relazioni fra le più varie culture e civiltà che si sono dette europee e molte altre culture e civiltà dalle varie origini e collocazioni. Le identità delle varie nazioni o etnie europee il più delle volte sono intrecci di culture molto diverse, e proprio attraverso tali intrecci esse rigenerano la loro vitalità e capacità coesiva.
Insomma, è “l’Europa vestita di piccoli fuochi multicolori”, decantata e vagheggiata con passione da Guillaume Apollinaire in una sua celebre poesia: À travers l’Europe.

L’Europa moderna si è auto-costituita in un caos genesico dove si sono annodate insieme potenze di ordine, di disordine e di organizzazione. L’Europa esiste, fino agli inizi del XX secolo, solo nelle divisioni, negli antagonismi e conflitti che, in un certo modo, l’hanno prodotta e preservata. L’Europa metanazionale del 1945 era nata dalla Resistenza alla barbarie nazista e dalla difesa contro la barbarie stalinista. Un’Europa è morta nel 1945, schiacciata sotto le rovine delle nazioni vinte o liberate da vincitori e liberatori divenuti nel frattempo le superpotenze mondiali. C’è voluta la morte dell’Europa dei tempi moderni perché ci fosse un primo voler nascere europeo. Questa Europa Morin racconta nel suo romanzo giovanile, in parte autobiografico, scritto immediatamente dopo la fine della guerra, intitolato: L’anno ha perso la sua primavera, da poco dato alle stampe per la prima volta dall’autore (in Italia è edito da Guanda, con la traduzione di Silvia Turato).
Oggi, l’unità europea vive nell’eterogeneità, nell’unitas multiplex, la sua identità nella non-identità.
La complessità è stata la sua storia. Storia politica, economica, letteraria, filosofica, sociale, etnica, fatta da straordinarie invenzioni comuni ma anche di drammatiche e violente rivalità, fino all’abisso delle guerre mondiali. Dal secondo dopoguerra, la complessità è il suo progetto intenzionale. Il suo progetto di convivenza, contrapposto al semplicismo brutale e omologante dello spirito totalitario, imperiale e autocratico. Edificata sulla coscienza delle ambiguità del progresso, dopo le tragedie storiche del primo Novecento, l’Europa unita e post-nazionale ha imparato a sperimentare la sintesi tra libertà e giustizia, a umanizzare la modernità, a irradiare pacificamente e dialogicamente i suoi valori umanistici e illuministici nel mondo.
C’è stato un mondo che si è ribellato all’Europa imperialista, colonialista, razzista, in nome dei principi e degli ideali europei. C’è un mondo che promuove le sue lotte per l’emancipazione o di resistenza in nome dei principi e degli ideali europei. C’è un mondo che vuole competere con l’Europa, sviluppando la scienza e la tecnica nate in Europa. C’è un mondo che emigra per raggiungere l’Europa e vivere nelle sue “società aperte”. Così, dopo la seconda guerra mondiale, nell’impotenza l’Europa ha scoperto la sua potenza, nel disarmo ha scoperto la sua forza, nel ripudio della guerra come strumento di aggressione e di conquista ha scoperto l’influenza basata sulla sua gentilezza e sulla sua tranquillità.
Su questa “potenza” tranquilla e “forza” gentile, pur senza avere un esercito comune, l’Europa unita ha consolidato la sua pace e coesione interna. E, anche nel caso di una ormai necessaria e improcrastinabile politica estera di sicurezza e di difesa comune, nella nuova situazione internazionale, è sempre e soprattutto su di esse che l’Unione europea dovrà costruire la sua autonomia e la sua presenza nel mondo, proteggendosi dagli imperialismi complici o antagonisti che la minacciano dall’esterno e dalle destre populiste e autoritarie che la minacciano dall’interno e vorrebbero fermarne la marcia.
Oggi l’Europa è chiamata a unirsi di più per conservare meglio le sue diversità nella libertà, nella pace, nella prosperità. Senza Unione europea, più forte, più “sovrana”, l’Europa degli Stati-nazione sarebbe destinata oggi a diventare come l’Italia dei Comuni nel Basso Medioevo; un mosaico di piccoli e insignificanti Stati nel gioco planetario, in contrasto tra loro e alla ricerca di tutele da parte delle potenze globali del mondo.
La nuova metamorfosi di cui ha bisogno l’Europa per salvarsi e tenersi unita, dicono Morin e Ceruti, sarà figlia dell’improbabile o non sarà. Improbabile non significa impossibile. Ma significa che se vogliamo credere nella possibilità di un’Europa più integrata politicamente, che torni a disegnarsi e a giocare un ruolo appropriato, dobbiamo smettere di illuderci che questa sia figlia dell’inevitabilità. Come se fosse, cioè, la conseguenza inevitabile dell’unificazione economica o monetaria. Un obiettivo politico può essere raggiunto solo con mezzi politici.
Allora, non rimane che andare avanti con determinazione, convinti che, come diceva un convinto federalista europeo come Denis de Rougemont, “gli scettici ci daranno ragione, i disfattisti avranno perduto come meritano, i nazionalisti faranno l’opposizione, indispensabile a ogni regime democratico”. E il progetto di una federazione europea avrà senso per i veri “Europei”, educati all’universalismo, solo se concepito come il primo passo per una federazione mondiale.
Sebbene respinta alla periferia della storia, sebbene sia divenuta una semplice provincia del mondo, e anzi proprio per questo, secondo Morin e Ceruti, l’Europa deve portare in sé la coscienza dei problemi planetari. Risorge in questa veste, l’ideale internazionalista di fraternità che il giovane Albert, combattente della Resistenza, protagonista del menzionato romanzo giovanile di Morin, coltiva e per il quale morirà fucilato dalle forze di occupazione naziste. La nostra Europa è anche il tributo che Morin rende ai tanti Albert, ai tanti suoi compagni della Resistenza, che, a differenza di lui, non sopravvissero e col loro sacrificio resero possibile la “primavera” europea dopo un lunghissimo inverno di guerre fratricide.
Leggi anche:
Alfondo Maurizio Iacono | Morin, la vita nell'opera
Francesco Bellusci | A trent’anni da “Terra-Patria” di Edgar Morin
Francesco Bellusci | Edgar Morin: Svegliamoci!
Vanni Codeluppi | Cento anni di Edgard Morin