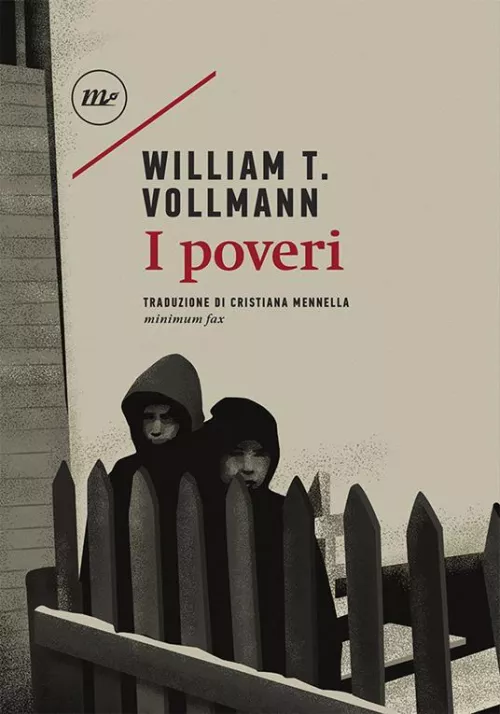Fotografia sociale / William T. Vollmann, I poveri
Possiedo un computer (usato), un IPad (regalato), un Kindle di seconda mano, uno smartphone, un abbonamento mensile a Sky e uno con Amazon Prime. Pago l’affitto di una stanza in una casa condivisa, ho qualche soldo sul conto in banca, vado ogni settimana in palestra e dallo psicologo. Mi considero povera. Mi sono sentita precaria tutta la vita: la mia famiglia non ha una casa di proprietà né risparmi da parte, e io stessa ho vissuto negli ultimi dieci anni di contratti a tempo determinato senza ferie né malattie. Ho tirato la cinghia durante la pandemia riducendo le spese al minimo, e innumerevoli volte mi sono trovata a fare la fila al Caf di fiducia per avere aggiornamenti sugli aiuti erogati dallo Stato. Devo pertanto dedurre che gli sporadici selfie che posto sui social possano rappresentare l’immagine della povertà?

La fotografia sociale intende dare voce e volto a vite relegate ai margini, rendendo letteralmente visibile l’invisibile. Ciò sottintende un rapporto di potere fra il fotografo e il soggetto, che esiste per il mondo solo tramite il mirino della macchina fotografica. Non sono i poveri a raccontarsi direttamente; non ne hanno il tempo né la forza, presi come sono dall’urgenza di sopravvivere. Chi vuole testimoniarne le esistenze deve avere i soldi per farlo; sarebbe pertanto onesto quantomeno che includesse questo paradosso nella sua narrazione. Così fa William T. Vollmann nel suo libro-reportage I poveri edito da Minimum Fax (traduzione di Cristiana Mennella). Il primo riferimento è all’opera fondamentale di James Agee e Walker Evans, che nel 1936 furono mandati in Alabama dalla rivista Fortune a ritrarre la vita dei contadini in fotografie poi incluse nel libro Sia lode ora a uomini di fama (il Saggiatore, traduzione di Luca Fontana):
“È un successo perché fallisce. Fallisce perché si fonda su due ricchi che osservano la vita dei poveri (…) Di conseguenza Agee diventa sincero al punto di disprezzare sé stesso, mentre Evans si rifugia nel silenzio rivelatore della fotografia. Una foto vale mille parole, senza dubbio, ma mille parole quali? Useremmo tutti la stessa didascalia? Un povero vi fissa da una pagina. Non arriverete mai a conoscerlo. “
Consapevole di questo dato, Vollmann gira il mondo per fare alle persone indigenti di ogni nazionalità la stessa domanda: perché sei povero? L’autore non si limita a descrivere le risposte che riceve, ma intrattiene un dialogo personale con sé stesso facendosi domande sulle condizioni di vita delle persone intervistate, sui motivi di tali condizioni e sul proprio ruolo rispetto ad esse. Sembra inevitabile rilevare nel rapporto tra Vollmann e i suoi soggetti una latente ma costante distanza data dalle diverse capacità economiche. Questa estraneità include il lettore che legge il testo e guarda le immagini del libro sapendo di rapportarsi a quello che il contesto narrativo chiaramente definisce come i volti della povertà.

Le immagini appaiono quasi stereotipate nel definire la precarietà di mezzi tramite visi precocemente invecchiati, avviliti, mal vestiti. La prima reazione è di doverosa compassione, pur nell’idea che sia cosa che non ci riguardi; latente giace un senso d’ansia all’idea – visti i tempi – di incappare nella stessa situazione. Eppure, come già detto sopra, io mi considero povera, riconosco quel senso di insicurezza costante come parte integrante della mia esistenza. Ciò nonostante già solo il fatto di poter possedere il libro di Vollmann mi pone in uno stato di incomprensione rispetto a ciò che vedo. La fotografia acquista senso tramite chi ne fa esperienza, ed è difficile non notare come i soggetti fotografati da Vollmann siano probabilmente proprio coloro che non avranno mai la possibilità di vedersi nelle pagine stampate. Come potrebbero permetterselo?
I poveri è un libro che, lungi dall’offrire risposte, pone infinite domande al lettore. Che cosa definisce il concetto di povertà? Quali sensazioni, considerazioni, eventi sono peculiari di questo stato? Le fotografie sono la metafora visiva di queste domande, e conducono a una seconda reazione conflittuale: ci si interroga sul livello di coinvolgimento personale rispetto alla relazione sfruttatore/sfruttato nella società, rilevando come spesso si vivano entrambi i ruoli a livelli diversi. Le difficoltà economiche di alcuni (tra cui la sottoscritta) si concretizzano nell’esigenza di acquisire beni di basso costo prodotti tramite manodopera sottopagata e scarsamente tutelata (si veda a tal proposito il bellissimo saggio Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa di Valentina Furlanetto per Laterza). Lo squilibrio sociale che ne deriva sembra rendere impossibile ogni rivoluzione perché chi la invoca è in parte inconsciamente responsabile delle ingiustizie perpetrate, in quanto sopravvissuto anche grazie al lavoro di persone ancora più sfruttate di lui.

Vollmann suggerisce una serie di fattori che possano identificare le dinamiche dell’emarginazione economica: la vulnerabilità, il torpore, i frequenti ricatti morali subiti, l’a-normalità come assenza di ciò che ci accomuna agli altri, come la stessa distanza presente fra le immagini e chi guarda. Sembra normale, allora, che ci appaiano lontane, respingenti o falsamente commoventi, quasi che la fotografia voglia solo confermare i nostri pregiudizi, riassumibili nel concetto “è triste, ma non parla di me”. Il che potrebbe significare la capacità di identificare la povertà solo in un’immagine ben precisa, e la conseguente incapacità di saper rappresentare o riconoscere visivamente le difficoltà esistenziali presenti entro la nostra scintillante società dei consumi.
Incomplete, ingannevoli, irrisolte, prevedibili e tuttavia disturbanti, le fotografie di Vollmann offrono al lettore una potenziale ferita emotiva fatta di contraddizioni tra compassione e senso di colpa, indignazione e cinismo. Sono domande aperte, punti interrogativi visivi che possono guadagnare un senso solo se chi guarda è disposto ad offrire a sua volta risposte diverse dal semplice pietismo di chi si sente non solo al sicuro, ma anche – illusoriamente – dalla parte dei forti e dei giusti. Nei fatti, si tratta solo di aver avuto la fortuna di occupare il penultimo posto nella classifica della sopravvivenza, piuttosto che l’ultimo.