Miteni: gli inquinanti eterni e la sentenza
La grande mobilitazione popolare, politica e scientifica che ha portato alla storica sentenza sulla Miteni di Trissino (Vicenza), la “fabbrica dei Pfas”, dello scorso 26 giugno, tuttavia preceduta da almeno un’altra molto importante il mese prima, è raccontata nelle sue origini e nel suo significato, da un libro molto bello di Alberto Peruffo, alpinista, scrittore e libraio, attivista fra i principali del movimento: Non torneranno i prati. Storie e cronache esplosive di Pfas e Spannoveneti (Cierre edizioni, 2019, 2021). Per sapere cosa siano i Pfas, si possono invece vedere due testi specifici: PFAS. Gli inquinanti eterni e invisibili nell’acqua. Storie di diritti negati e cittadinanza attiva (Altreconomia, 2024) di Giuseppe Ungherese e PFAS. Una contaminazione persistente, pervasiva e pericolosa, a cura di Vincenzo Cordiano e Vitalia Murgia (ISDE Italia, 2024). In sintesi, i Pfas sono un complesso di circa 4700 sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (Pfas, appunto), utilizzate in diversi settori. Sono definite “sostanze chimiche permanenti”, o anche “inquinanti eterni” o forever chemicals, poiché persistono nell’ambiente e negli organismi, compreso il nostro, di cui danneggiano soprattutto fegato, testicoli e tiroide, provocano obesità, problemi di fertilità, tumori.
L’importante sentenza precedente, è dello scorso 13 maggio, quando in sede civile il tribunale di Vicenza ha riconosciuto che il tumore al rene che aveva colpito un operaio, Pasqualino Zenere (deceduto nel 2014), era correlabile al suo lavoro alla Miteni dal 1979 al 1992. Il riconoscimento è importante per gli effetti che può comportare rispetto ad altri casi simili, ma anche perché attira l’attenzione sull’impatto sulla salute dei lavoratori interni all’azienda, oltre che sui guasti ambientali e alla salute dei residenti. Il movimento ha sempre riconosciuto questa trasversalità e generalità del danno. Nel mondo del lavoro, soprattutto nel sindacato, si è invece a lungo stentato ad accettarlo e il conflitto tra lavoro e ambiente e salute si è prodotto anche qui come già in altre aree (Porto Marghera, Taranto, Gela…). Ma la convergenza è infine avvenuta e la sentenza del 23 maggio ne rileva il fondamento: la lotta aveva una motivazione comune, niente era ed è più importante che opporsi insieme a chi devasta l’ambiente e la vita. Non a caso il soggetto collettivo più noto del movimento è il gruppo delle “Mamme No Pfas” protagoniste a partire dalla volontà di tutelare i propri figli e la maternità insidiata. Le due sentenze vanno perciò lette insieme. Una riguarda chi ha lavorato dentro la fabbrica, l’altra chi ci ha vissuto intorno insieme all’ambiente naturale in cui essa ha scaricato reflui ed emissioni. I corpi, l’acqua e l’aria sono le prede e le vittime ontologiche, per così dire, del tipo di sviluppo di cui la Miteni è un caso esemplare.

Per questo ha valore storico questa doppia sentenza, in particolare quella del 26 giugno con cui la Corte d’Assise di Vicenza ha condannato in primo grado undici manager della Miteni per inquinamento e avvelenamento doloso prodotti dal rilascio di sostanze nocive, in particolare Pfas, il cui impatto profondo si riconosce avere riguardato almeno tre province (Vicenza, Verona e Padova) abitate da centinaia di migliaia di persone. Un inquinamento generato localmente ma che è andato molto lontano.
Anche la storia della Miteni viene da lontano. Inizia nella Valle dell’Agno, sotto le Prealpi venete, dove due secoli fa la famiglia Marzotto avvia le sue celebri industrie tessili. Nel 1965 a Trissino apre un laboratorio sul trattamento dei tessuti, la Ricerche Marzotto Spa (la Ri.Mar.). Non passa un anno e vi fuoriesce una nuvola di acido fluoridrico – come se si fosse a Porto Marghera e non in una verde vallata – che brucia per sempre la vegetazione di parte della collina. Prati che non torneranno, appunto. La Ri.Mar. viene allora decentrata in un’altra proprietà Marzotto, tra Trissino e Montecchio. I Pfas sono molto redditizi, difficile rinunciarvi: si calcola che un chilo di Pfas valga sul mercato quanto mezzo chilo d’oro.
Quello in cui si sposta la Ri.Mar., però, è un luogo in cui la falda acquifera, da sempre, si ricarica con le piogge e i corsi d’acqua, così che, più a valle, contribuisca alle altre falde a cui attingono anche i pozzi per gli usi umani. I problemi, quindi, non tardano a emergere. A Trissino, a metà degli anni Settanta, il sindaco chiude alcune vasche di lavorazione della Ri.Mar. perché la terra vi risulta contaminata. Sul finire del decennio, gli acquedotti di alcuni comuni vengono chiusi per contaminazione e gli abitanti approvvigionati con autobotti. Seguendo il corso che scaturisce da una sorgente carsica le acque avvelenate giungono nel fiume Retrone, verso Vicenza, dove nel 1979 vengono chiusi alcuni pozzi. La Ri.Mar. è costretta a sospendere le attività per quasi un anno e mezzo. Al tempo stesso, però, un processo a suo carico finisce in niente e addirittura l’azienda può potenziare le attività.
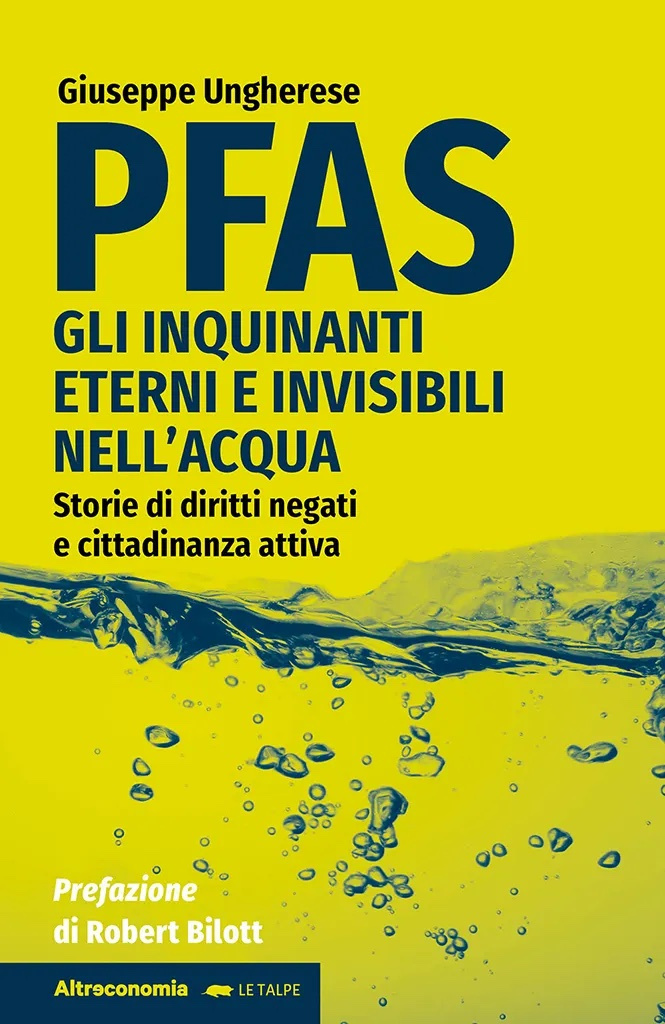
Nel 1985 entra nella società la Enichem Syntheis Spa e, in seguito, anche la Mitsubishi Italia Spa. Insieme, nel 1988, costituiscono la Mit-Eni Srl, nel 1994 sottoposta alla Direttiva Seveso, che classifica le attività più pericolose (nel suo caso, per i fluoroderivati che utilizza). Cominciano anche le prime denunce politiche, ma le responsabilità vengono fatte rimbalzare tra Comuni, Provincia, Regione e Ministero, mentre l’azienda – acquisita quasi totalmente dalla Mitsubishi Corporation nel 1996 – procede indisturbata. È solo nel 2010 che, a conclusione di uno studio condotto con fondi europei nelle valli del Chiampo e dell’Agno, viene documentato un grande aumento dell’inquinamento da sostanze rilasciate dalla Miteni. Anche se vi si cita uno studio di un esperto dell’Arpav, l’agenzia regionale non darà seguito a quanto riscontrato. Miteni, intanto, propone di realizzare dei “pozzi barriera” per evitare la contaminazione della falda, ma lo fa in modo inadeguato, senza che le autorità di controllo lo segnalino, soprattutto nel cruciale decennio 2000-2010, nel corso del quale ben altra attenzione sarebbe stato necessario dedicare alla situazione.
Nel 2009 la proprietà passa alla ICIG (International Chemical Investors Group) della multinazionale belga e tedesca WeylChem, che acquisisce la Miteni alla cifra simbolica di un euro. Bei tempi quelli in cui il valore di mercato dei Pfas si misurava a peso d’oro. Il passaggio di proprietà avviene mentre la nocività (cancerogena) dei Pfas viene documentata a livello internazionale e la loro presenza nei corsi d’acqua in Italia (compreso il Po) risulta sempre più diffusa. Nel 2011 due ricercatori del Cnr-Irsa, Polesello e Valsecchi, prelevati campioni d’acqua di scarico dell’azienda, vi certificano la più alta concentrazione al mondo di quegli inquinanti. Idem in altre zone contermini. Malgrado siano accompagnati da un tecnico dell’Arpav, le autorità si muoveranno soltanto due anni più tardi, nel 2013, dopo che l’Istituto Superiore di Sanità informa dell’emergenza le autorità del Veneto (le quali, però, tramite l’Arpav potevano ben esserne al corrente da tempo). Sembra un passo verso un maggiore controllo e maggiori vincoli. Invece accade l’opposto: nel 2014 le autorità presenti in una Conferenza di servizi a ciò dedicata – Regione, Provincia, Comune, Consorzio di bonifica – concedono alla Miteni un’ulteriore Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per passare dalla produzione di Pfas di nuova generazione (GenX e C604, ricavati da rifiuti tossici), senza peraltro modificare gli impianti. Nel 2017, poi, la Regione autorizzerà l’azienda a realizzare un inceneritore (un “cogeneratore”, detto pudicamente) per aumentare la potenza produttiva, così aggredendo anche l’aria con le emissioni oltre che l’acqua con gli scarichi e i corpi con la contaminazione. Un ciclo completo di avvelenamento.
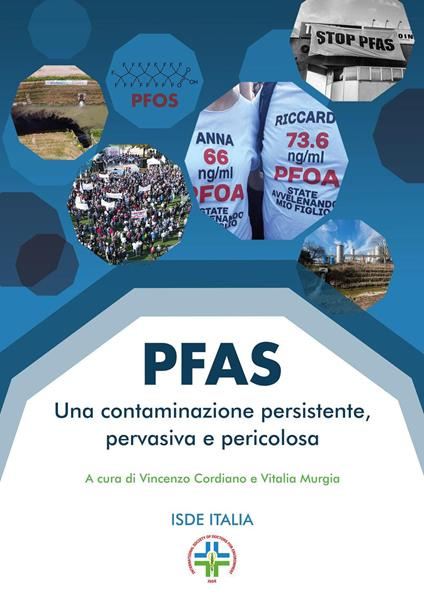
Nel 2021, l’Alto commissario per i diritti umani dell’Onu, Marcos Orellana, in una missione sulle sostanze tossiche, attesta che nel Veneto centrale, a causa di questo inquinamento, sono stati violati diritti umani, in luoghi che verranno definiti “zone di sacrificio ad alto reddito” o in cui si produce “ricchezza a fondo perduto”, senza pensare alle conseguenze sul futuro.
Le banche stesse, fiutando il cambio di clima, chiudono alla Miteni che, infine, chiede il fallimento, decretato dal Tribunale di Vicenza il 9 novembre 2018 con la chiusura della fabbrica.
Tutto ciò, questa lunga e complicata storia di veleni e di cinismo industriale e di elusione, e a volte complicità, istituzionale, viene scandito dalla costante crescita del movimento popolare, politico e scientifico che ha imposto la verità, cercandola ed esponendola insieme a tecnici e scienziati (tutta la storia è documentata nell’indispensabile sito PFAS LAND). Un movimento che infine ha saputo unire settori all’inizio divisi, i lavoratori con i residenti, gli ambientalisti con i sindacalisti più consapevoli, creando le condizioni per vincere anche in tribunale. Dove, dunque, sono state riconosciute le responsabilità fondamentali per l’avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana, il disastro ambientale, l’abbandono di rifiuti, la bancarotta fraudolenta. Un crimine ecologico e un imbroglio economico: anche di questo intreccio dà conto la sentenza (anzi, le due sentenze, penale e civile) e di qui il valore storico, appunto, nel quadro dei processi per inquinamento in Italia.
Ora, forte di questa vittoria, il movimento chiede che i risarcimenti ottenuti dalle parti istituzionali vengano utilizzati per finanziare azioni concrete: uno studio epidemiologico partecipato sui danni alla salute, per la bonifica e il ripristino ambientale, per la rete idrica alternativa nelle aree contaminate. Chiede anche una legge nazionale con limiti prossimi allo zero tecnico per i Pfas nelle acque potabili e chiede che l’Italia si impegni in Europa per la messa al bando totale dei Pfas. Ancora una volta, un impegno generale, universale, contro l’eredità di quella “ricchezza a fondo perduto” perseguita senza scrupoli, a cui si oppone, come dimostra questa storia, un’altra coscienza, un’altra vitalità, umana e politica, capace forse di rigenerare, con la giustizia, anche quei prati perduti, infine.







