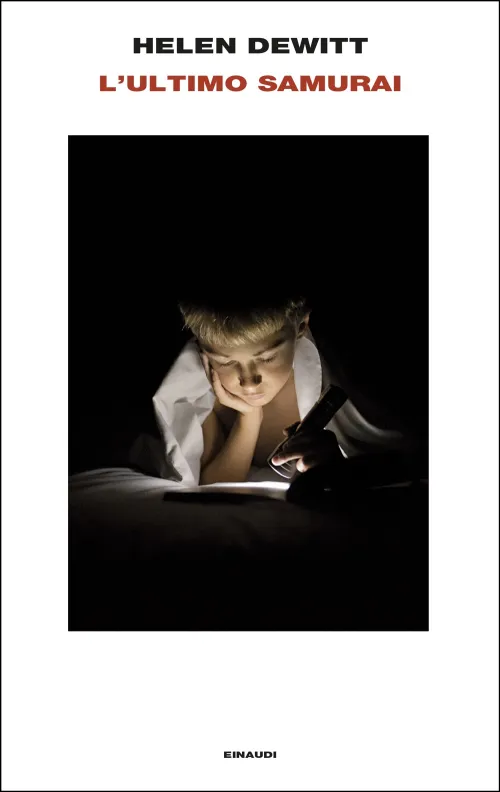Helen DeWitt: bambini prodigio
Nel 1986 la scrittrice italiana Angela Scarparo mette al mondo un bambino e lo chiama Ludovico, Ludo per la famiglia. Nel modo – per lei naturale – di vivere una genitorialità non convenzionale, gli dava la buonanotte leggendogli i versi della Divina Commedia (alternati, a volte, a Roald Dahl) e, appena il piccolo fu in grado di camminare, lo portava nei musei e alle mostre di arte antica, dove gli spiegava i quadri. Nel 1993 Scarparo pubblicò con Transeuropa Quando cresci in un piccolo paese, dove trasfigura sé stessa in Livio, un uomo che ha lasciato Milano e la moglie, un'affermata regista teatrale, per Roma, deciso "a fare solo il padre" del loro figlio che va alle elementari. Nathaniel Hawthorne, anche lui alle prese con un moccioso, ha descritto un'estate in campagna, nell'incantevole Venti giorni con Julian (1851), con un ritratto memorabile del figlio, un bambino di cinque anni che è un vero chatterbox, "un infaticabile produttore di parole e di domande", con le quali tormenta il padre durante il consueto tragitto mattutino per andare dal contadino a prendere il latte.
Nella prefazione al libro Adelphi del 2004, Paul Auster osserva che Hawthorne "è riuscito a compiere quello che ogni genitore sogna: far vivere il proprio figlio per sempre". Un altro indimenticabile Ludovico, anzi, Ludovic, abbreviato in Ludo – che non poteva aver ispirato Scarparo, poiché aveva partorito suo figlio molti anni prima della pubblicazione del romanzo di cui questo Ludo è protagonista, e che rende quindi curiosa la coincidenza – conquista ora i lettori, nella ristampa di L'ultimo samurai, dell'americana Helen DeWitt, con la paziente e accurata traduzione di Elena Dal Pra, autrice anche di una necessaria introduzione (Einaudi, 2025). Questo romanzo d’esordio di Helen DeWitt, pubblicato per la prima volta nel 2000 e oggi considerato un classico di culto, è un libro eccentrico, una sorta di tour de force dell’intelligenza narrativa. Protagonista, dicevamo, è Ludo, figlio di Sybilla e c'è una strana e inquietante risonanza tra il Ludo di Angela Scarparo, che esiste davvero (ma nel libro di Transeuropa si chiama Lorenzo), e questo inventato della DeWitt: entrambi i bambini, quello vero e quello finto, intellettualizzati precocemente, uno immerso fin da piccolissimo nelle rime dantesche e nella storia dell'arte, l'altro costretto dalla madre a vedere e rivedere I sette samurai (1954), il film di Akira Kurosawa, in lingua originale coi sottotitoli, per imparare, in un colpo solo, lingua, morale e disciplina; ma il Ludo della DeWitt legge anche – già a quattro anni – i classici greci e latini, testi scientifici e filosofici, ha consuetudine con Quine e Wittgenstein, impara a decifrare formule matematiche e strutture linguistiche complesse. "Non sarebbe meglio che giocasse a pallone?" è la considerazione che sua madre, una classicista brillante e inflessibile, si sente fare continuamente da conoscenti e sconosciuti che guardano perplessi il ragazzino con in mano l'Odissea.
Sybilla gli trasmette un'idea del sapere come gioco e spazio di libertà ma anche – e non importa se lui non lo sa – come forma di resistenza alla mediocrità. "C'è gente che ritiene la contraccezione immorale perché lo scopo dell'accoppiamento è la procreazione. Allo stesso modo, c'è gente che ritiene che l'unica ragione per leggere un libro sia scriverne uno; le persone dovrebbero far emergere i libri dalla polvere e dall'oscurità e scrivere fiumi di parole destinate ad essere inghiottite dall'oscurità e dalla polvere che possono essere richiamate in superficie in modo che altre persone possano creare altri fiumi di parole destinate a raggiungerle nell'oscurità e nella polvere", scrive a pagina 23, introducendo il lettore a quella "ricorsività" dei dialoghi e della scrittura, subito segnalata da Elena Dal Pra nell'introduzione, che vede in questi "anelli che paiono generarsi l'uno dall'altro" un rinvio alla Circle Line, la spiraliforme linea di metropolitana di Londra, città dove la coppia madre-figlio vive: Ludo si lascia spesso portare dai treni dell'underground, da capolinea a capolinea, più volte, immerso nella lettura, perché le carrozze sono calde mentre a casa il riscaldamento non c'è.
Ludo, bambino prodigio con un’intelligenza fuori scala, gioca con le lingue e con i libri e la sua fame insaziabile di sapere è uguale a quella che i bambini comuni hanno oggi per la playstation. Per sopperire all’assenza del padre e dare una direzione alla sua crescita, Sibylla gli fa vedere compulsivamente I sette samurai di Kurosawa perché, quel film, secondo lei, lo educherebbe a interiorizzare un comportamento "maschile". Sybilla racconta che Ludovic è nato da un unico incontro sessuale che ha avuto con qualcuno che lei chiama con disprezzo Liberace, riferendosi al pianista e showman americano dallo stile untuoso e kitsch, per ridicolizzarne la vanità artistica (scopriremo la sua identità, nel prosieguo del romanzo) e come forma di distacco emotivo, per sottolineare insomma quanto poco importante quel padre sia nella loro vita. Lei, coltissima, lo considera indegno e non può tollerare che il figlio possa essere influenzato da una figura che rappresenta l'opposto dei valori che lei vorrebbe insegnargli: autenticità, rigore, intelligenza. Sicura che non sarebbe capace, come nota Elena Dal Pra, "di scardinare le porte della loro gabbia a due". Alle continue richieste del bambino di dirgli chi è suo padre lei risponde sempre "No". Ma il suo è un gesto radicale di amore e discernimento, pur segnato da una solitudine ostinata.

Sybilla non vuole che Ludo cerchi nel mondo un padre secondo una convenzione biologica, vorrebbe piuttosto che ne trovasse uno diverso dal suo vero ma nei libri, tra i maestri, tra gli eroi, nei modelli ideali: non gli dice chi lo ha generato perché per Ludo pensa sia necessaria una paternità di spirito e non di sangue. Ma è quando Ludo si mette per conto suo a cercarlo che Helen DeWitt ci regala una irresistibile parodia del mito dell'origine, un gioco colto e un divertimento – suo e nostro – con le strutture archetipiche del romanzo di formazione e della ricerca del padre, che viene demitizzato e moltiplicato fino al grottesco con una intelligenza straordinaria. L'incontro tra Ludo e il suo padre biologico è irresistibile: dopo una ricerca metodica, da detective epistemologo, il bambino prodigio riesce finalmente a rintracciare "Liberace" in carne e ossa: ma l'uomo conferma le credenze della madre, dimostrandosi vanesio, superficiale, non all'altezza del figlio che, benché dodicenne, lo sovrasta in tutto. La figura mitica di questo padre tanto cercato si sgonfia, rivelandosi per ciò che è sempre stata agli occhi di Sybilla: una caricatura. Ludo, che forse aveva sperato in qualcosa di più, non si scandalizza né si commuove, registra il fallimento e passa oltre. Perché il suo bisogno di paternità è teorico: non cerca il padre, cerca un padre, ma che sia all'altezza di esserlo. A questo punto il romanzo vira decisamente al comico, col bambino che sceglie una galleria meravigliosamente assurda di candidati, con le peripezie per incontrarli, con quei campanelli suonati e, rispondendo alla domanda "Cosa vuoi", con la frase scioccante "Sono suo figlio".
DeWitt si prende gioco del cliché del Bildungsroman, capovolgendone gli elementi canonici, raccontando Ludo come un figlio che non si accontenta di aver conosciuto finalmente il suo vero padre ma, per non tradire le aspettative della madre, ne cerca uno all'altezza dei valori che lei gli ha trasmesso. "Ho pensato che ormai cominciavo a capire come funzionava. Ero partito scegliendo il padre sbagliato ma adesso sapevo che cosa cercare e potevo collezionarne anche una ventina. Mi vergognavo, ma moltissimo, per tutti gli anni che avevo passato a tentare di scoprire chi fosse il padre che mi era toccato in sorte, invece di puntare semplicemente al meglio sul mercato". Così Ludo si presenta a casa di Sorabiji, un genio della scienza autodidatta, vincitore di un Nobel. La scena è esilarante per il capovolgimento dei ruoli: il bambino pone allo scienziato una serie di domande tecniche complesse per valutare se sia "un padre meritevole", è lui ad esaminare l'adulto, con spietata lucidità. Poi interroga un pittore, Watkins; a Sgezeti, diplomatico e giocatore di bridge, dopo averlo sorpreso con la sua solita risposta, rivela di aver già incontrato il suo vero padre: "Tre mesi fa sono andato a incontrare il mio vero padre, solo per vederlo. Non ho detto chi ero. Stavo lì in piedi nel suo studio, e pensavo, Non posso dirgli che sono suo figlio, perché è vero". (...) "E a me potevi dirlo perché non era vero? Capisco!".
Poi è la volta di un pilota islandese: Ludo è affascinato dalla disciplina e dall'eroismo di una professione che richiede coraggio e controllo, finalmente un padre che ha padronanza del mondo reale, in contrasto con le figure dei padri intellettuali; c'è posto per un incontro non reale ma simbolico, con un violinista, Akira (come il nome di Kurosawa) e Ludo lo valuta per capire se il "candidato" sia sufficientemente "armonico" per meritare il titolo di padre; alla fine incontra un giornalista famoso, colto, sicuro di sé, Red Devlin, malinconicamente narcisista: accade un evento tragico ed è il segnale per Ludo di smettere di cercare altri padri. Insieme alla sua giacca di jeans porta via con sé, dal breve rapporto con Devlin, qualcosa di più profondo di un semplice esempio da seguire. Ogni uomo che Ludo sceglie di incontrare, recandosi a casa sua, rappresenta la tessera di un mosaico che va imponendosi sugli archetipi introiettati dalla madre: la scienza, la musica, il coraggio, il rigore, il linguaggio, la sapienza antica, la disciplina. A partire dalla metà del romanzo Ludo si muove nel mondo come un individuo autonomo e il tono cambia: il bambino agisce con decisione e senza mediazioni materne. La fine non è sentimentale né riconciliatoria. Ludo non "ottiene" un padre, perché non ha bisogno di un padre, ha incorporato in sé i modelli che cercava, il desiderio del padre è stato superato o trasfigurato: non c'è più un vuoto da colmare, semmai una forma piena in costruzione.
L'ultimo samurai è anche un romanzo profondamente e modernamente femminista. Sybilla è un personaggio memorabile: madre single, intellettuale, autodidatta, povera, costretta a lavori di trascrizione umilianti di riviste di hobby in procinto di essere digitalizzate, eppure instancabile, profondamente amorosa anche se apparentemente anaffettiva. Sceglie di istruire il figlio da sola, lo nutre di conoscenza, senza mai infantilizzarlo. Incarna un ideale di maternità non domestico, non sentimentale, non sacrificato, è l'anello spezzato della catena patriarcale, non sente mai il richiamo al dovere di "dare un padre" al figlio. Al cuore del romanzo c'è la domanda del bambino "chi è mio padre?" che DeWitt smonta e rimonta con intelligenza. Il romanzo non cerca di ricomporre la figura del padre: la moltiplica e, nello stesso tempo, la rende inutile e la disperde. Lei non dice a Ludo chi è suo padre perché non vuole che un uomo che lei giudica mediocre abbia il diritto di occupare nella mente di suo figlio nessuno spazio simbolico, demolisce il principio secondo il quale l'autorità maschile sia fondativa, proponendo invece una genealogia elettiva, intellettuale, multiforme, fondata su criteri meritocratici e non su vincoli biologici.
Ludo cerca guide "maschili" ma non vuole imitarle, quella del padre si rivela una ricerca della comprensione della propria misura, dove la figura paterna non rappresenta più il dominio ma semmai la spinta all'autonomia. E I sette samurai, che ritornano ossessivamente nel libro, è il film che mostra guerrieri che non sono padri autoritari ma uomini capaci, rispettosi, disciplinati, altruisti, più madri spirituali che padri fallocentrici. DeWitt scrive un romanzo intellettuale, frammentario, polifonico, femminista anche nella struttura: rifiuta la separazione tradizionale che assegna la ragione agli uomini e l'emotività alle donne e lo fa intrecciando lingue, stili, saperi diversi in una narrazione che rifiuta ogni gerarchia tra pensiero razionale e vita interiore. Il lavoro di Elena Dal Pra per tradurre questo libro eccezionale deve essere stato faticoso. Ne accenna lei nell'introduzione: "Qualcuno ha detto che il traduttore è come uno speleologo, che di una montagna esplora anfratti, grotte e faglie, senza poter godere del suo panorama (...). Ma la potenza della scrittura di DeWitt è tale che perfino io, che mi accostavo al testo per tradurlo, ne sono stata fagocitata, rapita. 'Perfino' perché di anfratti, grotte, crepacci, neanche nascosti, le pagine erano piene, eppure era massima l'attrazione centripeta di quel racconto (così centrifugo!), e di una scrittura che seguiva il corso, anzi la corsa, della mente, dei fatti, delle interruzioni e delle interpolazioni, slalomando senza neanche le porte, i paletti, le segnalazioni di virgolette e parentesi e incisi, in uno spazio tipografico in cui ogni segno, o mancanza di segno, è più che mai testo". Grazie a Dal Pra per averci ridato, a ventitré anni dalla prima edizione italiana, questo romanzo esigente e sfidante e onore al merito a Einaudi per non stancarsi di riproporlo.