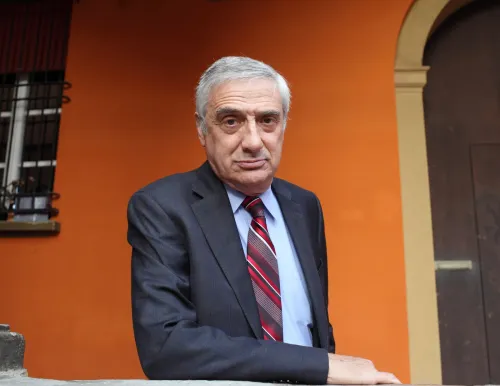Joel Mokyr: il Nobel a un idealista
Un premio che viene da lontano, mi verrebbe da dire. Poi mi rendo conto che per la gran parte dei premi Nobel – anzi per la gran parte dei progressi umani – si potrebbe dire così. Comunque in effetti viene da lontano, e lasciatemi spiegare il perché. Da quasi un secolo ormai gli economisti si interrogano sulla crescita. È un argomento che divenne cruciale alla fine della seconda guerra mondiale, quando si pensò che la crescita economica poteva essere davvero l’elisir per guarire tutti i mali, compresa la guerra, le cui ferite erano ancora aperte e ben visibili. E perfino la guerra di classe, tanto temuta. In sintesi, se c’è crescita tutti stanno meglio, le tensioni si stemperano: invece di togliere a Tizio per dare a Caio, faremo crescere il benessere di tutti e due. Per di più, i paesi poveri tendono a crescere di più di quelli ricchi, le distanze si accorciano (non è sempre vero). Insomma, pace e benessere, tutti contenti. In questa temperie intellettuale e politica, gli economisti si concentrarono su due questioni, attinenti rispettivamente al breve e al lungo periodo.
Nel breve periodo, bisogna cercare di evitare o almeno minimizzare le crisi, che riducono la domanda e l’offerta a un livello molto inferiore a quello potenziale, e per questa via provocano disoccupazione. Keynes aveva pubblicato il suo capolavoro (la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta) prima della guerra, nel 1936, ma le sue politiche avevano avuto scarsa applicazione negli anni immediatamente successivi. Fu nel dopoguerra che il keynesismo pratico sbocciò, e divenne quasi la religione ufficiale fino agli anni settanta. Lo scopo delle politiche keynesiane era di massimizzare l’occupazione, e per quella via massimizzare il prodotto (il famoso PIL). La ricetta keynesiana: se la domanda è insufficiente perché gli imprenditori hanno paura ad investire, si faccia avanti lo stato. Lo stato compensi con la propria domanda (esempio: lavori pubblici) il “vuoto di domanda” che si genera nell’economia privata. Ovviamente questo crea un deficit pubblico, ma è un deficit “buono” che serve a rimettere in moto la macchina. Così la crisi si supera e lo stato può rimettere a posto il suo bilancio. Quindi, grande sviluppo della scuola keynesiana: Kahn, Kaldor e Robinson nel Regno Unito, Samuelson negli Stati Uniti, Caffè e Graziani in Italia.
Ma c’è un secondo punto, che è quello più importante per noi oggi, nel commentare il Nobel a Mokyr. Si doveva individuare il motore di lungo periodo della crescita. Dipende dal fatto che mettiamo “più benzina” dentro la macchina economica (più lavoro, più capitale) oppure dal fatto che la macchina economica si avvale di una migliore tecnica produttiva? Il consenso fra gli economisti fu: la chiave sta nella migliore tecnica produttiva. Bene, ma come si ottiene il miglioramento della tecnica produttiva? Così iniziarono gli studi sull’innovazione, la quale dapprima fu pensata come esogena (esogena rispetto all’economia, cioè un qualcosa che avviene al di fuori del controllo di imprenditori e politici) e poi venne modellizzata come un fenomeno che può essere spiegato con cause economiche (nasce la scuola della “crescita endogena”, della quale uno dei maggiori esponenti è Paul Romer, premio Nobel nel 2018). Mokyr appartiene alla famiglia degli studiosi dell’innovazione. Ne è uno dei maestri.
Più avanti dirò qualcosa sulle prospettive future della crescita. Ora vediamo invece di capire meglio il contributo di Mokyr. Lui è prima di tutto uno storico. Uno dei suoi primi libri, Twenty-Five Centuries of Technological Change: An Historical Survey (1990), è essenzialmente una storia della tecnica: metallurgia, aratri, motori, macchine e così via, dall’antichità ai tempi nostri. Già si intravede però in quest’opera lo sviluppo maturo del suo pensiero: nel libro si parla non solo di macchine, di congegni, di sistemi di lavorazione, ma anche di mentalità. Quale è il mondo mentale dentro il quale matura una certa invenzione? Un esempio chiarirà la cosa. Prima di Evangelista Torricelli – seguace di Galileo – nessuno sapeva che cosa fosse l’atmosfera. Si sapeva ovviamente dell’aria, ma l’aria era, nella mente dell’uomo seicentesco, senza peso. Ora, dovete sapere che Galileo, in quanto matematico dei Medici, venne incaricato di affrontare il problema delle pompe: le pompe che dovevano provvedere all’irrigazione dei giardini granducali non pescavano acqua a più di 10 metri di profondità. Come mai? Galileo non seppe risolvere il problema, che passò così in eredità al suo successore, appunto Torricelli. Nel 1644 Torricelli scoprì la pressione atmosferica, e quindi l’atmosfera. Nella lettera che scrisse all’amico Michelangelo Ricci troviamo una frase famosa: “Noi viviamo sommersi nel fondo di un pelago d’aria”. È la pressione atmosferica, e non l’horror vacui, che fa funzionare le pompe a vuoto: se si crea il vuoto in un tubo verticale con il fondo immerso in una bacinella, la pressione atmosferica si annulla al suo interno, e la pressione atmosferica esterna farà salire l’acqua dentro al tubo, contro la gravità. Ma c’è un limite a quanto l’acqua può salire, limite dato appunto dal valore della pressione atmosferica: oltre i 10 metri (o 760 millimetri se riempiamo il tubo di mercurio) la pressione non ce la fa a vincere il peso della colonna di acqua.
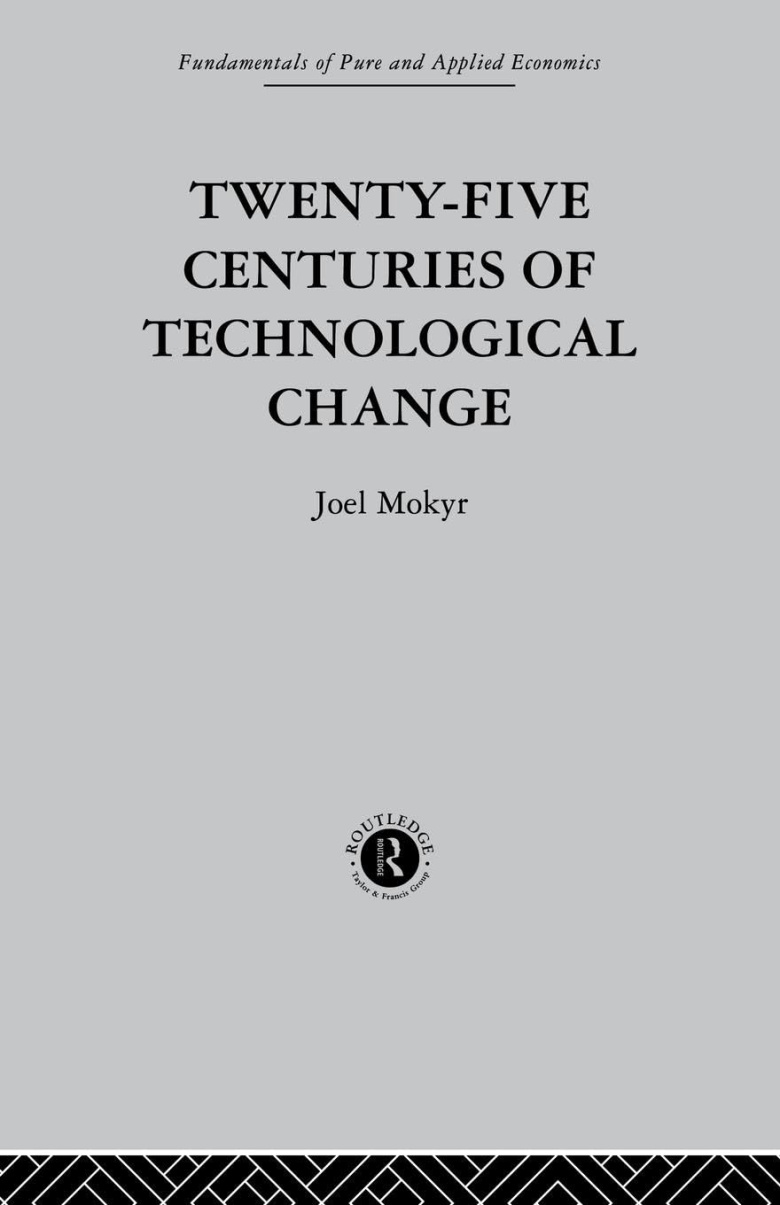
La scoperta di Torricelli ha a che fare con la mentalità in due modi. Primo: si tratta di una scoperta che nasce da una questione pratica, la faccenda delle pompe e dei giardini. Essa presuppone un interesse per la soluzione di questioni pratiche. Secondo Mokyr, un atteggiamento mentale orientato verso l’utile, verso la soluzione di problemi pratici, è un prerequisito fondamentale della crescita sostenuta che si è verificata in Europa dalla Rivoluzione Industriale in poi. Secondo, la scoperta di Torricelli cambia letteralmente la percezione del mondo: capire che siamo “nel fondo di un pelago d’aria” è un modo radicalmente nuovo di guardare al mondo che ci circonda. Esattamente come l’idea, propugnata dal suo maestro, che la Terra non fosse al centro dell’universo. La scoperta di Torricelli ebbe tuttavia conseguenze pratiche più immediate di quella di Galileo. Perché l’essere consapevoli della pressione portò a ragionare sui modi di sfruttare la pressione stessa per ottenere energia meccanica. Dalle pompe si passò così nel giro di qualche decina di anni ai motori “atmosferici” (Papin, Savery, infine Newcomen nel 1713): motori cioè in grado di generare movimento sfruttando la pressione atmosferica che agisce su un pistone al di là del quale è stato creato il vuoto. Il famoso motore a vapore di James Watt altro non era che un motore atmosferico altamente perfezionato: fu un grande successo industriale e anche commerciale. Dai motori atmosferici si passò rapidamente (si fa per dire) ai motori ad alta pressione, quelli che nei primi decenni dell’Ottocento mossero le macchine, i treni e le navi della Rivoluzione Industriale.
Nel suo libro successivo, il famoso Una cultura della crescita (tradotto in italiano dal Mulino, 2018), Mokyr riprende e sistematizza il ragionamento che aveva abbozzato nella storia della tecnologia. Qui protagonista non è più il progresso tecnico in sé, ma l’ambiente mentale nel quale il progresso tecnico si dispiega. Si riprende e si amplia il ragionamento sul pensiero utile, e soprattutto si sottolinea il fatto che nei due secoli fra Galileo e la Rivoluzione Industriale il mondo intellettuale europeo è animato dal desiderio di gettare un ponte fra scienza e tecnologia. La scienza, poco a poco, cessa di essere barricata nelle università, chiusa in sé stessa e nei suoi sillogismi: si apre a una missione nuova, la ricerca dell’utile. E per assolvere questa missione nuova non può che allearsi con la tecnica. Artigiani e scienziati non vivono più su mondi diversi (“meccanici” e “filosofi”), ma collaborano per creare macchine, materiali, processi industriali che rendono la vita migliore.
È questa alleanza che rende il progresso tecnico autosostenuto: un’invenzione (per esempio il circuito logico del computer) porta a macchine nuove, l’uso delle quali fa sorgere problemi nuovi (per esempio la miniaturizzazione) che determinano nuove investigazioni scientifiche e infine nuove scoperte (per esempio il transistor). E così via, in un processo continuo che ha l’effetto di mettere beni sempre migliori a disposizione di un numero sempre maggiore di persone. Questo è il meccanismo della crescita economica “sostenuta”. Sostenuta vuol dire continua, non episodica. Nei secoli che precedettero la Rivoluzione Industriale ci furono innovazioni (la ruota, i mulini a vento, la rotazione delle colture…) ma non ci fu mai un susseguirsi di innovazioni, le une legate alle altre, lontanamente paragonabile a quello che ha caratterizzato il mondo industriale. La crescita è stata minima. I problemi pratici risolti per mezzo della scienza e della tecnica sono centinaia: chimica, metallurgia, meccanica, aerodinamica, medicina e tante altre discipline hanno plasmato, nel giro di tre secoli, il nostro mondo “moderno”, fatto di strade asfaltate, automobili, aria condizionata, computer, grattacieli, ascensori, antibiotici, bombe atomiche e pistole Beretta.
Le radici del progresso autosostenuto, secondo Mokyr, sono culturali, e si sono formate molto prima che il processo iniziasse. I maggiori protagonisti del cambiamento culturale (“imprenditori culturali”, li chiama Mokyr) furono Francis Bacon e Isaac Newton (meno peso si dà a Galileo, non ho capito perché). A ciascuno dei due sono dedicate decine di pagine, nelle quali Mokyr mette a fuoco non solo il loro pensiero volto ad esaltare la conoscenza utile, ma anche il prestigio di cui essi godettero nel mondo intellettuale, e il debito di riconoscenza che i maggiori innovatori, contemporanei e di altre generazioni, riconobbero nei loro confronti. Basta questo a “dimostrare” la tesi che fu questa avanguardia culturale a gettare la basi della Rivoluzione Industriale e del progresso tecnico ed economico? Forse no: come si potrebbe dimostrare rigorosamente una tesi così complessa, così ricca di implicazioni? Ma certo l’opera di Mokyr è ricca, profonda, batte strade nuove.
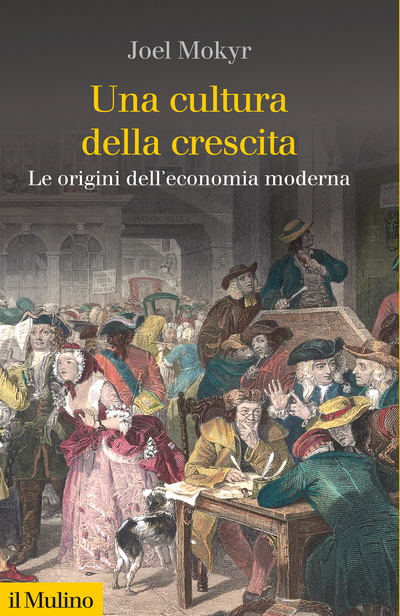
È ora il momento di discutere un fattore che ho trascurato: l’organizzazione della scienza. Tutti sappiamo che l’Europa è da sempre divisa in parecchie decine di stati indipendenti. Eppure nel campo della scienza, e della cultura in genere, vi è stata una grandissima compenetrazione di idee. Gli scienziati europei hanno creato una densa rete che li ha messi in comunicazione fra loro: una rete fatta di lettere (scritte in latino, la lingua universale della scienza), di università, di accademie (Lincei, Royal Society e mille altre), di editori, di sovrani illuminati che elargivano pensioni e cattedre. C’era mobilità: Cartesio finì in Svezia (dove morì di freddo), Eulero a San Pietroburgo e a Berlino, Lagrange a Parigi, eccetera. Questa rete, la Repubblica delle lettere, fu un grande moltiplicatore di ricerca. Funzionò in due modi, spiega Mokyr. In primo luogo come canale di comunicazione (e quindi generò ispirazione, critica, affinamento delle ipotesi), in secondo luogo come valvola di sicurezza: se uno studioso si trovava in pericolo in uno stato poteva fuggire in un altro, dove le sue idee erano accolte con più favore. Questo non poteva avvenire in Cina, un grande impero unitario dotato di una autorità centrale.
Una cosa è certa: Mokyr è un idealista. Idealista in senso tecnico: il cambiamento storico nasce nelle menti, e poi si traduce in fatti concreti. Su questo è piuttosto categorico. Io che vengo da una formazione marxista ho la tendenza opposta, a vedere il cambiamento delle idee come un riflesso di un mondo materiale che cambia, nel quale si manifestano bisogni e interessi nuovi. Per esempio, credo che la crescita della popolazione europea, dopo il crollo demografico dovuto alla peste del Trecento, abbia stimolato l’invenzione di nuovi processi produttivi in agricoltura, e siccome gli strumenti agricoli sono prodotti da artigiani, abbia anche smosso le menti nel mondo industriale. Penso anche che la crisi energetica nella quale era caduta l’Inghilterra alla fine del Seicento (le foreste erano state in larga parte abbattute per ottenere legna da ardere o per costruire navi) abbia stimolato l’estrazione del carbone, e che l’industria carbonifera, andando a sbattere con il problema dell’acqua nel fondo delle miniere, abbia stimolato Newcomen e poi Watt a inventare motori che muovessero le pompe necessarie per liberare le miniere dall’acqua e per continuare a scavare sempre più in profondità. E per quella via si arriva alla Rivoluzione Industriale.
Tuttavia, non è il momento di polemizzare. Riconosco, avendo abbandonato ogni velleità dogmatica, che cultura ed economia si influenzano a vicenda. Sebbene trovi il lavoro di Mokyr un tantino unilaterale, non posso non ammirare la vastità della dottrina e la brillantezza delle idee. Il libro è talmente ben fatto che mi inchino.
Però non posso lasciarti, caro lettore, senza aver prima detto una cosa sulla crescita. Mokyr ha fatto benissimo a illuminarci sulle origini della crescita. E si capisce bene che è un grande estimatore della crescita: ci ha allungato la vita, ha ridotto la mortalità infantile di 10 volte e ci ha fornito di tanti strumenti e beni utilissimi. Dobbiamo quindi augurarci che continui all’infinito? Non lo credo. La crescita infinita è plausibile in un mondo materiale infinito: se Elon Musk riuscisse a realizzare il suo sogno di colonizzare non solo Marte, ma molti altri pianeti con risultati economici sensati, allora potrei accettare l’idea. Ma l’idea dell’economia nello spazio, lasciatemelo dire, è una totale fesseria. Non solo la vita stabile su altri pianeti presenta sfide invincibili, ma lo stesso viaggio è talmente dispendioso dal punto di vista energetico che qualsiasi ricavo che se ne potrà trarre sarà di gran lunga inferiore al costo. Perché allora il brillante imprenditore vi si dedica con tanto ardore? Perché il brillante imprenditore ha creato una bolla mentale, all’interno della quale, finché dura, fa un sacco di soldi (a spese dei cittadini americani, e speriamo che si fermi lì). Poi finirà, esattamente come la bolla finanziaria creata da Bernie Madoff, e da Charles Ponzi prima di lui. Un paragone utile è quello con la conquista italiana dell’Etiopia: un enorme fallimento economico per l’Italia, ma una succosa fonte di profitto per pochi imprenditori spregiudicati e per alcuni funzionari pubblici collusi. Un’altra via plausibile per ottenere una crescita infinita è quella di far crescere soltanto i beni immateriali (conoscenza, arte, educazione ecc.). Potrebbe funzionare, a patto che funzioni davvero in quel modo. Il mio sospetto è che si tratti di uno specchio per le allodole. Il messaggio che vien fuori da questo approccio è: continuiamo tranquillamente come prima, nella confortante previsione che in un futuro indeterminato la crescita si orienti “spontaneamente” verso beni immateriali. Ma quando? Sarà probabilmente troppo tardi per evitare l’aggravarsi dei disastri ecologici che si avvertono già pressanti oggi.
In conclusione: viva Mokyr, ma la cultura della crescita, che lui ha magistralmente analizzato, vive oggi in un contesto nuovo, nel quale la civiltà umana, dopo due secoli e mezzo di crescita, spinge visibilmente contro i limiti fisici del nostro pianeta: siamo entrati nell’Antropocene. Dobbiamo ripensare fini e metodi. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è una cultura della Terra. L’alleanza fra scienza e tecnica non basta più, è necessario un terzo partner: la politica.