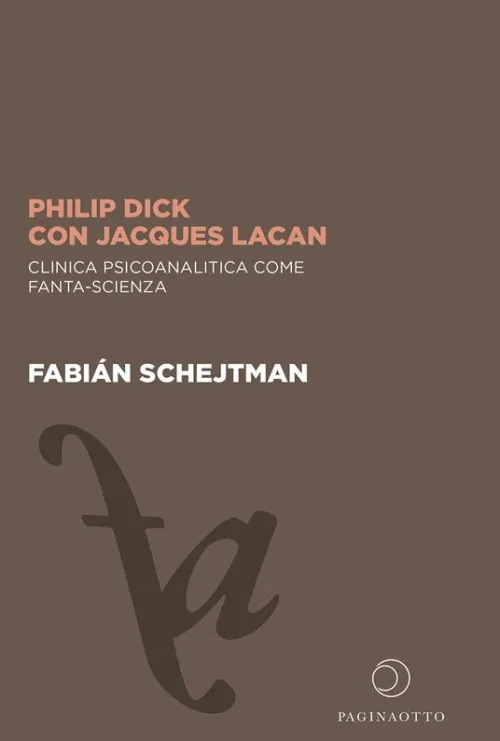Philip Dick con Jacques Lacan
Verso la metà degli anni Quaranta, Philip Kindred Dick, colui che sarebbe diventato da lì a qualche decina d’anni uno degli scrittori di fantascienza più noti e più utilizzati dal cinema, era ancora uno studente della Berkeley che già aveva conosciuto l’esperienza della psichiatrizzazione, che si ripeterà numerose volte lungo tutto il corso della sua vita. In quegli anni, il giovane Dick inizia a fare un sogno ricorrente: si trova in una libreria e cerca il numero di una rivista di fantascienza dell’epoca, Astounding, che avrebbe dovuto contenere il racconto L’impero non è mai cessato. Dick immaginava che, leggendo quel testo, avrebbe avuto accesso a un incontro con una verità rivelatoria. Nei sogni Dick non troverà mai davvero quel fantomatico numero della rivista, anche se, trent’anni dopo, ormai divenuto autore cult della letteratura sci-fi, la frase “L’impero non è mai cessato” riecheggerà nella sua vita e nel suo universo letterario sotto la forma di un’intrusione allucinatoria.
Nell’episodio del sogno, riportato da Fabián Schejtman nel suo Philip Dick con Jacques Lacan, è possibile identificare la ricerca onirica di Dick in cui si annida l’interrogativo che serpeggia in tutte le sue opere, a volte sotterraneo, a volte inciso a chiare lettere: “che cos’è vero? Che cos’è la realtà?”. Dick tenta di andare a scovare la verità che riguarda la realtà nella dimensione del libro e, ancor di più, del libro nel mondo del sogno, dunque nel luogo che tendiamo a considerare, sulla scia di Cartesio, sede di illusione e finzione per eccellenza. Eppure, se c’è un’operazione su cui si innesta gran parte, se non tutta, la riflessione di Dick, che possiamo a pieno titolo definire metafisica, è proprio quella di utilizzare mondi alternativi di finzione, fantastorici come in L’uomo nell’alto castello o fantascientifici come nella maggior parte della sua ciclopica produzione, per interrogare la questione della verità della realtà. In questo senso, Dick è molto distante da un grande autore della fantascienza come Isaac Asimov. Se quest’ultimo cerca di definire un mondo futuro scientificamente credibile, Dick è totalmente disinteressato a questo. Al contrario, i suoi mondi futuri e distopici sono popolati da sostanze psicoattive distorcenti o da programmi di simulazione che introducono ancora più finzione e illusione all’interno di universi letterari che sono già di fantasia. In questo senso, Dick sta dal lato di un Borges nel suo modo labirintico di lavorare sui confini tra realtà e finzione, tra mondo testuale e mondo extratestuale. Allora, la sci-fi di Dick è letteralmente un modo di indagare la realtà – se vogliamo una “scienza” ma nei termini di una conoscenza gnostica più che di un sapere scientifico determinista – nell’incontro con la “finzione”. Questo non è solo il cruccio di una poetica ammantata di metafisica ma è la questione che impernia – anche drammaticamente – tutta la vita dello stesso P. K. Dick.
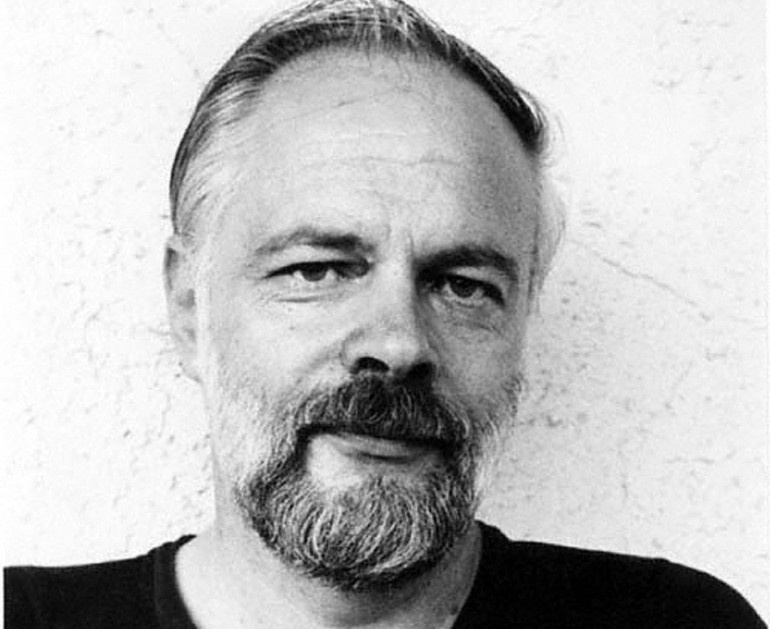
Tutta questa problematica del rapporto con la realtà e la letteratura di Dick viene articolata nel densissimo Philip Dick con Jacques Lacan. Clinica psicoanalitica come fanta-scienza, libro dello psicoanalista lacaniano argentino Fabián Schejtman, tradotto e curato da Mavie Loda per la casa editrice PaginaOtto (2025). Schejtman, infatti, appassionato e innamorato di fantascienza e, soprattutto, di Dick ben prima di incontrare la psicoanalisi lacaniana, mette in tensione lo scrittore americano e lo psicoanalista francese, intrecciandoli non solo nella teoria ma anche nella dimensione biografica. La struttura del testo assume allora, a suo modo, una dimensione sci-fi: da una parte la biografia di Dick e, soprattutto, le sue opere si innestano con la psicoanalisi lacaniana nella costruzione di un caso clinico-letterario – in maniera simile a quanto avvenuto per Lacan con Joyce –, dall’altra sono proprio Dick e Lacan che vengono fatti dialogare in alcuni incontri situati tra il reale e il fantastico, tra il possibile e il congetturale. Parte letteraria e parte saggistica si alternano costantemente nello scritto, creando una sorta di gioco speculare di riflessi che rende il libro creativo e vitale.
L’operazione di Schejtman non è, però, affatto forzata e non è un caso che l’incontro tra Dick e Lacan funzioni così bene. Infatti, proprio mentre Dick scriveva i suoi romanzi più metafisici tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta negli Stati Uniti, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico Jacques Lacan era preso dalla sua decennale operazione seminariale, che terminerà alla fine degli anni Settanta. Proprio durante i suoi Seminari Jacques Lacan non smetterà mai di ripetere l’aforisma “la verità ha struttura di finzione”, frase che ricorre anche per tutto il libro di Schejtman. Per Lacan questo significa che la verità non si può mai dire tutta: si può solo dire a metà perché è nella dimensione del linguaggio che essa può essere articolata ma, nel momento in cui la si articola nel linguaggio, di questa si perde sempre qualcosa, in un’operazione in cui si produce sempre uno scarto. Potremmo dire, invece, che Dick avrebbe formulato questa frase lacaniana in una forma invertita: “la finzione ha una struttura di verità” e cioè che proprio attraverso la costruzione di distopie e mondi immaginari possiamo dire qualcosa sul reale che è più vero del vero sebbene sia, appunto, fantastico. Sono quelli che Dick chiama i suoi “simulacri”, «gli artifici che lo scrittore continua a inventare» (Schejtman, 2025 p. 136), e che sono, secondo Schejtman, anche ciò che gli permette di avere un aggancio alla realtà e un modo per interrogarla senza perdersi completamente nella frammentazione o nella dissoluzione della psicosi da cui è affetto. Allora il simulacro diventa il punto centrale della questione di Dick: «Appunto, ma esiste l’originale? [...] O l’originale non sarebbe altro che un falso, un simulacro, un artificio?» (Ivi, p. 58). Sono la realtà stessa e la sua origine, e dunque tutto ciò che ha a che fare con la creazione e la costituzione del mondo, che vengono radicalmente messe in discussione da Dick. Non è un caso che la fortuna di Dick sia arrivata nel cinema e nella televisione quando anche nel discorso pubblico si è parlato dell’attualità concreta di sostanze che modificano radicalmente gli stati di coscienza e soprattutto con l’emergere del mondo della robotica e dell’intelligenza artificiale, e quindi con il senso di angoscia e perturbante che questi oggetti, così capaci di confondere umano e inumano, realtà e finzione, hanno procurato nella nostra era.
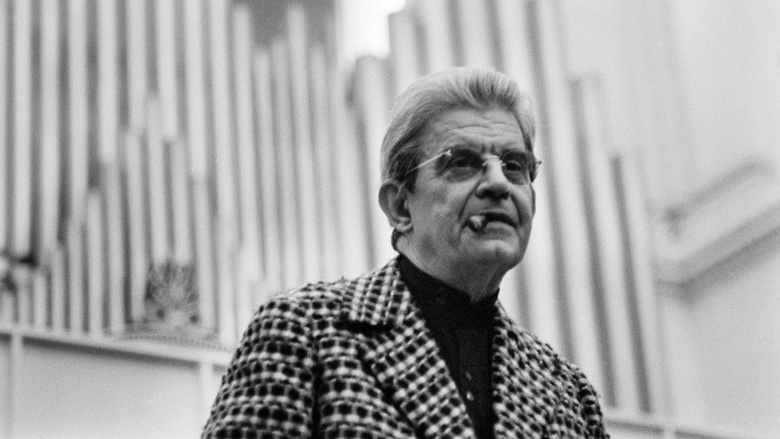
Non solo, però, l’accostamento di Dick e Lacan si presta particolarmente bene per il rapporto tra verità e finzione. Potremmo dire che è lo stesso Lacan a costruire una sorta di “fanta-scienza”, perché la psicoanalisi è la disciplina, la scienza, che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con le fantasie e i fantasmi che attraversano la vita psichica dei soggetti. Ma anche perché le sperimentazioni formali lacaniane hanno spesso il sapore di una scienza “fantastica”, nel senso di un modo di avere un rapporto inedito con il sapere. E sono proprio queste formalizzazioni a essere protagoniste della riflessione sull’opera e sulla psicosi di Dick: Schejtman mette a lavoro la teoria topologica dei nodi lacaniana per costruire un “caso Dick”. Al di là degli aspetti tecnici, però, la sfida che si è trovato davanti Schejtman è stata quella di cercare di evitare di limitarsi all’operazione che è stata tanto comune ad alcune psicoanalisi: costruire delle psicobiografie dove si va a rovistare, anche un po’ morbosamente, nella vita degli autori, rischiando di perdere di vista l’opera. Infatti, spesso, gli psicoanalisti hanno messo artisti e letterati del passato sul lettino per trarne diagnosi o bizzarre interpretazioni psicoanalitiche. Schejtman stesso, nell’introduzione del testo, sostiene: «Qualsiasi approccio che cercasse di ridurre la sua arte a una psicobiografia è stato escluso fin dall’inizio, in quanto sterile. Nessuna psicologia potrà mai spiegare l’opera di un artista appellandosi a quanto o quanto poco sia stato allattato dalla madre, alla figura paterna presente, assente, goffa, efficace o infelice che gli è toccata in sorte, all’influenza di una morte, di una nascita, di un inganno o di un trauma di qualsiasi tipo sulla sua esistenza. È necessario andare oltre questo psicologismo da quattro soldi» (Ivi, p. 14). La questione è, invece, provare vedere che cosa dice l’opera e come può interrogare la teoria e la pratica psicoanalitica, anche mettendone temporaneamente tra parentesi gli assunti. Mavie Loda, psicoanalista oltre che traduttrice del volume, ci dice qualcosa dell’operazione di Schejtman nella postfazione: «Il libro di Fabián Schejtman avanza la possibilità per la psicoanalisi di parlare di uno scrittore senza farne una biografia psicoanalitica. Come? Cogliendo la necessità di introdurre qualcosa nel suo procedere che viene messo in luce non dalla vita dell’autore né dalla sua opera, ma dal movimento che nell’autore con la sua opera viene messo in atto. Non si tratta quindi né dell’uomo né del libro, ma del rapporto tra i due» (Ivi, p. 169). Allora è l’aspetto di relazione e interazione tra Dick e il libro, la sua opera, ma anche tra Dick e Lacan, a diventare il motore del testo, il punto di incontro centrifugo che produce la possibilità di far emergere un movimento di sapere ed esplorazione che si crea a partire dalle opere di Dick. I suoi scritti diventano per Schejtman più importanti della sua biografia, che resta senz’altro centrale e ineliminabile – anche considerato quanto sappiamo della vita di Dick. Perciò, gli aspetti sintomatici di Dick non sono visti solo come aspetti clinici ma diventano innanzitutto le tre stigmate, riprendendo proprio uno dei libri più importanti e noti dello scrittore, Le tre stimmate di Palmer Eldritch. Ed è proprio la contaminazione tra i mondi d’invenzione-simulacri dei romanzi di Dick e la sua vita, così contrassegnata da una spinta alla scrittura compulsiva e irrefrenabile a essere il perno di tutto il discorso di Schejtman, fino al punto in cui lo spazio di differenziazione tra il simulacro e la dimensione biografica sfuma nell’ultima parte della vita di Dick. Negli ultimi anni prima della morte (l’epoca delle gigantesche scritture dell’Esegesi e della Trilogia di Valis), infatti, Dick riceve costantemente rivelazioni gnostiche, spesso in lingue antiche, il greco e il latino, dall’entità VALIS, un “Vast Active Living Intelligent System” che comunica costantemente con lui, e l’unico modo in cui può proteggersi nella scrittura è creare una sorta di doppione, Horselover Fat, che crea un minimo di distanza dall’invasione costante di questa voce che si annuncia con il già citato “L’impero non è mai cessato”. Ormai per Dick la realtà e la finzione arrivano a un punto di collasso: «[…] nella sua mente cominciavano ad apparire forme linguistiche corrispondenti a quell’epoca. È abbastanza chiaro: la realtà diventa instabile. Non c’è un reale che ancori il campo percettivo. Il sembiante fluttua, il mondo intero è tenuto insieme con lo sputo. Il tempo oscilla tra il primo e il ventesimo secolo, lo spazio oscilla tra Roma e la California. La finzione non trova fissazione» (Ivi, p. 92).
Al di là di quella che è la storia e l’opera di Dick, è importante soffermarsi anche sul sottotitolo “Clinica psicoanalitica come fanta-scienza”. Il “come” ci indica che non può essere solo l’accostamento tra queste due dimensioni a interessarci, è che c’è qualcosa nella pratica psicoanalitica che rimanda alla creazione di mondi possibili, di simulacri, e perciò al (ri)costruire e attraversare le proprie verità attraverso delle finzioni. Allora, la relazione e l’interazione che intercorre tra Dick e il libro a cui si accennava prima è qualcosa che assomiglia al transfert tra analizzante e analista, spazio relazionale in cui si possono costruire, ritagliare e incollare nuovi testi, producendo perciò l’inedito che caratterizza l’orizzonte di un percorso di psicoanalisi. In questo senso, anche il libro di Schejtman fa qualcosa del genere, ritaglia e mette in dialogo Dick e Lacan nella dimensione della scrittura per produrre qualcosa di nuovo e generativo: psicoanalisi e fantascienza sì ma, soprattutto, psicoanalisi come fanta-scienza!
Leggi anche:
Carlo Paggetti | La canonizzazione tardiva di P.K. Dick
Nicoletta Vallorani | Philip K. Dick: un Meridiano per la fantascienza
Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick
Alberto Mittone | I mondi di Philip K. Dick