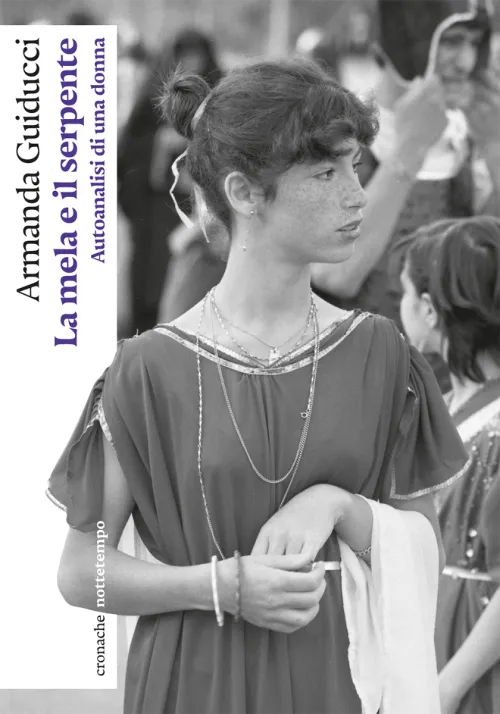Armanda Guiducci e tutte le donne del mondo
Il 12 e il 13 maggio del 1974 gli italiani sono chiamati alle urne per votare il referendum abrogativo relativo alla legge Baslini-Fortuna sul divorzio, approvata dopo un lungo e tormentato iter legislativo quattro anni prima, nel dicembre 1970.
In Italia sono anni di estremismi politici, stragismo e terrorismo, strategia della tensione, ma anche di agitazioni civili che cambiano per sempre la storia del Paese: il movimento studentesco del 1968, certo, ma anche la seconda ondata di femminismo che, grazie alle manifestazioni di piazza, incide non solo su questo referendum ma si batterà per ottenere, qualche anno dopo, altri due importanti cambiamenti: quello del diritto di famiglia nel 1975, che equipara i coniugi all’interno del matrimonio e, nel 1978, anche il diritto all’aborto.
Sempre nel 1974, nel pieno di queste lotte e rivendicazioni, viene pubblicato da Rizzoli uno strano libro, un oggetto editoriale insolito, difficile da definire e catalogare perché non si iscrive né nella categoria di saggio antropologico o psicologico, né in quella di memoir: si intitola La mela e il serpente. Autoanalisi di una donna e lo ha scritto Armanda Guiducci, studiosa, poeta, scrittrice, femminista e intellettuale tra le più interessanti in Italia. Nel giro di pochi mesi La mela e il serpente vende più di 25.000 copie, portando alla sua autrice un’improvvisa quanto inattesa notorietà. Scomparsa a lungo dagli scaffali delle librerie, l’opera di Guiducci torna adesso disponibile ai lettori grazie all’infaticabile lavoro di recupero della casa editrice nottetempo e con la preziosa curatela di Eloisa Morra, che ha deciso di far partire la ripubblicazione del lavoro di Guiducci proprio dal libro che la consacrò come importante autrice femminista e che ne firma anche l’appassionata e puntuale prefazione.
Quando il libro esce, negli anni Settanta, Guiducci è una personalità che si è già tracciata una strada ben precisa nel mondo editoriale, sebbene non sia ancora particolarmente nota al grande pubblico. Nata Armanda Giambrocono nel 1923, napoletana d’origine ma trasferitasi a Milano da giovanissima, è allieva del filosofo Antonio Banfi che, come era accaduto per altre sue allieve celebri – Rossanda Rossanda e Antonia Pozzi –, con il suo impegno politico e la sua visione estetica segna un’impronta ben definita nella brillante intelligenza di Armanda anche se, come molti studiosi marxisti dell’epoca, non è ancora in grado di riconoscere la potenza specifica delle lotte femministe. Antropologa, poeta, critica letteraria e studiosa di Cesare Pavese (a cui dedicherà un approfondito studio sul mito nella sua opera, Il mito Pavese, nel 1967 e Invito alla lettura di Pavese, nel 1972) e di Virginia Woolf (su cui scrive Virginia e l’Angelo nel 1991), Armanda mostra da subito un’attività intellettuale poliedrica e curiosa che la porta a sperimentare generi letterari diversi e a uscire dalle griglie della schematizzazione editoriale più classica. Nel 1955, insieme a Franco Fortini, Luciano Amodio e a quello che diventerà suo marito, Roberto Guiducci, fonda la rivista politico-letteraria Ragionamenti, di cui diventa ben presto direttrice editoriale. Il libro che la fa conoscere al grande pubblico prima di La mela e il serpente è una silloge poetica, Poesie per un uomo, del 1965, in cui Guiducci sembra già definire il rapporto con l’alterità dell’altro sesso come un cardine del suo pensiero filosofico e intellettuale.
T’ammiro, così astratto, e provo orrore
della tua incerta furia-forza maschile
e debolezza insieme; mancanza di natura
che mi relega in nota-a piè di pagina.
C’è già, in questa poesia, l’idea della dualità di un rapporto imprescindibile con l’Altro, che per Guiducci non è mai nemico da distruggere, ma complesso sistema da comprendere, biasimare e a volte compatire, da prendere per mano, con cui dialogare, portando l’autrice a trovare una posizione intermedia, una via personale, tra le due correnti principali dei femminismi degli anni ’70: quello separatista della differenza, ascrivibile al collettivo Rivolta femminile di Carla Lonzi e Carla Accardi, e quello socialista-marxista, più incline a volere le donne partecipi della vita politica e del potere, al quale invece era più vicino una figura come quella di Rossanda.
In quel mi relega a nota-a piè di pagina sembra anche di sentire l’eco delle parole della giornalista americana Martha Gellohorn, troppo spesso ricordata solo per essere stata una delle amanti di Ernest Hemingway, che una volta disse: “Non mi vedo come una nota a piè di pagina nella vita di qualcun altro”. Sembra essere la cifra delle donne che scrivono questo desiderio di scappare dal margine inferiore in cui la società vuole relegarle: amanti, mogli, madri, costole di qualcuno, e avere invece voglia di rivendicare il gesto di ribellione, l’autodeterminazione di quando Eva colse la prima mela, disubbidendo all’ordine costituito con la sua sete di conoscenza. Queste donne si fanno pagina, prendono la penna e scrivono, cercano di tracciare il proprio percorso e, come accade ad Armanda Guiducci, lo fanno segnando una via unica e originale di stare al mondo e pensarlo.
La mela e il serpente è infatti un libro che intreccia esperienza personale e studi antropologici, psicologici e sociali, che parte dal corpo femminile e lo rimette al centro della battaglia: infanzia e mestruazioni, ruolo sociale dell’età adulta e maternità/vecchiaia, sono le fasi che ogni donna attraversa ma anche le sezioni in cui è diviso questo libro, e Guiducci parte dalla sua esperienza personale per connetterla al simbolismo universale della concezione del corpo della donna nella società, per connettere così tutte le donne del mondo.
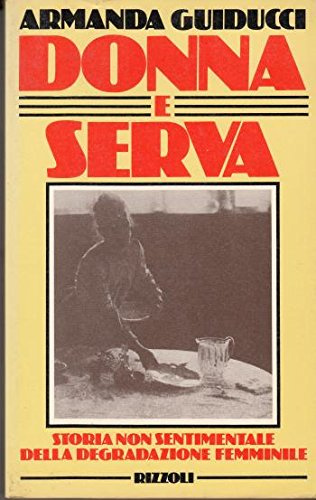
Lo fa da subito, in maniera programmatica, quando all’inizio del libro esordisce dicendo: “Non sono autobiografia, sono un campione d’esistenza femminile. Ogni ragazza dell’Occidente percorre infatti fasi “obbligate” dello sviluppo fisico e psichico. […] Risalgo ad Eva, la mela e il serpente, e discendo dentro me stessa. Frugo dietro le istituzioni sociali, dietro i tabù del sesso, nell’inconscio maschile. Ma frugo anche nel mio inconscio che pullula di immagini compiacenti, deformate, della Femminilità”.
Guiducci tiene fede a tutte queste promesse e con metodo antropologico rintraccia nel passato, nella tradizione occidentale ma anche nelle diverse culture, le origini delle istituzioni sociali e dei tabù sessuali (come quello legato al sangue mestruale, rosso, impuro e negativo, e al seme maschile, bianco, fecondo e positivo) che hanno portato alla discriminazione di metà degli esseri viventi sul pianeta, le donne. La sua non è una rabbiosa accusa al genere maschile, piuttosto un tentativo di comprensione che parte dalla decostruzione personale di tutti gli assunti interiorizzati attraverso l’educazione e che ledono, allo stesso modo, sia gli uomini che le donne.
Non sorprende dunque che in questo processo di decostruzione Guiducci arrivi anche a toccare, già negli anni Settanta, punte del più moderno femminismo intersezionale, comprendendo quanto privilegiata sia, pure in un contesto patriarcale, la condizione di una donna della classe borghese rispetto a quella di una donna proveniente da una classe sociale più bassa, consapevolezza che la porterà a scrivere libri come Due donne da buttare (1976), in cui traccia il ritratto di una casalinga e di una prostituta, La donna non è gente (1977), sulla condizione delle donne contadine in Italia, o Donna e serva (1983), volume dedicato al lavoro non riconosciuto delle casalinghe e alla loro emarginazione dalla vita sociale e dai centri del potere.
In La mela e il serpente si legge: “Il vero problema dell’istruzione femminile non è infatti quello della classe al potere, o delle ragazze borghesi che si assicurano laurea e matrimonio. È il problema dell’immensa maggioranza, dei milioni. È il problema dei milioni di ragazze che vivono nelle campagne, nelle province, nelle isole – là, dove miseria ignoranza e “scuola d’obbligo” non si incontrano che in modo formale ed evasivo. Si tratta veramente di un problema da terzo mondo al femminile. […] Questo problema è talmente lontano da ogni soluzione che perfino un bambino capirebbe, a questo punto, che la cosiddetta questione femminile non è, da qualunque parte la si guardi, che un aspetto di un problema politico di portata più vasta e strutturale. Esattamente come lo è la “questione meridionale”. O tutt’uno con essa”.
È un risveglio, quello di Armanda Guiducci, che inquadra la condizione delle donne come un problema politico specifico e che coincide con la scoperta della propria voce, e la rivendica:
Ho dormito. Per metà della mia vita,
Ho dormito: sono stata felice.
Un risveglio di consapevolezza, dunque, che la fa uscire da una dimensione di felice ignoranza e che le porta l’infelicità di chi si scontra con la realtà, ma da quello scontro non esce sconfitta, possiede invece, e usa, gli strumenti per capire la matrice di quella infelicità e parlarne, per riprendere la propria assertività e dare voce a migliaia di donne.
“Il grande paesaggio donna mi sfuggiva. Anche l’ignoranza dell’ampiezza mi sbarrava dunque il passo. Solo ora che l’una o l’altra appare ai miei occhi un universo; e, per quanto diverso, saturo di quell’affanno e solidale dolore femminile accumulato, in quasi ogni civiltà, da repressione e destino, scorgo la donna che non è me. Nella lontananza, mi chiama e mi somiglia.”
La mela e il serpente riscuote tanto successo perché agisce su più piani: lei si riconosce in tutte le donne che non sono lei e tutte le donne si riconoscono nella rigida educazione patriarcale ricevuta da Guiducci, nelle sue incertezze e nelle sue ribellioni, nelle vergogne e nelle repressioni familiari prima e sociali poi, negli stereotipi che imbrigliano e ingannano la femminilità, e allo stesso tempo fornisce una chiave interpretativa che parte da un dato concreto, il corpo, e lo rimette al centro del discorso pubblico e dell’arena politica, ne svela i meccanismi che hanno portato dai tabù sul corpo femminile (l’assenza del pene vista come mutilazione, le mestruazioni come condizione di impurità, il parto come condizione invidiata dall’uomo da un lato e cristallizzata in assurdi cliché dall’altro) fino alla creazione dei tabù che giustificano la subalternità del sesso femminile e che hanno condotto a considerare natura o destino quello che non è che un costrutto sociale.
“Capii che il mistero dell’esistenza ha molte strade per turbarci ma che quella maestra attraversa il corpo.”
Il corpo che origina le differenze di genere, anche nel linguaggio, mediante la presenza o l’assenza di definizioni. “Nella nostra lingua tutto ciò che sprigionava una forza, ispirava una solidità o emanava fierezza e aggressività era, mi fu perentoriamente spiegato, con ben poche eccezioni, di genere maschile. Fragilità invece dolcezza esalavano il genere femminile sulla scala della natura e dell’universo. […] Il genere, da grammaticale, diventò corporeo. Si iscrisse sulla pagina bianca e aperta del mio corpo”.
E così la nascita del fratello maschio, l’erede, che dona a sua madre la regale bellezza di una generatrice di uomini, dona invece a lei, per converso, la definizione di femmina come qualcosa di inferiore, subalterno: “Mio fratello avrà tutto, assicura mio padre, dato che è l’unico maschio della famiglia. A me, ora, dicono: tu non sei che una bambina”.
Il passaggio derivativo è in quel che si sceglie di nominare: il sesso del bambino maschio, la sua costante, celebrata, presenza, rispetto al sesso senza nome della bambina, privato del pene non già da un’innata invidia freudiana, ma dalla società che gli riserva un ruolo il cui unico assunto è privativo, e sorge da una presunta e simbolica mutilazione.
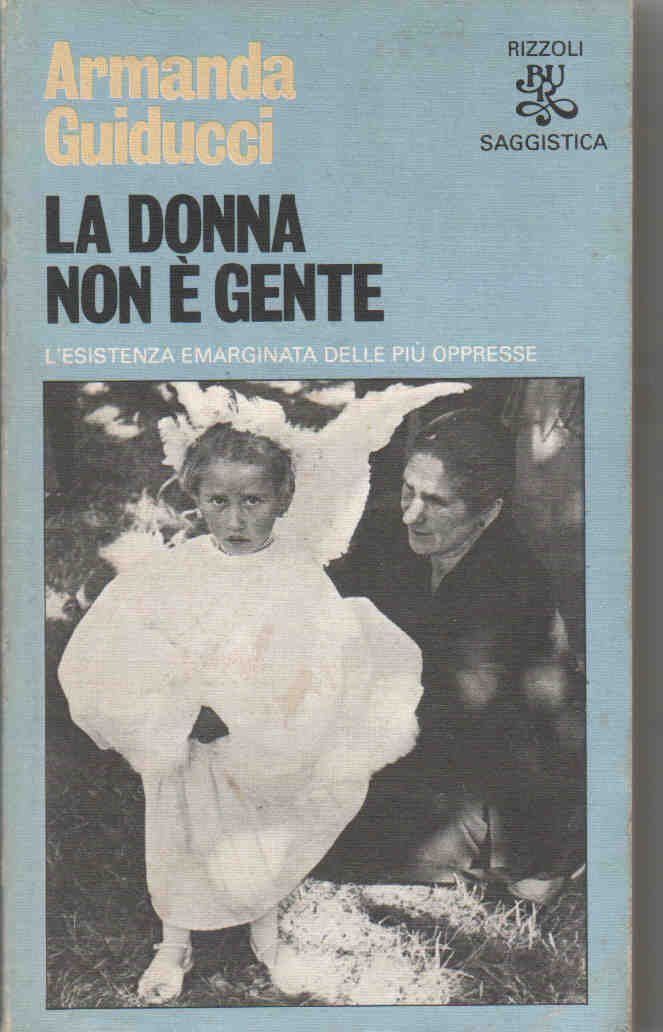
La femminilità si fa prescrizione, si viene educate a essere donne in un certo modo, e forse per questo Guiducci odia le sue bambole (e ricorda simbolicamente una Lila che in L’amica geniale propone di scagliare le bambole sua e di Lenù nella cantina del temuto vicino), odia i nastri con cui le infiocchettano i boccoli, i vestiti per la comunione e anche quella parola, fica, che un giorno un’amica le rivela essere il nome che gli altri danno al suo sesso e che le sembra violenta, estranea, subita. Da qui parte il viaggio di Guiducci, che attraversa continenti e culture differenti alla ricerca di universali antropologici, analizza la filosofia di Aristotele fino a Freud, sottolineandone limiti e parzialità, e individua nella religione e nel perbenismo borghese le matrici di un controllo così pervasivo sul corpo e la sessualità da farla sorridere quando sente le femministe rivendicare che il corpo di una donna non è dello Stato; non perché lo sia di fatto – la rivendicazione è giusta e legittima – ma proprio perché la società civile lo ha sempre ritenuto e trattato come tale.
Guiducci attraversa le esperienze proprie e comuni a tutte le donne: le molestie, le pulsioni e le relazioni lesbiche dell’adolescenza, lo stigma che pone le donne fuori dai circuiti del potere e che le rende per questo strane, pazze o streghe, legate a doppio filo al sogno e all’irrazionale perché quella è la dimensione in cui sono state relegate e di cui si sono riappropriate come una rivendicazione; problematizza e analizza i romanzi e la produzione poetica, analizza i sogni propri e delle donne che conosce, e smantella gli stereotipi legati alle mestruazioni e alla maternità, senza mai odiare, senza mai voler distruggere l’altra metà del mondo che ha dato origine a questo tipo di narrazione. Nessuna società evoluta, per lei, si è creata senza l’unione di uomini e donne, e gli uomini stessi soggiacciono al mondo distorto che hanno creato, privandosi, ad esempio, della liberazione del poter essere emotivi o della cura dei figli, della bellezza della paternità piena. Bisogna, afferma, darsi la mano nel mistero.
La decostruzione portata avanti dal femminismo, e in particolare dalla seconda ondata che vive Guiducci, è l’inizio di un percorso che occuperà troppi anni a venire, ma ne va riconosciuta la portata, la forza, e anche la necessità di aver bisogno dell’Altro per poter cambiare le cose.
“Io mi rendo conto solo adesso di essere un ammasso di mitologia. Ma non voglio gridare alla vittima. Non è sempre possibile distinguere la vittima e il carnefice. Guardo l’uomo e, dietro il possente petto respirante di Adamo, scorgo ora la vittima di una analoga, sebbene opposta, mitologia. Ciò che posso fare è demistificarmi come donna, creatura etichettata. […] Questa non è una rivolta, è un’estirpazione”.
Questa estirpazione, così forte e radicale, non è solo di Armanda Guiducci, è la lotta di ogni donna, è dover disimparare un’educazione per poter cambiare un sistema, un modo di pensare agito e respirato fin dalla nascita, è un processo lungo e faticoso, che avrà bisogno ancora di moltissimo tempo per completarsi, e proprio per questo ci servono opere come queste, scritte da donne che si sono interrogate, messe in discussione, e hanno lottato dismettendo il ruolo della vittima ma creando un immaginario nuovo e potentissimo.
Ursula K. Leguin nel Discorso per la consegna dei diplomi al Bayern Marw del 1986 (in I sogni si spiegano da soli, edizioni Sur, traduzione e cura di Veronica Raimo) chiama queste figure che hanno decostruito il linguaggio e i sistemi di potere le sue disinsegnanti e le celebra così: “Sono lenta a disimparare. Ma adoro le mie disinsegnanti – le pensatrici femministe, le scrittrici, le oratrici, poete, artiste, cantanti, critiche e amiche, da Wollstonecreft e Woolf, passando per tutte le furie e le glorie degli anni Settanta e Ottanta – voglio celebrare qui e ora le donne che da due secoli lavorano per la nostra libertà, le disinsegnanti, le disconquistatrici, le disguerriere, donne che hanno offerto la loro esperienza come la loro verità, prendendosene il rischio e pagandolo a caro prezzo”.
Armanda Guiducci è senz’altro una di loro, ed è il nostro momento di riscoprirla, leggerla, celebrarla.