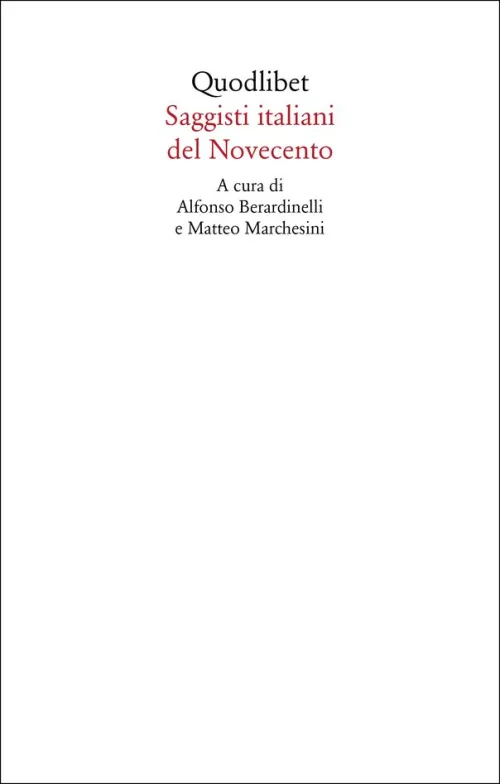Berardinelli e Marchesini: l'ipersaggio del Novecento
Nel 1910 l’editore Laterza pubblicava il catalogo della futura collana «Scrittori d’Italia», progettata da Benedetto Croce. Era una rivoluzione copernicana rispetto all’idea di storia della letteratura italiana che Carducci e la sua scuola, allora dominante, proclamavano e professavano attraverso l’insegnamento, gli studi e l’editoria di classici: tanto la letteratura italiana per Carducci era toscocentrica e ancorata alla poesia, tanto quella di Croce inglobava le geografie periferiche e gli scrittori di politica, gli economisti, i critici, i moralisti, gli storici, i filosofi. Per fare qualche esempio, tra i primi volumi usciti negli «Scrittori d’Italia»: Traiano Boccalini, Carlo Gozzi, Vico, Baretti. E non a caso un carducciano come Renato Serra scrisse un saggio indignato intitolato Per un catalogo. Molti anni dopo (1968) Gianfranco Contini, che disputò duramente con Croce per la filologia e gli «scartafacci», si dimostrò ben crociano nell’includere nella sua Letteratura dell’Italia unita, che divenne subito un’antologia molto famosa, saggisti come Luigi Einaudi e Roberto Longhi.
All’inizio del Novecento Croce intendeva rovesciare il dominio della poesia (e della poesia lirica in particolare) sulla letteratura italiana. Oggi lo strapotere è quello del romanzo e, con un’operazione ancora più programmaticamente provocatoria, Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini hanno messo insieme una voluminosa antologia di Saggisti italiani del Novecento (Quodlibet, pp. 1450, 36 euro), dichiarando apertamente che il meglio degli scrittori italiani è lì e nei dintorni, molto più che nei romanzi. Berardinelli e Marchesini non hanno in simpatia né Croce né Contini, e non li nominano come predecessori (ma sono entrambi antologizzati) anche perché il loro concetto di saggismo è un po’ diverso, però mi sembra innegabile che questa antologia radicalizza una tendenza, magari non maggioritaria, che percorre tutto il Novecento.
Che cosa intenda per saggio, Berardinelli lo ho detto e scritto in numerose occasioni, e in modo più disteso nel suo libro La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, uscito da Marsilio nel 2002. Nell’ampia introduzione all’antologia di Quodlibet, Matteo Marchesini ne riprende i punti sostanziali con affondi storici, teorici ed esempi pratici applicati agli autori antologizzati. Gli autori sono tanti, ben centocinque, da D’Annunzio e Croce, che costituiscono la preistoria di un percorso che muove soprattutto, almeno inizialmente, contro di loro, fino a Umberto Fiori che conclude il volume con uno scritto su Montale del 2000, passando per Salvemini, Papini, Prezzolini, Borgese, Cecchi, Michelstaedter, Gramsci, Savinio, Noventa, Debenedetti, Carlo Levi, Chiaromonte, e per Natalia Ginzburg, Fortini, Cases, Sciascia, Pasolini, La Capria, Garboli, Bellocchio e lo stesso Berardinelli.
La prima impressione potrebbe essere quella di una rassegna abbastanza ecumenica, ma in realtà l’idea che tiene insieme il volume è molto precisa. Per Berardinelli e Marchesini l’idea di saggio nasce dagli Essays di Montaigne e dunque i saggi, etimologicamente, sono dei tentativi. Hanno in sostanza, o dovrebbero avere, una natura sperimentale. Da qui l’anatema verso i critici che mettano a punto un metodo: la critica formalista subisce una totale damnatio memoriae, salvo nominare nell’introduzione i nomi di alcuni “cattivi maestri” come Bachtin o Genette; per quella psicanalitica viene accettato Giacomo Debenedetti dato il suo approccio meno sistematico, ma non Orlando e Lavagetto. L’erudizione è ammessa ma non se troppo specialistica. I bravi saggisti sono scrittori tout court e devono mettersi in gioco, toccare le corde della vita: possono farlo attraverso l’autobiografia, la riflessione filosofica, la polemica sociale; devono sempre farlo attraverso una «critica dell’esistente, lievito di ogni saggistica», dunque attraverso un impegno politico contro i poteri costituiti, perlomeno a livello culturale.
Nell’introduzione di Marchesini si enuncia a più riprese e in diverse declinazioni «il dovere del saggista», e questo francamente sembra un po’ paradossale data la pretesa libertà che il saggismo dovrebbe rappresentare. Ma poi, esaurito il proclama, c’è fortunatamente l’antologia. E qui le maglie si allargano e si può godere di tante voci che non rientrano nella teorizzazione. Possiamo leggere Emilio Cecchi anche se non è certo mai stato un feroce critico dell’esistente (viene presentato, oltre che con la celebre pagina dei Pesci rossi, con un geniale brano giovanile in cui accomuna nella stroncatura, pur così distanti fra loro, D’Annunzio e Croce; lui che poi è stato crociano per tutta la vita). Possiamo leggere Longhi, che sappiano grande scrittore ma che non ha mai scritto fuori della sua disciplina. Possiamo leggere scrittori dalla lingua troppo fatuamente estrosa (per Berardinelli e Marchesini) e dallo scarso impegno politico come Gadda e i suoi nipotini Manganelli e Arbasino (peraltro ben bacchettati nell’introduzione). Possiamo leggere perfino Calasso, di cui ricordiamo un memorabile ritratto-stroncatura di Berardinelli. Dunque l’antologia è senz’altro un’ottima raccolta di testi che mancava ed è da salutare con favore. L’impostazione “ideologica” offre un quadro un po’ tendenzioso ma non inficia il risultato complessivo e una qualche oggettività del panorama dato (con una percentuale di soggettività più alta sugli autori più recenti e meno storicizzati, ma questo è naturale).
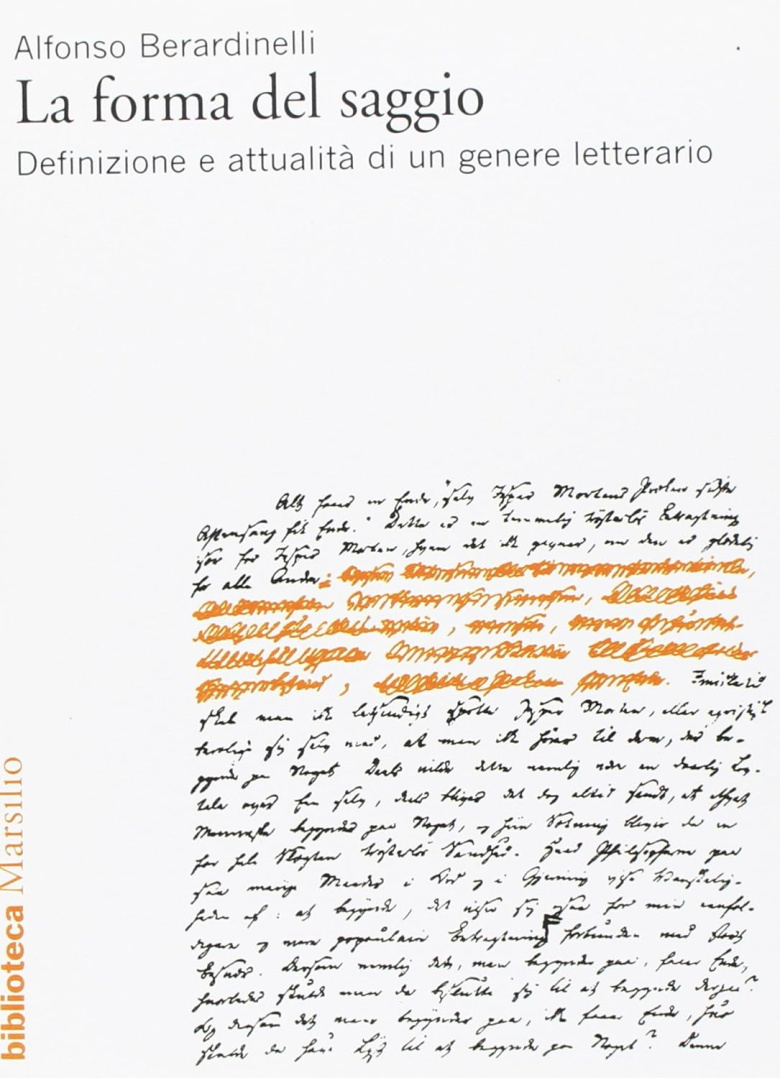
Certo, con gli stessi presupposti, la si sarebbe potuta fare un po’ meno letteraria. Qui la stragrande maggioranza degli autori è costituita da scrittori e critici letterari. Un solo economista: Luigi Einaudi (forse uno come Carlo Cipolla poteva essere convitato per il piacere dei lettori); due o tre gli storici, due i musicologi, solo Longhi per gli storici dell’arte. Ma anche nel campo della letteratura spiace non vedere Dionisotti, perché in molti suoi saggi ci sono pagine di un’autobiografia intellettuale e politica che entrano nel vivo della storia italiana. Altra assenza è quella di Carlo Bo, vista l’importanza che si dà a Renato Serra come “proto-esistenzialista” e per la sua concezione di letteratura come istanza ultimativa. Bo è stato il critico più influenzato da Serra e non è certo un caso che il suo saggio più famoso sia intitolato Letteratura come vita. Se il parametro di inclusione fosse stato la brillantezza della prosa, sull’esclusione di Bo si sarebbe tutti d’accordo; con l’impostazione dei curatori ci poteva senz’altro stare. Ma l’assenza che stupisce maggiormente è forse quella di Vittorini, dato che le riflessioni su politica e cultura attraversano fittamente il volume (e si parlano fra loro) da Gramsci a Bobbio, a Fortini.
Comunque è sempre stucchevole e sbagliato parlare di un’antologia per quello che non c’è. Vediamo invece di sottolineare alcune cose di quel che c’è. Un autore che mi è piaciuto incontrare nel volume è Tomasi di Lampedusa. È l’unico autore del volume che parli delle opere letterarie come orologi da smontare «osservando nel loro giusto ordine le mollette, le ruote dentate, gli scatti, le viti ed i perni» per rendersi conto «di come avvenga il movimento». E la sua analisi di Stendhal, passando elegantemente attraverso Tolstoj, Joyce e tanti altri, lascia incantati. E così il volume, ingaggiando uno splendido dilettante, dà conto della possibilità di letture “tecniche” che non sarebbero mai state concesse a un accademico.
Tra i saggi cardine del volume è senz’altro Cocò all’Università di Napoli di Gaetano Salvemini, che uscì sulla «Voce» nel 1909. Una riflessione sociologica sulla borghesia improduttiva meridionale destinata al sottobosco governativo locale in un precipizio senza fondo di compromessi morali e di corruzione. Il filone del saggismo sui «costumi degli italiani» è uno degli assi portanti del volume, con ascendenza nel massimo saggista italiano pre-novecentesco, cioè Leopardi, ma qui, con Carlo Levi, Chiaromonte e Silone, indirizzato a una militante esperienza antropologica.
Altra linea portante è quella che parte da Noventa, passa per Fortini e arriva a Bellocchio e allo stesso Berardinelli. Una genealogia di polemisti appartenenti a una sinistra critica, impegnati contro il filisteismo culturale (che in Berardinelli si indentifica soprattutto con il mondo universitario). L’altro “figlio” di Noventa, Geno Pampaloni, c’è ma rientra meno in questa linea ricoprendo un ruolo di critico letterario più tradizionale. Non a caso di Noventa è stato scelto il saggio su Uomini e no, che verte sulla profonda scissione del protagonista del romanzo di Vittorini e che è dedicato a Fortini e Pampaloni, nella «loro antica e attuale discordia che più li unisce a me». Bellocchio e Berardinelli, invece, hanno senz’altro una fratellanza più concorde nata nei «Quaderni piacentini» e poi confortata nell’esperienza di «Diario». Nei loro saggi qui selezionati è come se si volesse sottolineare la loro vicinanza, dato che di Bellocchio vengono riportate le pagine contro lo “sdoganamento” di Carl Schmitt e Ernst Jünger avvenuto durante gli anni Ottanta, e di Berardinelli viene offerto in maniera complementare il famoso saggio sull’altro grande «ex nazista non pentito», e cioè Heidegger: un saggio che passa impercettibilmente dalla gustosa parodia alla precisa analisi demolitoria del linguaggio e dei procedimenti retorici del filosofo tedesco e di due dei suoi seguaci: Derrida e Severino.
Uno scrittore che ha un posto di rilievo nell’antologia è Garboli: per la sua posizione tutta pro Sainte-Beuve contre Proust, per l’intreccio di autobiografia e critica (come si vede qui nello scritto su Dante), per l’attenzione alle sensazioni nella lettura, per l’impegno civile, e perché è forse l’autore le cui opere più si avvicinano a quel «romanzo delle idee» che è la definizione di saggio prediletta da Marchesini sulla scorta di Savinio e dello stesso Garboli. Ma pur da isolato quale è stato, senza maestri e senza allievi (ma con un certo numero di imitatori), anche Garboli partecipa al fitto gioco di echi e incroci che percorre il libro. Citate in più punti e da autori vari sono la sottise della prima poesia dei Fiori del male e la bêtise tanto raccontata da Flaubert. Che sono le chiavi di lettura del primo breve saggio garboliano qui antologizzato, Come ridere di Lacan?, e sono un altro dei fili conduttori del volume.
La ricchezza del libro è notevole e si potrebbe parlare ancora di tanti autori e di tanti singoli saggi. Mi limito a sottolineare nuovamente l’accorto lavoro dei curatori che con le loro scelte, a volte di parte ma sempre coerenti, hanno fatto rimbalzare continuamente temi, questioni e personaggi da un saggio all’altro, da un autore all’altro. Ne deriva un libro assai compatto e molto piacevole da leggere nonostante la mole: una sorta di iper-romanzo della cultura italiana del Novecento.