Solitudini
“Ho molti amici lacaniani e posso dire che sono persone proprio come noi”. Quando Tommaso Labranca scriveva così stava esprimendo tutta la sua insofferenza per la fascinazione dei curatori d’arte – una posa, ai suoi occhi di critico spietato di ogni posa – per la filosofia francese del Novecento. Sembra quasi di riassaporarla, questa insofferenza, nelle primissime pagine del nuovo libro di Tommaso Tuppini (Senza gli altri. Esperienza assoluta e solitudine, Solferino, 311 pp.), che pure di filosofia francese ne mastica, avendo scritto di Deleuze, Derrida, Bataille e un libro a quattro mani con Jean-Luc Nancy. Piuttosto, Tuppini sottopone a critica una certa retorica dell’alterità, degli altri, del Grande o Assolutamente Altro: “oppure altrə, altr*. Non sappiamo più come dirlo. L’importante, però, è dirlo” (p. 9). Va da sé che qui non si tratta solo di filosofia. In ogni cosa che studiamo e facciamo, nei libri che leggiamo e nelle nostre attività quotidiane, l’Altro ci sommerge fino quasi a soffocarci: “l’impero degli Altri è uno spazio a comunicazione diffusa e totale” (p. 20). È così, ad esempio, nell’ossessione contemporanea per la condivisione: si tratti di esperienze, racconti, viaggi, emozioni o reel su Instagram, siamo costantemente chiamati a “condividere” qualcosa con gli altri. Era proprio Lacan a dire che fin dalla nascita siamo gettati nel regno dell’Altro; di quell’Altro che ci assegna un nome che noi non scegliamo e che ci contraddistinguerà durante la vita e dopo la morte.
Ma il moto di insofferenza da cui prende avvio il libro di Tuppini non è indirizzato al grande psicoanalista e filosofo francese né a nessun altro autore nello specifico. È un’insofferenza che nasce piuttosto lì dove l’impero degli Altri punta il dito contro l’individuo e rintraccia in un fantomatico eccesso di individualismo la radice di tutti i mali politici, economici, intellettuali del nostro tempo. Tutto ciò che è intimo, profondo e non condivisibile viene stigmatizzato.
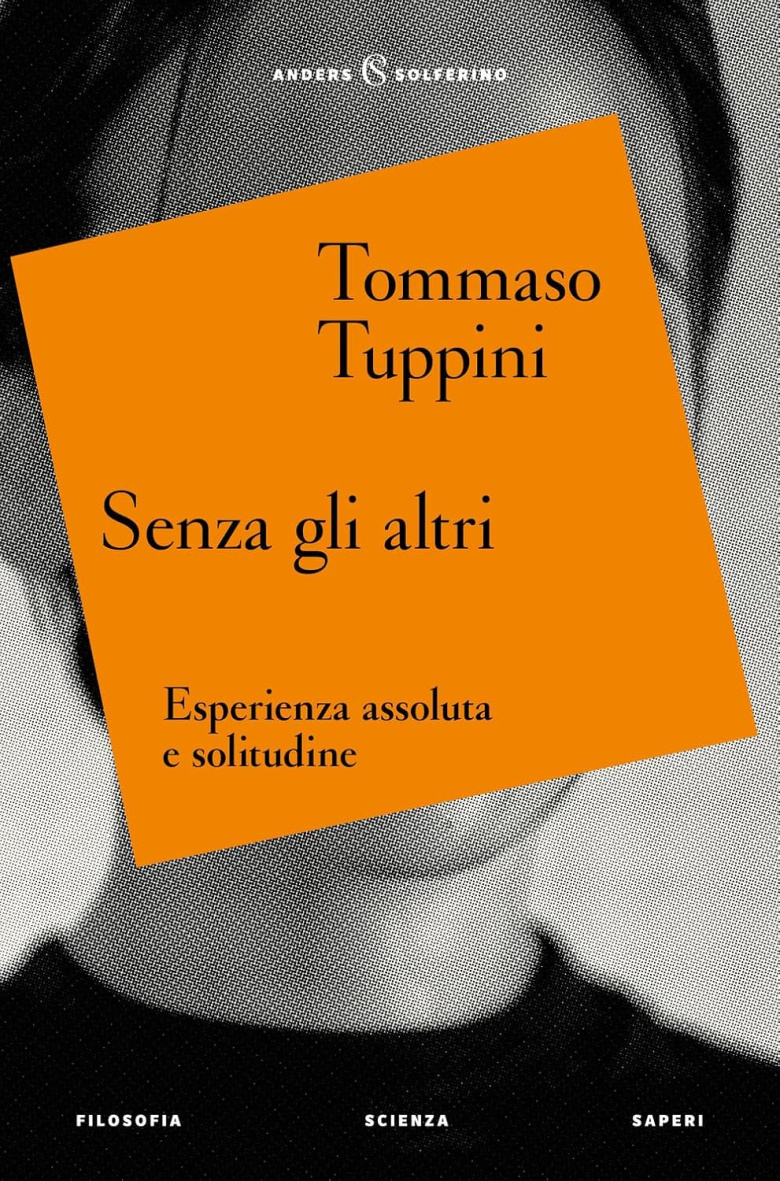
Ebbene, la pretesa di Tuppini in questo libro – di cui, oltre che la proposta teoretica, merita di essere meditato con attenzione anche il risvolto etico-politico – non è solo mostrare come questa sia una visione semplicistica e ingenerosa di come stanno davvero le cose, ma anche sostenere che una prospettiva radicalmente individualista è, a rigore, la più coerente sul piano filosofico, con buona pace dei tanti sforzi messi in campo dalla filosofia per sfilarsi dalle accuse di solipsismo e di guadagnare un piano di intersoggettività. In effetti, in-dividuo non dice nient’altro che un’unità indivisibile, assoluta, irriducibile e, potremmo aggiungere, concreta. Si tratta di un completo rovesciamento del tradizionale senso comune filosofico che, fin dagli antichi, ha sempre collocato il vero e il concreto nell’universale.
Prendiamo ad esempio il bimillenario pregiudizio della filosofia nei confronti della sensazione. Almeno da Platone a Hegel, la sensazione viene vista come un fenomeno pre-conoscitivo proprio perché legata alle facoltà percettive del singolo individuo: nessuno vede o sente quello che vedo e sento io esattamente nel modo in cui io lo vedo e lo sento. La sensazione non è conoscenza proprio perché non è universale né universalizzabile. Per dirla con Vico, sentire non è ancora avvertire “con animo perturbato e commosso”, né, tantomeno, “riflettere con mente pura”. Si tratta di una fenomenologia impietosa, che non sembra lasciare troppo spazio ai diritti della sensazione, incapace com’è di identificare i contorni precisi del proprio oggetto e quindi di distinguerlo da altro. Ecco, Tuppini mostra come la sensazione non soltanto non sia quell’avvertimento confuso che viene negato e superato dal giudizio percettivo, ma è, propriamente, l’unica esperienza che abbiamo. Tutto è sensazione. E la sensazione è esperienza assoluta, priva di limiti.

Questo vale anche per la vista, il senso a cui Aristotele riservava il gradino più alto nel podio delle facoltà sensibili, perché è quella che più delle altre ci consente di distinguere, di individuare i confini delle cose, ognuna altra dal suo altro, all’interno di un campo (quello visivo) ben definito. Al contrario, nella prospettiva delineata nel libro, la vista è l’espressione più piena di quell’esperienza assoluta in cui tutto è uno. Noi non vediamo oggetti, vediamo un continuo che, per convenzione e convenienza, rendiamo discreto.
Ma, si dirà: sicuramente la vista ha dei limiti, esclude molto dal suo campo. Quali sono questi limiti? Che cosa esclude la vista? Se alziamo gli occhi non vediamo il confine del campo visivo, ma soltanto i contorni sfumati delle nostre ciglia. Ciò che vediamo è sempre una totalità senza limiti. Così, quando due spadaccini duellano, in realtà essi non sono mai due, ma sempre un’unica attività, un plesso articolato che l’attività riflessiva scarnifica, ritaglia, opponendo al soggetto riflettente gli oggetti della riflessione. Soggetto e oggetto, quindi, altro non sono che i prodotti della riflessione; essi sorgono in un momento successivo all’esperienza immediata in cui a duellare è un unico ‘si’ impersonale. Tuppini si rivolge ad autori esterni al canone maggiore del pensiero occidentale: William James e Raymond Ruyer fanno da guida alla sua rivalutazione dell’esperienza assoluta e alla sua critica dell’idea di relazione o, quanto meno, dell’idea che l’esperienza si costituisca soltanto nella relazione tra qualcuno che fa esperienza e qualcosa che viene esperito.
Difendere i diritti dell’esperienza assoluta non è un compito facile: significa, come detto, difendere il primato della sensazione sulla percezione, della solitudine sul senso di comunità, dell’individuo sul bene comune, dell’atomo sull’aggregato, della sostanza sulla relazione, dell’uno sui molti. Si tratta di una posizione filosofica tanto coraggiosa quanto pienamente consapevole che l’uno, nel momento in cui si contrappone ai molti, da questi è già pienamente assorbito e che quando si parla di molteplicità si parla pur sempre di una molteplicità. La questione diventa allora quella della differenza tra molteplicità organiche, gli individui, e molteplicità aggregate: «Un individuo possiede un ritmo d’insieme che coordina gli elementi. L’aggregato, invece, un ritmo d’insieme non ce l’ha. Gli elementi dell’aggregato continuano a fare ciascuno la propria vita indipendente» (p. 183). A differenza di quanto accade nei semplici aggregati, l’individuo “sorvola” i suoi componenti conferendo loro armonia e organicità. Caratteristica degli aggregati è anche quella di esistere solo per un soggetto che li percepisce creandoli, conferendo loro una autonomia e un’organizzazione che di per sé non hanno. A dare la dignità di individuo organico a un semplice aggregato può essere il complottista, che rintraccia fantomatici collegamenti in eventi scollegati tra loro, o il magistrato troppo zelante, quando non insegue le prove di un reato ma le verifiche di una sua ipotesi assunta come verità apodittica.

Ora, ammettiamo pure che l’esperienza sia assoluta e che essa si risolva di volta in volta nell’istante presente, in cui la totalità del passato e del futuro collassa in un presente infinito. Se è così – potremmo chiederci – se l’esperienza non è altro che un continuo e inarrestabile “sì” alla vita, da dove viene l’errore, l’inciampo, la sofferenza, il male? Tutto questo, spiega Tuppini, deriva di nuovo da un eccesso di interpretazione e di riflessione. La sofferenza o anche soltanto il fastidio che si genera in me se la gita che avevo programmato salta per il maltempo, o se la mia ragazza mi pianta in asso (sono esempi che troviamo nel libro che ha, tra gli altri meriti, la capacità di unire la speculazione rigorosa a quelle che Kant chiamava “fertili bassure dell’empiria”) è soltanto perché la riflessione proietta nel futuro uno scenario alternativo a quello del presente assoluto in cui collassa ogni esperienza. La riflessione è pertanto un grosso equivoco, una deviazione rispetto alla via dritta dell’esperienza pura. È una deviazione necessaria? È un inciampo evitabile? Il confronto con la proposta teorica del libro potrebbe, a questo punto, ricominciare e collocarsi su un altro piano, con accresciuta consapevolezza e nuove domande.
In copertina, A Laren Scene, Jozef Israëls.







