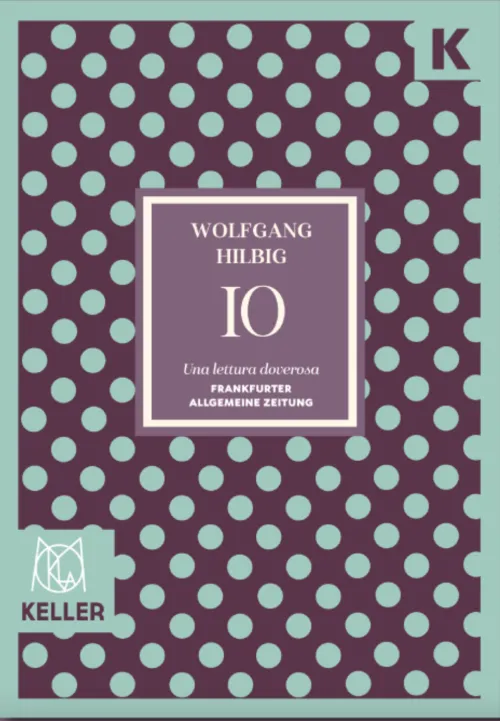Wolfgang Hilbig, fochista con la macchina da scrivere
C’è un romanzo di Yoko Ogawa in cui le persone non sanno più a cosa servono gli oggetti. Perché nell’Isola senza memoria (tradotto da Laura Testaverde nel 2018 per il Saggiatore) la Polizia Segreta di un regime totalitario ha deciso di sequestrare i ricordi degli abitanti. È riuscita ad annullare, così, il senso della realtà, visto che le cose non hanno più un nome, un’identità precisa, una chiara utilità. Qualcosa di simile accade nel Palazzo dei sogni di Ismail Kadare (tradotto da Liljana Cuka per La nave di Teseo nel 2024), dove un Potere invasivo decide di creare una minuziosa mappa delle visioni oniriche che riempiono le notti dei suoi sudditi. Per paura che in quei liberi voli della mente si annidi il complotto capace di rovesciare la dittatura.
Fantasticherie da romanzo? Niente affatto: a leggere il saggio del filosofo Byung-chul Han Le non cose (tradotto da Simone Aglan Buttazzi nel 2022 per Einaudi), viene da pensare che il granitico ordine dei mondi distopici immaginati dalla scrittrice giapponese e dall’autore albanese sia stato di gran lunga superato, nel nostro presente, da uno strisciante “tsunami delle informazioni”. Una dittatura digitale, insomma, solo in apparenza utile e amichevole, ma capace, in realtà, di azzerare e poi sostituire i vecchi equilibri sociali e politici.
“Non abitiamo più la terra e il cielo, bensì Google Earth e il cloud”, avverte l’ex docente delle Università di Friburgo, Monaco di Baviera e Berlino, nato a Seul. “Guidato dagli algoritmi, l’uomo si trova davanti a un mondo che sfugge alla sua comprensione. Si attiene a decisioni algoritmiche che non riesce a capire fino in fondo”.
Ma come siamo arrivati a scardinare quell’ordine terreno che Hannah Arendt, come Martin Heidegger, legava alla “fatticità”, al contatto concreto, continuo e irrinunciabile con la realtà? Un’ipotesi inquietante la formula un romanzo nato all’ombra del Muro di Berlino e di un equilibrio politico mondiale disegnato dagli accordi di Yalta del febbraio 1945. Quando il mondo venne spartito tra l’Unione Sovietica di Iosif Stalin, l’America di Franklin Delano Roosevelt e la Gran Bretagna di Winston Churchill. Lo ha scritto Wolfgang Hilbig, cresciuto dalla madre e dal nonno analfabeta a Mauselwitz, un paesino dell’ex DDR, la Germania comunista. Si intitola Io e arriva soltanto adesso in Italia, a oltre trent’anni dalla sua uscita nella Germania riunificata per l’editore Fischer. Lo hanno tradotto con grande cura Roberta Gado e Riccardo Cravero per Keller editore (pagg. 366, euro 20).
Io nasce da un percorso tormentatissimo, che ha segnato l‘esistenza di uno dei maggiori poeti e narratori in lingua tedesca del ‘900. Wolfgang Hilbig, nato nel 1941, è vissuto per molti anni facendo il fuochista in fabbrica, pur dedicando gran parte del tempo libero alla scrittura. Bersagliato dalla censura, arrestato e poi rilasciato con la proposta di diventare un informatore degli spioni della Stasi, è morto alcolizzato a Berlino nel 2007 a 66 anni. Dopo che, nel 1987, aveva deciso di usufruire di un permesso di espatrio temporaneo dalla DDR, per non farvi più ritorno.
La vita di Hilbig si specchia, in parte, nelle pagine di Io. Al centro della storia c’è W., uno scrittore di provincia che fatica a farsi notare dagli editori, anche se non smette di credere nella letteratura. A guardarlo muoversi nella vita quotidiana sembra un uomo senza importanza, senza qualità, che replica di continuo la sua banale routine, come mille altri, guadagnandosi da vivere lavorando. Ma lui è uno dei cittadini della DDR, dove niente deve sfuggire al controllo della Ditta, agli invisibili, onnipresenti agenti della Stasi. Perché lì, con la benedizione dell’Urss, si sta costruendo una società che si crede perfetta.
La Ditta escogita uno stratagemma raffinato per incastrare, e poi, arruolare lo scrittore. Lo convoca nella stanza 17 del municipio, dove un misterioso Capo comunica a W., dal “visino ipersensibile alla David Bowie”, che è diventato padre di un bambino. A niente valgono le sue rimostranze per spiegare che ci dev’essere un errore: lui non ha mai generato neonati. Ma la verità, nella Germania dell’Est, è qualcosa di sfuggente, manipolabile a seconda degli interessi del momento.
E allora? Semplice: se accetta di diventare un informatore della Stasi, con il nome di Cambert, allora sarà lo Stato a provvedere a lui. Gli pagherà un alloggio, farà in modo che le sue poesie vengano pubblicate. Verserà gli alimenti alla mamma del bambino, come prevede la legge. Insomma, non dovrà più sfinirsi con turni massacranti né sacrificare una buona parte della paga di addetto alle caldaie dell’azienda per cui lavora.
Provare a sfuggire agli uomini della Ditta è impossibile. Perché loro sono dappertutto e hanno il potere di modificare la realtà a proprio piacimento: “Crede davvero che non riusciremmo a dimostrare che il bambino è suo figlio? – gli dicono a brutto muso –. Ci riusciremmo persino se lei non avesse mai visto una donna orizzontale in vita sua”.
Nel mondo in cui si muove W., alias Cambert, l’oggettività delle cose non ha più alcun valore. La Ditta non è interessata tanto a punire i suoi informatori, quanto a creare una narrazione dei fatti che pieghi la realtà alla propria visione, a un credo totalmente appiattito sulla ragion di Stato. “Saremmo arrivati al punto di non riuscire più a classificare senza ombra di dubbio se le cose su cui indagavamo appartenevano ancora all’ambito della simulazione o in nuce erano già diventate realtà”, finirà per ammettere Cambert.
Il fine ultimo della Ditta, sempre all’erta “come cani da caccia”, non è punire chi contravviene alle regole, bensì trascinarlo dentro il labirinto e arruolarlo come informatore. Perché il sogno del Potere è quello di creare uno Stato fatto di spioni, di occhi attenti, di orecchie sempre all’erta. In un sistema del genere nessuno si può sentire al sicuro: nel momento stesso in cui smettesse di rigare dritto “la catastrofe sarebbe tornata a galla”. E i fascicoli con le informazioni raccolte sul comportamento dello stesso W. lo avrebbero inchiodato alla propria colpa.
La macchina del controllo trascina Cambert dentro un meccanismo perverso, che funziona senza inciampi. Perché riesce a trasformare le ipotesi, i sospetti, le elucubrazioni, in verità indiscutibili. Nemmeno le occhiute spie possono considerarsi al sicuro in un mondo dove tutti sono potenziali colpevoli: “Sorvegliare gli agenti dei servizi nell’esercizio della propria funzione, sorvegliare i sorveglianti, costringerli a vigilare sui propri pensieri che inevitabilmente affioravano dalla consapevolezza di essere sorvegliati… sorvegliare il sonno… sorvegliare che nel sonno fosse soltanto l’io a dormire, mentre la sorveglianza perseguiva la propria coerenza”.
In questo universo così grigio, ossessivo, perfettamente sotto controllo, dove “non poteva succedere niente di oscuro”, a Cambert viene affidato un caso piuttosto difficile. Deve seguire passo passo le tracce di un misterioso Reader, autore di testi che ama leggere nel corso di una serie di incontri semiclandestini potendo contare “su un pubblico in costante crescita, con piccole comunità annidate in molti quartieri” di Berlino Est. Ma il sospettato si rivela sfuggente, appare e scompare, fa precipitare l’informatore della Ditta in una vertigine di smarrimento, che lo spingerà a perdere il contatto con se stesso e con la realtà: “Poteva succedere che dentro di me la realtà si facesse fantastica, anomala, e che da un momento all’altro l’unica tranquillità che mi restava fosse una simulazione difficile da sostenere”.

Perfino quando W. tenta di fissare sulla carta qualcosa che possa dare un senso concreto alla sua esistenza, finisce per rendersi conto che è capace di produrre soltanto “una congerie di ipertrofiche autorappresentazioni stilizzate (di un sé inventato)”. E che nemmeno l’aggrapparsi alla “noiosa quotidianità” è in grado di fermarlo dal cercare evasioni in territori immaginari.
Giorno dopo giorno, la Ditta ottiene il suo scopo. Trasforma W. in un burattino che non riesce più a muoversi se non è governato dagli strattoni che i suoi stessi burattinai imprimono ai fili. Così, lo scrittore si rassegna ad accettare il torbido pensiero di uno dei superiori della Ditta: “Vede meglio chi guarda la luce nelle tenebre”.
Ma il suo calvario non è ancora finito. Perché quando crede di avere raggiunto un precario equilibrio, la situazione attorno a lui cambia di nuovo. Il suo stesso superiore viene messo da parte. Il metodo di controllo dei sospetti, usato fino a quel momento, deve mutare, rinnovarsi. Anche Reader non interessa più tanto agli agenti della Stasi. In fondo, sono loro a dettare le regole e hanno facoltà di stravolgerle a piacere in qualunque istante.
Cambert è uno scrittore, quindi dovrebbe trovarsi a suo agio in quell’indefinibile precarietà: “Per il poeta la realtà non è che uno squallido sogno, o sbaglio?”, gli chiederà il Tenente, conosciuto anche con il nome di Feuerbach. Del resto, da quando il famoso poeta e musicista Wolf Biermann è scappato all’Ovest, “anche per noi il mondo era diventato un sogno squallido”, ammetterà l’agente della Ditta. Perché non è facile inventare dal nulla un nuovo nemico. Uno spauracchio che si carichi sulle spalle il coraggio di criticare una società che si ritiene perfetta, e che vada poi incontro al suo funesto destino.
Anche W., allora, si deciderà a cambiare obiettivo. Individuerà una nuova pista, comincerà a pedinare una misteriosa studentessa venuta dall’altra parte del Muro, dall’Ovest. Senza accorgersi che, così, infrangerà tutte le regole e rischierà di perdersi definitivamente in un labirinto di significati contraddittori. Dal momento che proprio il cambiare orizzonte investigativo, senza ricevere ordini precisi, si rivelerà “un segno che nel nostro Paese le costellazioni non erano più chiare come sembravano”.
Finirà per crollare, quel maledetto Muro, a partire dal 9 novembre del 1989. E con lui svanirà anche il mostruoso apparato poliziesco. Ma dagli oscuri cunicoli della Berlino raccontata da Io, dalle clastrofobiche stanze del Potere, dai sotterranei dove si trama e si bisbiglia, dilagherà nel mondo un metodo di controllo capace di mutare forma, linguaggio, ideologia. Ma che avrà sempre lo stesso obiettivo: disintegrare l’identità delle persone. Moltiplicare il loro io in un perverso gioco di specchi, fino ad annullare ogni certezza in quel rincorrersi di identità interlocutorie.
Quando Herta Müller, Premio Nobel per la Letteratura 2009, è riuscita finalmente ad andarsene dalla Romania di Ceaușescu, nel 1987, il ricordo del condizionamento poliziesco della Securitate l’ha pedinata come un’ombra maligna. “In Germania non riuscivo a vivere serenamente – ha raccontato nel 2015 in un incontro organizzato a Milano nell’ambito di Bookcity –. Portavo dentro di me il tormento di immaginare che i tedeschi mi considerassero una spia del mio Paese. Dopo anni di inquisizione poliziesca, insomma, erano riusciti a modificare il mio rapporto con la realtà. Nella mia testa non ero più la vittima della censura, degli interrogatori persecutori, ma una sorta di complice dei miei carnefici”.
Io non è una riscrittura in salsa germanica del Processo di Franz Kafka. E nemmeno una testimonianza che il Grande Fratello di 1984 di George Orwell ha già vissuto fianco a fianco a noi. Questo romanzo bracca il lettore con una scrittura magmatica e ipnotica, lo ossessiona fino a convincerlo che il Potere ha messo a punto, nel corso del tempo, un sistema infallibile per rendere gli uomini schiavi. Perché ha saputo manipolare la realtà fino ad annullarla del tutto, sostituendola con le proprie verità farlocche. È riuscito a imporre dogmi indiscutibili. Ha spacciato false notizie per fatti inoppugnabili, inquinando perfino le fonti a cui si abbeverano gli studiosi della Storia.
Così, dittatura dopo dittatura, il controllo delle menti si è fatto invisibile. E, proprio per questo, sempre più difficile da esorcizzare. Perché, avvisava Hilbig nel finale di Io, piano piano siamo diventati “il lato oscuro dell’umanità, fatto carne e ombra”. Senza mai smettere di illuderci di avere sotto controllo un sistema che ci sta inesorabilmente incatenando.