Diario clinico 2 / Un terapeuta acrobata tra lettino e Skype
Si inizia con: “ma lei adesso dov’è?”. Perché il terapeuta, si sa, è nel suo studio, ma il compagno d’analisi non varca la soglia, non suona il citofono, si annuncia con il segnale Skype. E, ogni volta, si cambia location. Roberto è sempre in macchina, al buio con la mascherina, sono gli occhi che segnalano lo stato d’animo. Luisa è sempre in tuta, con la coperta sul divano, si è appena svegliata, tra poco in ospedale inizia l’ennesimo turno di notte. Marco è sempre nello sgabuzzino, ogni tanto si alza e controlla che la porta sia chiusa davvero. Annabella preferisce una panchina che garantisce la sua privacy. Luigi arriva senza preavviso, non ce la fa più a fare a meno della presenza, una donna si annuncia per una richiesta urgente, e irrompe in studio in monopattino.
La pandemia ha scombussolato le regole del setting, mutato il rapporto con il tempo e il denaro, scardinato quell’atmosferico così speciale della stanza d’analisi, fatto di ripetizioni di gesti formali e di racconti di un materiale tremendamente privato. Il terapeuta è catapultato nell’intimità casalinga dell’altro, investito dalla drammaticità dell’impoverimento economico, da stati d’animo inediti che non possono essere riduttivamente etichettati come narcisismo o depressione.
Apro e chiudo il computer, sanifico e spruzzo igienizzanti, mi metto e mi tolgo la mascherina, tengo aperta la finestra e rimango con il piumino. Mi sento un acrobata, chiamato più volte al giorno a compiere un salto mortale. Per rovesciare l’impossibilità in possibilità. Il diffuso senso di impotenza in potenzialità. Mi aiuta Freud, che utilizzava la formula man kann, si può, noi possiamo, per evocare la forza di un campo analitico. Jung, che annoverava tra le auspicabili caratteristiche di un terapeuta la capacità di adattarsi all’insopprimibile unicità dell’altro. Mi ritrovo in Ferenczi, convinto assertore dell’elasticità.
Intanto è passato un anno. Forse anch’io mi sono sbiadita, alla ricerca affannosa di quella parola levata a tenda, come dice Celan, capace di riunirci.
So che non c’è un pronto soccorso per la psiche: vicende amicali, situazioni analitiche, inclinazioni personali hanno estremizzato la tendenza personale al “farmi carico”. Una sorta di assorbimento psichico che ha accresciuto il bisogno di tempo dilazionato, di momenti di essere. Che per molti mesi mi ha reso difficile ritemprarmi con la mia autoterapia preferita, quella con la pagina stampata. Adesso leggo di nuovo, non mi sento in colpa se scavalco montagne di email, e ignoro i nuovi amici di WhatsApp.
Mi sono tuffata in libri pubblicati da poco, che non hanno paura di nominare l’io del terapeuta, di parlare delle sue umane défaillance.
Come fa un gruppo di analisti della Società Psicoanalitica Italiana, che fotografa la nostra caducità a partire da un’espressione tratta da Malattia come metafora, ormai un classico nel quale Susan Sontag affronta gli stereotipi, le fantasie punitive e sentimentali della nazione dei malati per liberarli “dall’uso figurato o metaforico della malattia”.
“La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più gravosa. Ogni nuovo nato detiene una duplice cittadinanza, nel regno dei sani e nel regno degli infermi. E per quanto preferiremmo tutti servirci soltanto del passaporto migliore, prima o poi ciascuno di noi è costretto, almeno per un certo tempo, a riconoscersi cittadino di quell’altro luogo”.
Il lato notturno della vita. Corpo malato e relazione analitica, (a cura di Tonia Cancrini e Daniele Biondo, Franco Angeli, 2020), racconta, con gran ritmo e in modo coinvolgente, percorsi, a volte lunghi a volte brevi, attraversati dall’incontro con i dolori del corpo e la paura di morire. Come accade, in diversi passaggi dell’esistenza, ai protagonisti delle storie riportate. Situazioni così particolari dove la cornice muta: è il terapeuta ad andare in visita dal suo paziente malato, controlli medici e chemio scombinano il calendario degli incontri.
Improvvisare, inventare, accettare, non avere troppa paura del dolore degli altri. Consapevoli che, un giorno, possa capitare anche a noi.
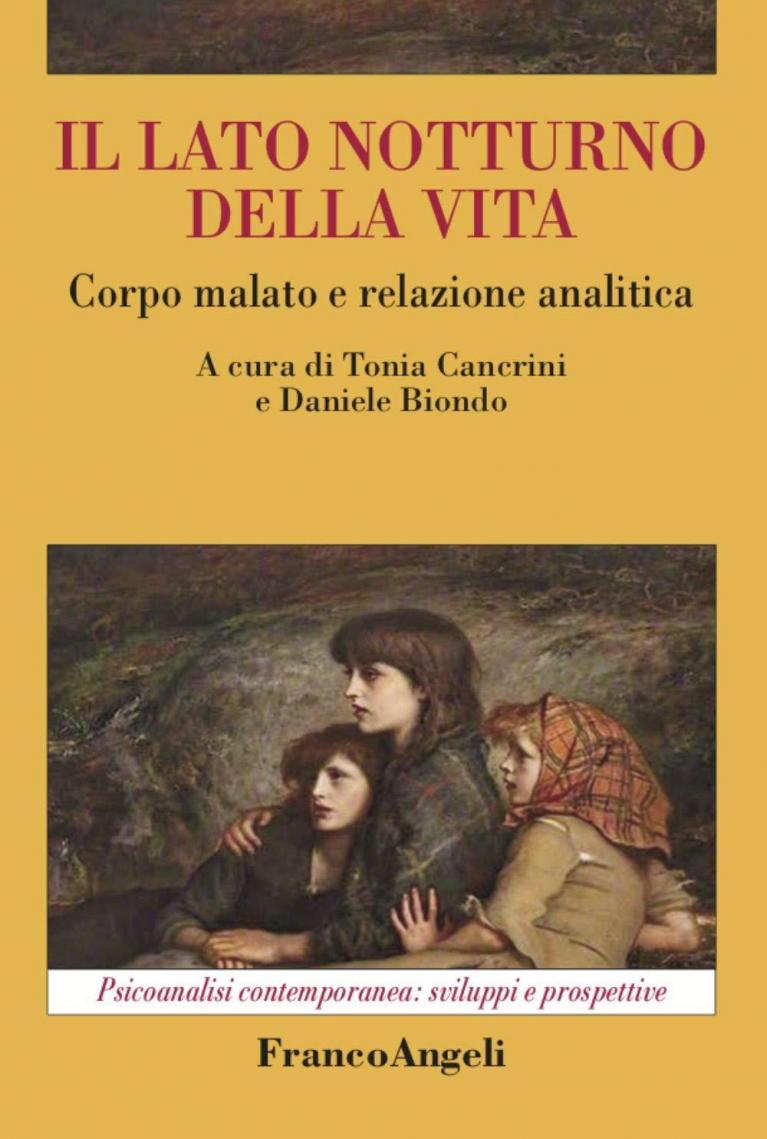
Sta qui l’originalità di una ricerca che ci propone un incontro inedito con lo stesso Freud. Nel saggio di Daniele Biondo, Freud non è più l’eroe titanico in lotta per afferrare il significato della tragedia del fato di Edipo e della tragedia del carattere di Amleto, ma un omino vecchio e fragile che ha stretto un patto con il suo medico per il momento dell’addio. Segnato dalle vicende della Grande guerra, colpito da lutti personali, tormentato per decenni dalla sofferenza quotidiana di una protesi, conseguenza delle numerosissime operazioni per un cancro alla mandibola, Freud si presenta come una figura stoica. Non per il suo spirito di conquistatore, nel quale si era riconosciuto, ma per la capacità di sopportazione che gli ha permesso di affrontare il lato notturno della vita. Di trasformare, fino alla fine, il dolore in pensiero, la morte in simbolo e di continuare a godere delle “piccole cose” e dell’“amore e della vicinanza affettiva dell’altro”.
Mentre sto leggendo, mi chiedo: siamo noi che non abbiamo capito questo lato di Freud, da cui ora ci pare di aver molto da imparare, oppure, pur conoscendo infiniti dettagli della sua biografia, non abbiamo osato indugiare troppo sulla dimensione umana e quotidiana?
Freud non permetteva di avvicinarsi alla sua sfera intima. Durante il viaggio per nave, nel 1909, verso gli Stati Uniti, è pronto ad affrontare il rischio di uno scandalo oltreoceano – “Non sanno che stiamo per portare loro la peste” –, ma non a svelare particolari del suo mondo privato. Insieme per sette settimane, racconta Jung in Ricordi, sogni, riflessioni, “analizzavamo i nostri sogni”. Finché, di fronte a una domanda su alcuni dettagli confidenziali, “Freud mi guardò sorpreso, con uno sguardo carico di sospetto, poi disse: ‘Non posso mettere a repentaglio la mia autorità!’. La perse in quel momento. Quella frase si impresse come un marchio indelebile nella mia memoria, e in essa vi era già un presentimento della fine della nostra amicizia”.
Lo stesso motivo porterà due decenni dopo alla drammatica rottura con Ferenczi, che non si sottomette all’autorità del maestro in disaccordo con un suo scritto – anche lui partecipa all’avventura americana, è il piccoletto, quello più povero, che vediamo nel film A Dangerous Method mentre va a dormire “in basso”, in classe economica.
E sarà proprio Ferenczi a osare un esperimento di autobiografia, all’epoca qualcosa di rivoluzionario. Nei mesi precedenti alla sua morte, tra il gennaio e l’ottobre del 1932, tiene un diario nel quale mischia resoconti clinici, ricordi personali, riflessioni teoriche e moti dell’animo. Il Diario clinico avrà un destino tormentato, vedrà la luce quasi mezzo secolo dopo.
Nata per capirsi, per vagabondare tra la nostra storia e la nostra memoria, la psicoanalisi sospetta dell’autobiografia. La self-disclosure minaccia l’immagine di un terapeuta specchio. Per diventare una figura affidabile la sua vita deve azzerarsi, si impara a diventare reticenti, sfuggenti. Si selezionano gli intimi, i colleghi fidati, i compagni d’analisi ai quali si sente di poter comunicare qualcosa di personale. Nel timore che, un giorno, magari, si insinui il dubbio che la nostra biografia non sia all’altezza di un mestiere che cerca il senso in ogni autobiografia.
Un analista può parlare del proprio io, può tenere un diario? Accennare frammenti della propria storia senza che questo appaia un eccesso di protagonismo impudico?
Il dibattito, storicamente lunghissimo, è ancora aperto. Anche se oggi, la maggioranza dei terapeuti risponderebbe probabilmente con un sì. Testi psicoanalitici contemporanei, seppure di autori con formazione diversa, arrivano a conclusioni molto simili. La soggettività del terapeuta fa meno paura, anzi è considerata un imprescindibile strumento di lavoro.
Ne è convinto Franco Borgogno, tra gli analisti italiani quello che ha più lottato per far conoscere l’opera di Ferenczi. Una vita cura una vita. Inizi, maturità, esiti di una vocazione (Bollati Boringhieri, 2020), è un appassionato diario di viaggio condotto da un analista testimone, che dichiara quanto nella sua esperienza sia stata importante l’atmosfera affettiva. Per Borgogno la vocazione terapeutica è inseparabile dalla dimensione etica. E l’incontro è una forma di educazione al vivere, se riesce a immunizzare e a contenere la sofferenza, “se è capace di tollerare la paura senza farla diventare terrore”, se riesce, in momenti difficili, a far intravedere un futuro.
Arriva postumo il diario di Elvio Fachinelli, Grottesche. Notizie, racconti, apparizioni, (a cura di Dario Borso, Italo Svevo, 2019): dal 1963, per 26 anni, fino all’estate del 1989, poco prima di morire, appunta stati d’animo e sfasature dell’io, incontri di vita e uscite bizzarre di bambini. I suoi sono calembour che registrano il mutamento antropologico dell’Italia di quegli anni.
Per Fachinelli l’analisi è un cammino iniziatico che rende possibile, come accade nel viaggio sciamanico, il cambio di sesso e di identità, il rovesciamento dei ruoli, la trasformazione di attivo in passivo e viceversa. “Sono del parere che, se nell’analisi non c’è sorpresa, e in ciascuno dei due interlocutori, non c’è analisi affatto”. Il timore della violazione del setting – che, insieme, richiede e vieta la fusione e il contagio – è prodotto da un fenomeno psichico dove non è il sesso dell’altro, ma il “non posso fare a meno di un altro” a spaventare per il suo potere d’attrazione. E “l’unico altro, l’alter, sei tu”, come scriveva Freud a Fliess. Qui, come dice Fachinelli ne La mente estatica, affiora la figura del doppio, del gemello, dell’alter. Un amico immaginario.
Leggi anche:
Nicole Janigro | Personalità "come se"







