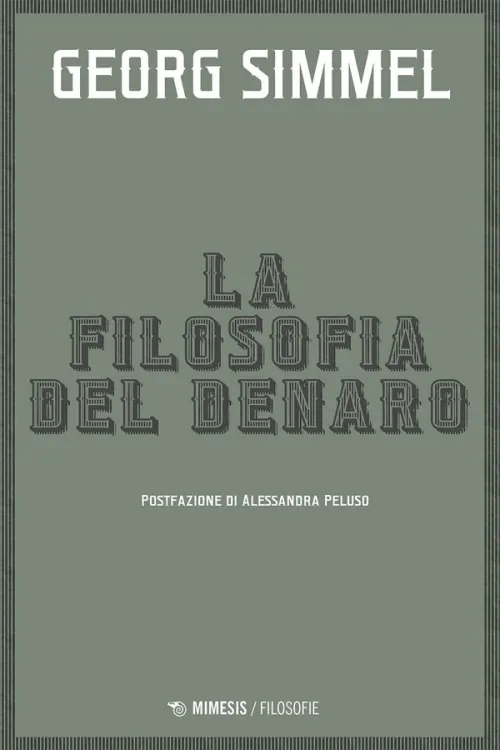Simmel: il mondo è denaro
In un suo aforisma, il fisico e scrittore Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) scrive che «in tedesco, denaro (Geld) fa rima con mondo (Welt); non è possibile che vi sia una rima più ragionevole: sfido tutte le altre lingue». Non stupisce, allora, che circa un secolo più tardi sia stato un altro autore tedesco a elaborare una riflessione sul denaro come simbolo della propria epoca. Si tratta del filosofo e sociologo Georg Simmel, nato a Berlino nel 1858, autore di Filosofia del denaro (Philosophie des Geldes). Pubblicato nel 1900, poi riveduto e ampliato nel 1907, Filosofia del denaro inaugura il Novecento facendosene portavoce. Un’opera monumentale non soltanto per le sue dimensioni, ma anche per l’estensione dei temi trattati: l’obiettivo dichiarato nella Prefazione alla seconda edizione è infatti quello di «tracciare una linea direttrice che vada dalla superficie del divenire economico fino ai valori e ai significati ultimi dell’umano nella sua totalità» (G. Simmel, Filosofia del denaro, a cura di A. Cavalli e L. Perucchi, UTET 1984, p. 87). Tale dichiarazione d’intenti mette in luce il modo di filosofare tipico di Simmel, che consiste nel muovere dalla «superficie della vita», ossia da situazioni comuni o da oggetti d’uso quotidiano, fino allo «strato ideale che è sempre sotteso a tutti i suoi fenomeni» (id., Saggi di cultura filosofica, Guanda, 1985, p. 10). Ciò viene portato avanti sapendo che giungere a un sistema filosofico definitivo, così come a una verità assoluta, è una pretesa tanto necessaria alla pratica filosofica soggettiva quanto impossibile da realizzare una volta per tutte.
La Philosophie des Geldes viene tradotta per la prima volta in italiano nel 1984 da Alessandro Cavalli e Lucio Perucchi: un’«encomiabile impresa», come l’ha definita Cacciari, destinata a rimanere un punto di riferimento per gli studi simmeliani in Italia. Nell’Introduzione, Cavalli si pone una domanda fondamentale: che senso ha proporre la lettura di un simile volume al pubblico italiano? È certamente un documento di grande interesse per gli storici della filosofia, ma «un interesse esclusivamente storico non giustificherebbe oggi la traduzione di un’opera di tale mole e complessità» (pp. 9-10). Quel che rende ragione di una simile impresa, scrive, è la vicinanza del pensiero di Simmel al tempo presente. Non è solo nei temi, ma anche nel metodo che viene rilevata l’attualità della filosofia simmeliana: una pratica di pensiero che privilegia le domande alle risposte, vive di tensioni polari, e adotta un approccio che oggi definiremmo – per usare un termine in voga – interdisciplinare.
La pubblicazione della nuova traduzione di Philosophie des Geldes a cura di Alessandra Peluso (La filosofia del denaro, Mimesis 2025) è l’occasione perfetta per chiedersi, seguendo l’esempio di Cavalli e Perucchi, che senso abbia riproporre oggi la lettura di una simile opera. Ha ancora qualcosa da dirci, o è diventata soltanto materia da storici della filosofia? Il che, in un certo senso, equivale a chiedersi: il denaro può essere (ancora) considerato simbolo del nostro tempo?
Prima di affrontare queste questioni è bene soffermarsi sulla struttura dell’opera. Filosofia del denaro è composto da due parti: Parte analitica e Parte sintetica. La prima, come scrive lo stesso autore nella Prefazione, è volta a individuare le condizioni che determinano l’esistenza e il significato del concetto di denaro. Questa si compone di tre capitoli di lunghezza omogenea, suddivisi a loro volta in tre sezioni. La Parte sintetica indaga invece gli effetti del denaro sulla società e sulla vita degli individui che la compongono; anch’essa è divisa in tre capitoli, con la medesima suddivisione in tre sezioni ciascuno.
L’edizione a cura della Peluso riproduce l’esatta struttura formale della versione tedesca del 1907, a cui le due traduzioni italiane si riferiscono; l’edizione di Cavalli e Perucchi, invece, aiuta il lettore a orientarsi di fronte al “muro di testo” simmeliano, trasformando il sommario originale in un indice analitico, e suddividendo il corpo testo con i paragrafi elencati nell’indice. Non mi soffermo su questi aspetti per mera pedanteria, ma per enfatizzare il contrasto tra la perfetta simmetria delle sezioni che compongono Filosofia del denaro e lo stile filosofico di Simmel, sopra accennato. Si diceva, infatti, che obiettivo di Simmel non è costruire un sistema filosofico definitivo; al contrario, sarebbe per lui una pretesa impossibile da realizzare. E infatti, la partizione dell’opera non è il riflesso di un’altrettanto rigorosa architettura logico-argomentativa. Ciò non significa che non vi siano una suddivisione tematica o una logica interna, ma che ogni capitolo si lega e si distingue dagli altri in modo peculiare: ogni sua parte, scrive Peluso, «costituisce un dettaglio a sé che nell’insieme rende l’unità, la totalità del tutto» (Postfazione, p. 724), consentendo, a chi vuole, di poter leggere Filosofia del denaro anche partendo dall’ultimo capitolo (“Lo stile della vita”), come consigliato dallo stesso Simmel all’amico Hermann Keyserling nel 1908. È Cavalli, nell’Introduzione del 1984, a fornirci un’immagine utile a orientarci in questo testo, presentandolo come se fosse un intreccio di fili: ciascuno di essi mantiene la sua autonomia, contribuendo a costituire la trama nel suo insieme; allo stesso tempo, ogni filo tirato potrebbe influenzare l’intera tessitura, modificandola di volta in volta. Questa costruzione non risponde solo a un’esigenza espositiva, ma esprime un punto cruciale del pensiero simmeliano, che si fonda sulla possibilità di pensare la totalità come rete dinamica di relazioni senza dover ricorrere alle nozioni di essenza, di eternità o di assolutezza. In altre parole, immaginarsi dei fili che si annodano e si sciolgono incessantemente, componendo con questo movimento un’unica superficie, è utile a figurarsi ciò che per Simmel costituisce la società, e più in generale, la realtà nel suo complesso.
Questa immagine rappresenta, seppur in modo semplificato, la visione relativistica (o meglio, “relazionistica”) del mondo che, per Simmel, raggiunge il suo massimo sviluppo nella modernità. Ma attenzione, perché il relativismo così inteso non ha nulla a che fare con lo scetticismo. Antonio Banfi, allievo di Simmel a Berlino, descrive il relativismo simmeliano come una concezione della realtà «per cui ogni determinatezza si risolva in una incommensurabile ricchezza di relazioni» che la definiscono come tale; «una concezione cioè per cui ogni obiettività sia il termine ideale di un complesso di rapporti, in cui […] oggetto e soggetto siano ugualmente e vicendevolmente implicati e caratterizzati» (Il relativismo critico e l’intuizione filosofica della vita nel pensiero di G. Simmel, in G. Simmel, I problemi fondamentali della filosofia, Isedi 1972, p.14). Il perno concettuale di questa visione del mondo, così come dell’intera filosofia simmeliana, è il concetto di azione reciproca, in tedesco Wechselwirkung. Tradotta anche come “interazione”, la Wechselwirkung implica la reciprocità dei suoi termini, che si definiscono come tali proprio nella relazione. Caratteristica peculiare dell’azione reciproca è quella di generare una “circolarità virtuosa”, una sorta di rimbalzo continuo di azioni e reazioni, il cui movimento costituisce il tessuto della realtà sociale e non.
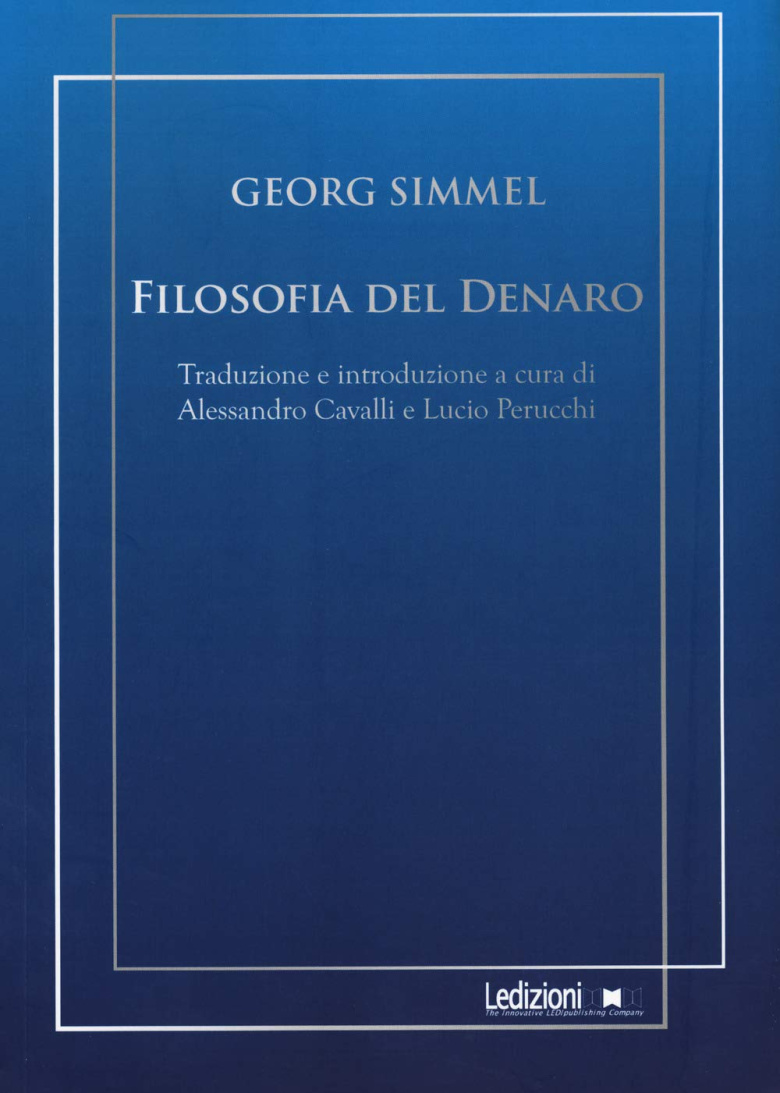
Ora, giustamente, mi si potrebbe chiedere cosa c’entri tutto questo con il denaro e con l’attualità di Simmel. Solo dopo essersi soffermati sul concetto di Wechselwirkung è possibile cogliere «il significato filosofico del denaro» dato che quest’ultimo «costituisce l’immagine più chiara e la realizzazione più definita della formula dell’essere in generale, in base alla quale le cose trovano il loro senso l’una rispetto all’altra e la reciprocità dei rapporti, in cui sono sospese, determina il loro essere e essere così» (Filosofia del denaro, cit., pp. 192-193). Più semplicemente: il denaro è simbolo della relatività delle cose. In particolare, della relatività del loro valore economico. Il che risulta decisivo per comprendere una «civiltà dominata dall’economia monetaria» come il Novecento, ma anche per capire il presente. Che cos’è oggi il prezzo di un oggetto, anche del più banale, se non l’espressione e il risultato di una rete complessa di relazioni che coinvolgono produttori, vettori, intermediari, venditori e consumatori, a loro volta soggetti alle fluttuazioni determinate dalle leggi della domanda e dell’offerta, dalla crisi delle materie prime, dalle relazioni internazionali, dalla situazione geopolitica, dai dazi (effettivi o eventuali) e da innumerevoli altre variabili? Per non parlare dell’effetto delle mode, così passeggere da aver trovato espressione nei micro-trend. Se si pensa alla quantità di fattori necessari a stabilire il prezzo della cosa più semplice e banale – per fare un esempio attuale, una confezione di uova al supermercato – si comprende allora in che senso la cifra segnata su un cartellino possa arrivare a esprimere una rete di relazioni che abbraccia il mondo intero.
Ma questo basta per considerare il denaro simbolo del nostro tempo? A intuito, se qualcuno dovesse scegliere un oggetto che simbolizzi la contemporaneità, sceglierebbe lo smartphone. Quel che importa del cellulare non è tanto la sua componente materiale, (per quanto certi modelli siano più prestigiosi di altri), ma la sua funzione: connetterci. Non avrebbe nessun senso l’esistenza di un telefono, se ne esistesse uno solo in tutto il mondo; già soltanto uno smartphone privo di SIM e di connessione internet può essere considerato al pari di un fermacarte. Anche nel caso del denaro, per Simmel, a importare è la sua fungibilità. Così come le lettere o «i cavi telegrafici che collegano i vari paesi», il denaro è un “oggetto simbolico” che trova il suo «significato soltanto nei rapporti tra gli uomini e i gruppi umani che sono cristallizzati in essi» (ibid.). Si potrebbe dire che il denaro rappresenta la Wechselwirkung in modo puro, cioè la scambiabilità intesa come azione reciproca; dato che non ha altre qualità che non siano la quantità, il denaro nella sua funzione di mezzo di scambio è mera relazione reciproca “astratta” dai contenuti che mette di volta in volta in relazione. Ma la sua valenza non è solo rappresentativa. Il denaro non si limita a essere un’immagine, in piccolo, della rete di rapporti che costituiscono la realtà perché, allo stesso tempo, li istituisce. La sua funzione è costitutiva: agisce come principio di riduzione valutativa universale, annullando le differenze qualitative tra oggetti per renderli scambiabili, e in tal modo produce l’interazione sociale che simbolizza, essendone a sua volta soggetto.
Dunque, quando Alessandra Peluso si riferisce al denaro come «medium delle relazioni» non indica soltanto la sua funzione negli scambi commerciali, ma anche il suo ruolo di mediatore universale nei rapporti sociali. Il denaro è una sorta di convertitore universale, o, scrive Simmel, è come se fosse una lingua comune a tutto il genere umano, che permette a ciascuno di tradurre i propri pensieri per farli comprendere agli altri. Non si può negare che, ancora oggi, – e forse più di prima – il denaro sia l’unica lingua compresa da tutti, e perciò possa addirittura essere assimilato all’idea di Dio nella sua capacità di portare «all’unità l’irriducibile molteplicità del mondo» (G. Simmel, Sulla psicologia del denaro, in Id. Stile moderno, a cura di B. Carnevali e A. Pinotti, Einaudi 2020, p. 377). Ma, proprio come ogni linguaggio, il denaro non lascia i suoi “parlanti” indenni. Questi ultimi ne vengono plasmati, così come le loro interazioni, i cui effetti altro non sono che le caratteristiche della società moderna descritte nella Filosofia del denaro. Lo si vede bene nelle pagine dedicate a figure tipiche della modernità, come il blasé, ormai assuefatto agli innumerevoli stimoli della metropoli; a figure come quelle della prostituta, a cui Peluso dedica una lunga riflessione nella sua Postfazione. O ancora, alle riflessioni sul ruolo “liberatorio” delle prestazioni lavorative pagate a ore, che si fanno sempre più impersonali, ma con ciò lasciano più libertà all’individuo. Un altro esempio, particolarmente attuale, riguarda il ruolo del progredire dell’economia monetaria (e della divisione del lavoro) «sul prolungamento delle serie teleologiche per ciò che è oggettivamente vicino e verso il loro abbreviamento per ciò che è oggettivamente lontano» (Filosofia del denaro, cit., p. 305): si pensi a quanto sia facile e veloce ordinare un abito pagandolo direttamente online, facendoselo arrivare a casa propria, magari dalla Cina, e quanto possa essere complesso e dispendioso realizzarne uno nel proprio salotto.
Dei fili che si intrecciano in Filosofia del denaro, fino a formare un’opera unitaria, in questa sede ne abbiamo seguito uno soltanto utile a definire i nodi centrali che permettano di orientarsi nell’opera. Solo alcuni dei numerosi collegamenti tra le riflessioni simmeliane e il tempo presente sono stati esplicitati. La lettura dell’opera rivelerà quanto siano numerosi e fecondi anche per la comprensione del mondo in cui stiamo vivendo.