Genesi e Grazia
Dopo l’uccisione di Abele, il Signore mise un segno su Caino «perché chi lo trovava non lo attaccasse», ma la Scrittura non precisa la natura del segno. «Per quel che ne sappiamo, potrebbe averlo reso disarmantemente bello», suggerisce Marilynne Robinson in Leggere Genesi (Marietti1820, traduzione di Laura Scarmoncin, Francesca Cosi e Alessandra Repossi, pagine 288, euro 19), un saggio che si lascia ulteriormente apprezzare se tenuto a fianco della nuova versione del primo libro della Bibbia approntata da Erica Baricci per i “Classici liberati” di Blackie Edizioni (Genesi, pagine 310, euro 26,90). I due volumi condividono l’obiettivo di incoraggiare alla conoscenza diretta del testo biblico. Che quello di Genesi sia «il racconto più straordinario mai narrato» è un’affermazione di Baricci che Robinson sarebbe senz’altro disposta a condividere, benché le osservazioni della scrittrice statunitense non si concentrino sulla sola dimensione letteraria. «La Bibbia è una teodicea, una meditazione sul problema del male», dichiara Robinson in apertura di Leggere Genesi e questo basta per dare la prospettiva di un’interpretazione che si realizza sì mediante il close reading, ma che riconduce di continuo alla logica di una macrostruttura di «strategie di caratterizzazione» e più ancora di complesse argomentazioni teologiche. Anche per questo, il libro di Robinson si presenta come riflessione ininterrotta, senza alcuna suddivisione in capitoli. Da parte sua, Baricci elimina la partizione in versetti e abbonda invece in schede esplicative, oltre che in immagini a commento; inoltre, in appendice viene radunata una piccola antologia di testimonianze eccellenti, da Stephen Hawking a Søren Kierkegaard, e dall’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert fino al meno conosciuto Arthur Dobb, il filosofo scozzese al quale si deve il calcolo congetturale del numero di divinità effettivamente presenti sulla scena della Creazione.
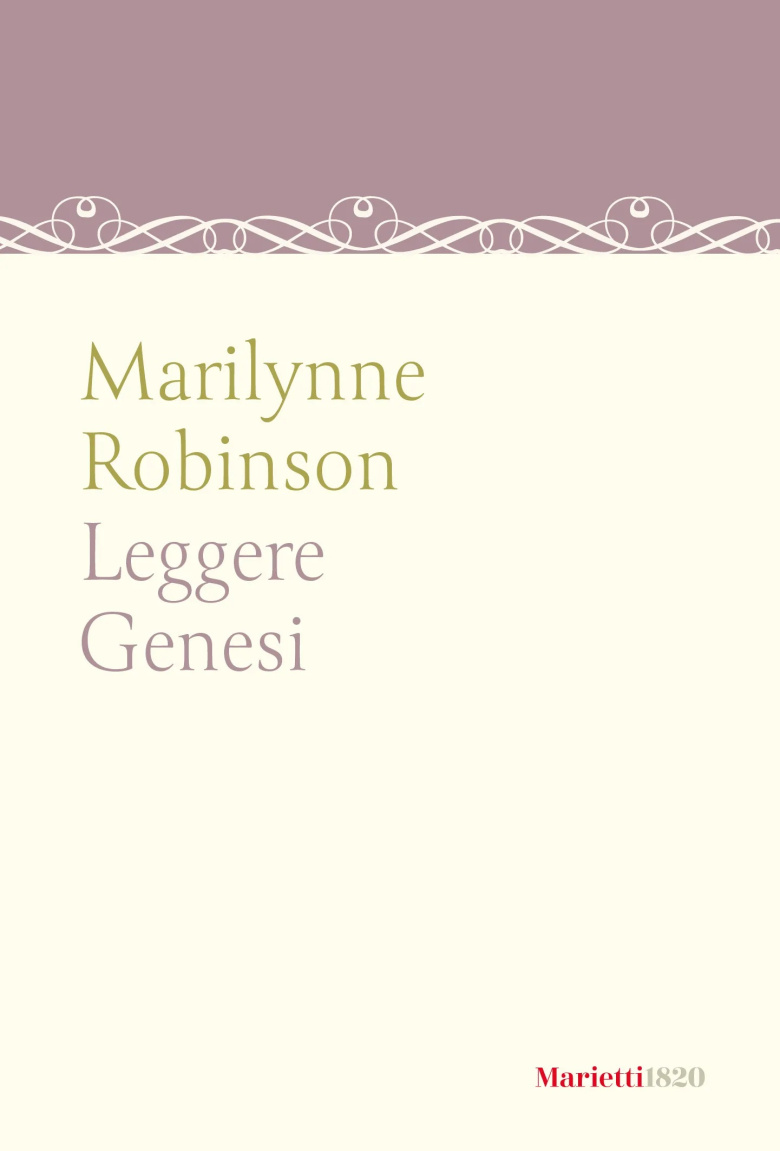
È la dibattuta questione dei diversi appellativi riservati all’Altissimo nei capitoli iniziali di Genesi. Il primo a manifestarsi è Yahvè, ma subito gli si affianca Elohìm, che a rigore è un plurale e che per molti interpreti (non per Dodd, la cui ipotesi è polemica molto più che filologica) sarebbe la spia di un residuale politeismo. Secondo Robinson, al contrario, Elohìm è una forma di pluralis maiestatis e quello testimoniato da Genesi è semmai «un monoteismo originario, per quanto implicito», come dimostra tra l’altro l’apparizione di Melchisedec, il re e sacerdote del «dio altissimo» che al cospetto di Abramo compie il rituale del pane e del vino. Si tratta, com’è noto, di un personaggio decisivo nella ricezione della Bibbia ebraica in ambito cristiano. Nella tradizione figurale (il procedimento ermeneutico medievale per cui ogni personaggio o situazione del Primo Testamento è annuncio di ciò che troverà compimento nel Secondo), Melchisedec è infatti un’indiscutibile anticipazione della messianicità di Cristo. A modo suo, anche Robinson segue questo metodo, facendo puntuale ricorso a brani evangelici e delle lettere apostoliche per ribadire l’intima coerenza e la profonda novità della prospettiva che da Genesi si sviluppa lungo tutta la Scrittura.
Un banco di prova particolarmente significativo è costituito dall’episodio del Diluvio, che ricorre in Genesi come nelle altre letterature dell’area mesopotamica (si veda, in proposito, il recente I Diluvi di Dio del biblista Federico Giuntoli, il Mulino, pagine 258, euro 23; di grande interesse anche la reinvenzione romanzesca di Enzo Fileno Carabba in L’Arca di Noè, Ponte alle Grazie, pagine 240, euro 16,90). Per Robinson la superficiale somiglianza tra le varie narrazioni del cataclisma non fa che accentuare l’originalità del resoconto di Genesi, nel quale l’intervento divino mira a preservare la primordiale «bontà» della Creazione. «Perché esistono gli esseri umani? – si domanda l’autrice – Per offrire sacrifici a Marduk [il signore supremo del pantheon babilonese, ndr] e agli dèi? Perché esistono gli esseri umani? Il Dio di Genesi è unico nel Suo avere per loro non un uso ma piuttosto un misterioso, benevolo intento».
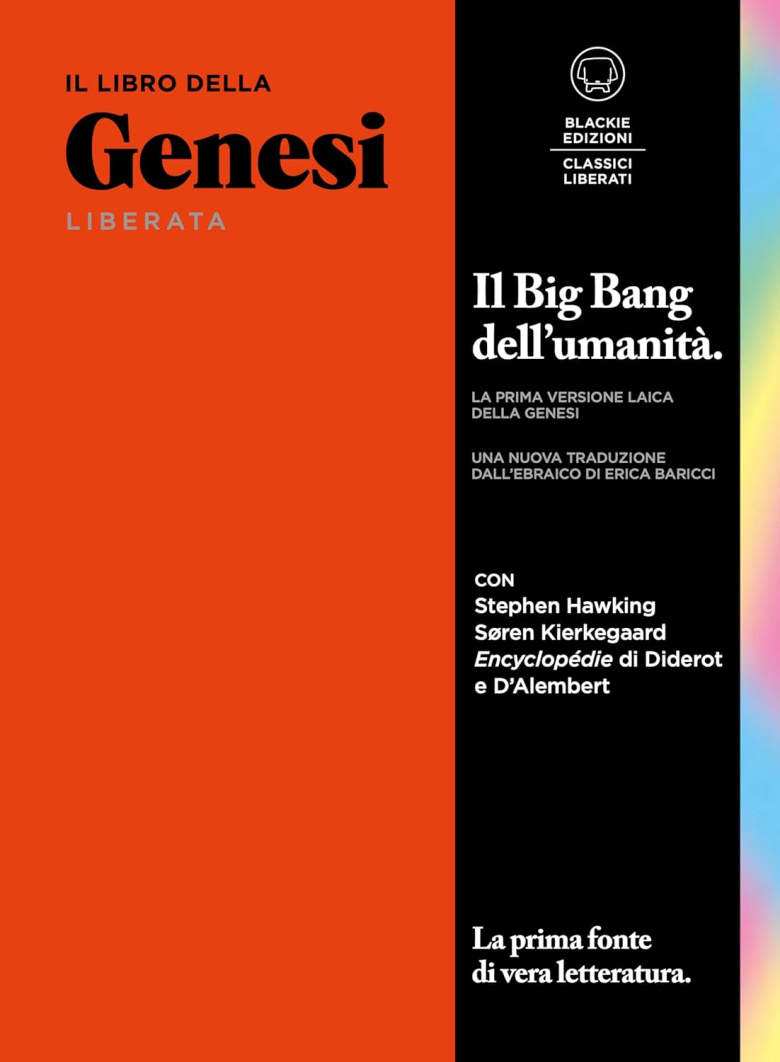
L’espressione finale merita di essere ripresa. La premessa di «un misterioso, benevolo intento» attraversa e sostiene tutta l’opera narrativa di Robinson, che con il passare del tempo si è strutturata nella sequenza di romanzi composta da Gilead (2004), Casa (2008), Lila (2014) e Jack (2020: tutti in catalogo da Einaudi nella traduzione di Eva Kampmann). Della sua attività di saggista, minimum fax ha portato in Italia le raccolte Quel che ci è dato e Quando ero piccola leggevo libri, che culmina in un intervento sulla cosmologia in qualche modo propedeutico alla dettagliata esplorazione di Leggere Genesi. Muovendo dalla premessa per cui «l’ateismo è un elemento relativamente minore della cultura mondiale», Robinson non nasconde di essere credente (appartiene alla Chiesa Congregazionalista, di matrice calvinista) e diffida del positivismo: «[…] raziocinare quel che Dio fa comporta il rischio di perderne la difficoltà e l’alterità di contro alle aspettative umane», ammonisce. Il Dio della Bibbia, e nella fattispecie il Dio di Genesi, può essere di difficile comprensione, è vero. Agisce in maniera spesso paradossale, ma «reggere il paradosso è il genio del testo», avverte Robinson con una considerazione che non vale solamente in ambito biblico.
La chiamata di Abramo, l’astuzia di Giacobbe, il protagonismo di Giuseppe rispetto ai fratelli sono i momenti principali di una vicenda nella quale la vendetta divina è più volte annunciata e mai messa in atto. A prevalere è sempre l’imperscrutabile «economia della grazia», che Robinson sintetizza in una formula memorabile: «La grazia modifica la legge. La legge non può limitare la grazia». E ancora, più avanti, in consonanza con la dottrina patristica sull’ira Dei: «La grazia modera il giudizio». Smisurato nella misericordia, Dio applica una misura più che generosa nei confronti dell’umanità, in un intreccio di avvenimenti da cui scaturisce un irripetibile disegno narrativo. A differenza delle mitologie di fondazione dell’Antico Oriente, «le storie di Genesi sono storia perché la Scrittura parla di esseri umani in circostanze umane». Pur non esibendo riferimenti bibliografici circostanziati, la ricostruzione proposta da Robinson si basa su una documentazione molto solida, in virtù della quale viene presupposta l’esistenza di una tradizione orale le cui tracce risultano evidenti nel racconto. La funzione asseverativa della ripetizione si riverbera così sui numerosi parallelismi narrativi, che tuttavia non impediscono di far risaltare gli aspetti peculiari delle singole personalità. «Queste storie – annuncia Robinson in esordio – sono l’embrione di una letteratura e di un’identità poderose». L’affermazione viene ripresa nel congedo, con parole ancora più nette e suggestive: «Tutta la grande letteratura della Scrittura, che si dipana nel corso di secoli, procederà nei termini stabiliti in questo libro. Quindi Genesi viene portata avanti nella legge, nei Salmi, nei profeti, è un’esplosione spettacolare di luce senza precedenti, ma con un universo di conseguenze».

Un simile «Big Bang dell’umanità» (la definizione si trova anche nell’edizione curata da Baricci) ha avuto e continua ad avere esiti imprevedibili nella stessa letteratura profana, compresa quella di Marilynne Robinson. Ammesso e non concesso che quanto accade a Gilead e dintorni non faccia parte a sua volta della storia sacra. O, meglio, che la trasformazione degli esseri umani in «competenti attori morali» avvenuta attraverso la «conoscenza del bene e del male» non sia qualcosa che ci riguarda ancora direttamente. Non sappiamo quale fosse il segno impresso dal Signore su Caino, ma intuiamo una disarmante bellezza in Jack, l’antieroe che nella tetralogia Robinson assume su di sé la sventura del figlio colpevole e disamato: un diseredato «principe delle tenebre» inseguito dal sospetto che l’esistenza di ciascuno sia visitata da «un misterioso, benevolo intento».
La cacciata dal Paradiso Terrestre, Cornelis van Poelenburch.







