Azar Nafisi: racconta l'Iran!
“Un romanzo, un racconto, una storia, sono democratici per definizione, sono sempre composti da un insieme di personaggi che interagiscono gli uni con gli altri, e dove anche i cattivi hanno voce e esprimono le loro idee. Consiste in questo la natura sovversiva dell’invenzione letteraria, che non è raccontata al fine di emettere un giudizio: la grande letteratura non sentenzia, la grande letteratura racconta “.
Abbiamo incontrato Azar Nafisi insieme a suo marito Bijan in una caldissima giornata di luglio, nel giardino di un Hotel di Frascati dove si è fermata qualche giorno a cavallo di un tour che l’ha portata a Roma per il Festival Letterature, ai Castelli per il Velletri Libris, a Formia e a Vieste per Il libro possibile: ne è nata una conversazione su alcuni autori e personaggi, come una ideale continuazione di Leggere Lolita a Teheran.
È tempo d’estate e di letture sotto l’ombrellone.
Sì, la letteratura come svago. Sono in molti a pensare, a prescindere dalle stagioni, che la fiction abbia o debba avere una funzione d’intrattenimento. Ma la lettura deve cambiarti. Se sei un buon lettore, uno di quelli che presta attenzione alla pagina scritta, non puoi che uscirne modificato, tutt’altro che rassicurato nel tuo punto di vista. In questo sono d’accorso con Faulkner, un autore che può aiutarci a comprendere anche il presente: la fiction consiste nella moltiplicazione delle voci, che da Faulkner vengono orchestrate mirabilmente, e anche di quelle che non ascolti abitualmente, compresa la voce del “nemico”. Se vuoi sconfiggere il nemico – compreso il “tuo” nemico, quello interno –, il primo passo non può che essere quello di conoscerlo e comprenderlo: un buon generale è colui che riesce a figurarsi come pensa l’“altro”. Per questo c’è bisogno di buona letteratura, è questa la sua funzione. Purtroppo, la condizione che stiamo vivendo è invece quella in cui non esistono altre voci, che sono cancellate, disperse, quantomeno non le ascoltiamo: viviamo tempi di rinnovati conflitti e tutto è polarizzato.
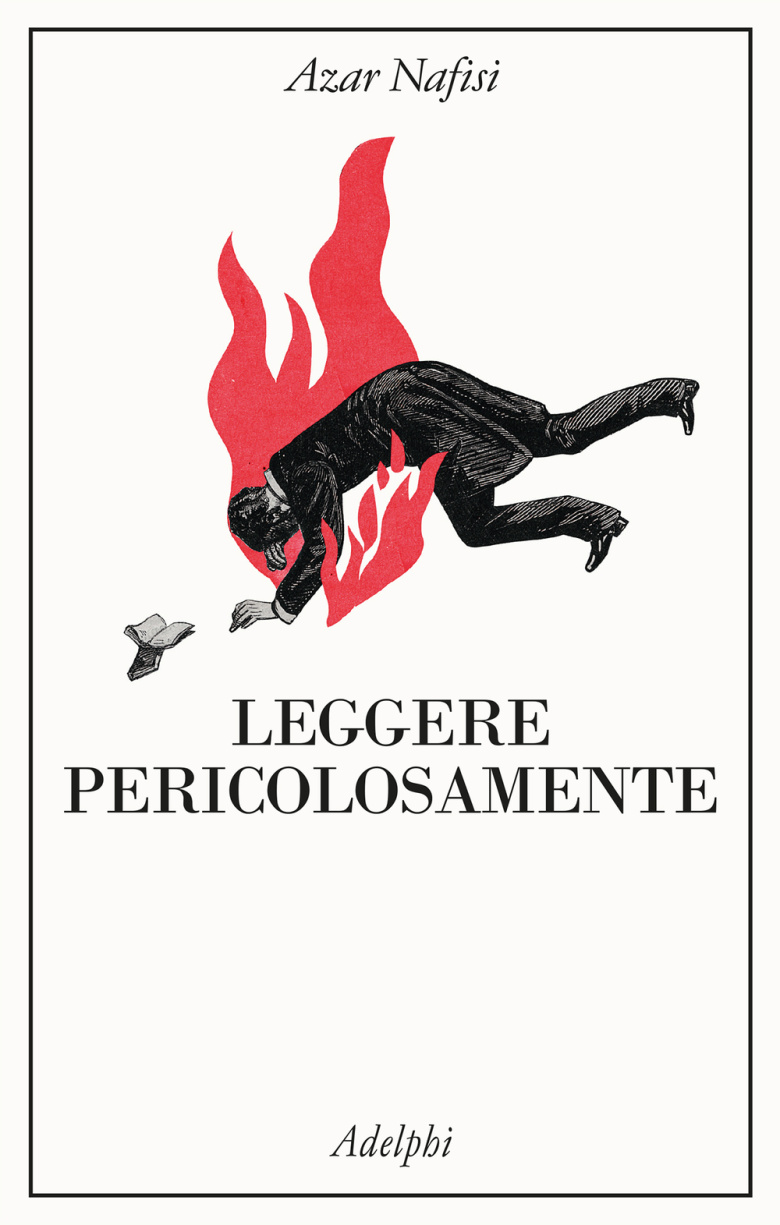
A proposito di guerre che non finiscono mai, in Leggere pericolosamente, lei dedica molte riflessioni all’opera di David Grossman.
Io trovo sorprendente, nell’accezione più positiva possibile, la posizione di Grossman riguardo a quel “nemico” di cui ho appena detto. La sua ricerca e la sua scrittura vanno nel senso di sottrarsi alla disumanizzazione dell’altro, del nemico, perché è ciò che finisce per disumanizzare noi stessi: provo grande empatia per questa visione, ed è l’atteggiamento che mi guida nel mio attuale rapporto con l’Iran. C’è stato un lungo periodo durante il quale ho profondamente odiato le persone che sono al potere nel mio paese dal tempo della rivoluzione islamica, tutte le emozioni, i miei sentimenti, i pensieri erano caratterizzati dal disprezzo, ma tutto questo non mi ha fatto sentire meglio, al contrario, i sentimenti che mi attraversavano non mi hanno fatto sentire in potere di me stessa: il potere, semmai, lo conquisti nella comprensione profonda della complessità di ogni condizione. Ecco, leggere David Grossman ti aiuta a capire che non c’è un solo un livello di comprensione del reale, ce ne sono molti, non c’è una sola voce cui prestare orecchio, ce ne sono tante. È lo stesso insegnamento di Faulkner.
Tornando a Leggere Lolita a Teheran, quale altro personaggio aggiungerebbe a quel libro per raccontare l’Iran di oggi?
Direi senza dubbio Sherazade, la madre di tutte le storie. Quella di Le mille e una notte è ben nota, e parte dall’odio – appunto! – e dal desiderio di vendetta del Re per il tradimento di una donna che lo porta a generalizzare il carattere di infedeltà su tutte le donne. Ora, la cosa sorprendente del personaggio di Sherazade sta nel suo rifiuto di riconoscersi nel dominio del nemico, Sherazade rimane in controllo perché si riconosce e si definisce nel dominio del racconto, nell’atto del raccontare. L’esito per cui ogni notte la storia rimane incompiuta, non finita, sollecita la curiosità del Re e siccome le due caratteristiche principali dell’immaginazione sono la curiosità e l’empatia, le storie che Sherazade racconta cambiano la mente del Re, il suo modo di stare al mondo, il suo mindset. È questo quello che dobbiamo fare anche oggi: non tagliare le teste, ciò che fanno i persecutori dei regimi totalitari, bensì cambiarle. Sherazade non uccide il Re, magari prima addormentandolo, Sherazade lo cura, gli cambia la testa. Ma per fare questo ci vuole curiosità – empatia e curiosità, dicevo a proposito dell’immaginazione –, la curiosità così come la definisce il Nabokov, che ha ispirato il mio Leggere Lolita a Teheran: per questo grandissimo scrittore la curiosità è insubordinazione nella forma più pura, è uscire da ciò che ci è familiare. La lettura non può essere consolatoria, ma sovversiva. Bisogna, come ho scritto, leggere pericolosamente.
Quale autore leggere, allora, per provare a capire cosa sta accadendo negli Stati Uniti del secondo mandato di Donald Trump?
Direi il mio amato Saul Bellow, perché nessuno di noi deve sottrarsi alla responsabilità di quello che è accaduto e che accade. Spesso ho riferito il pensiero di Bellow quando si chiede: “Come faranno, quelli che sono sopravvissuti al calvario dell’olocausto, a sopravvivere al calvario della libertà?”. Bellow vede la libertà come un calvario, qualcosa tutt’altro che facile. Sono molti a scambiare la democrazia con una condizione che ha a che fare con la libertà di vestirsi come ti piace meglio, di avere un bell’aspetto e di andare a ballare… che va bene, certo! Sicché vivere in democrazia è difficile, in un senso specifico è più difficile che vivere nel totalitarismo, perché il totalitarismo può essere seducente, il totalitarismo ti induce a vedere in bianco e nero, giusto e sbagliato, si definisce nel rifiuto della complessità, nei regimi dispotici c’è sempre qualcuno che pensa per te, prende decisioni, ti dice quello che devi fare. Ciò che può essere molto più semplice e comodo rispetto alla responsabilità della democrazia. Dal mio punto di osservazione, è una “comodità” che spiega quello che sta accadendo oggi negli Stati Uniti. Raccomanderei la lettura di Saul Bellow, quindi, e anche quella di James Baldwin quando scrive che gli artisti sono tali in quanto disturbano la pace, ti lasciano in una situazione di sconforto, importunano le regole della tua mentalità, mettono in discussione i tuoi pregiudizi: ciò che realmente minaccia la democrazia è il sonno delle coscienze e l’atrofia dei sentimenti.
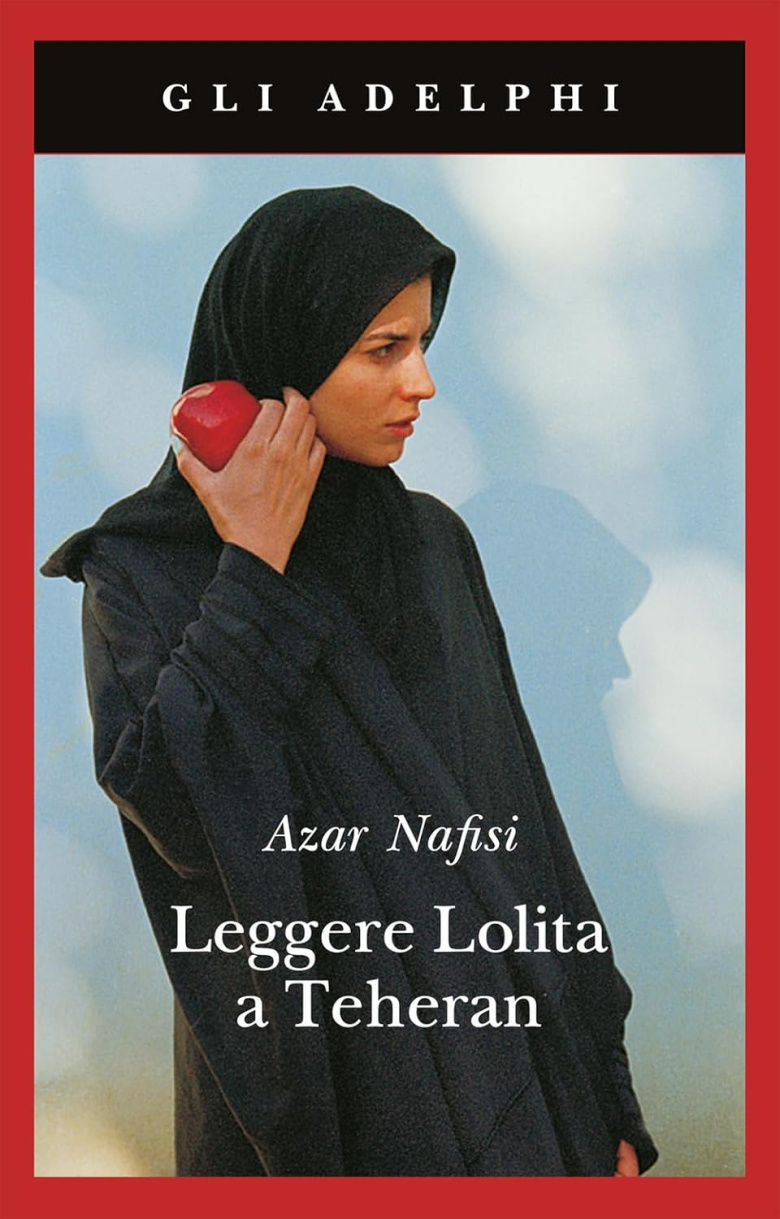
Dovrei chiederle che ruolo ha la religione, non solo nel suo paese d’origine, nel minacciare le coscienze e i sentimenti.
E io le posso rispondere che la repubblica islamica non ha a che fare con la religione se non con la religione come ideologia. All’inizio della rivoluzione in Iran, nel 1981, l’allora Presidente Rafsanjani volò dal leader della Nord Corea, Kim Il Sung, il nonno dell’attuale dittatore, una visita nell’ambito di una cooperazione tecnico-militare e con un forte accento sulla comune posizione anti-americana: nulla a che fare con la religione ma con la necessità e i mezzi per ottenere il potere, mantenendolo a ogni costo. Ciò che accomunava i due leader era la scelta di un sistema di governo totalitario, non certo una comunanza spirituale: Rafsanjani era più vicino a Kim Il Sung o a ciò che oggi rappresenta il Presidente Putin, di quanto lo fosse nei confronti dei musulmani e di un certo Islam progressivo che pure si riuniva intorno a lui. Quella visione religiosa è stata confiscata e abusata, ed è per questo che è importante ciò che accade oggi in Iran. Perché in Iran è in gioco il ruolo della religione nella vita di tutti i giorni, ciò che oggi è in discussione è il fondamentalismo che sta dietro la religione. Per i fondamentalisti la parola democrazia rappresenta un pericolo ed è per questo che non perdono occasione per dire che è una parola “occidentale”.
Lei vive da molti anni oramai negli Stati Uniti, potremmo dire al centro della cultura e della democrazia occidentale, un occidente di cui si predice il “tramonto” da almeno un secolo e che nelle parole di molti protagonisti della rivoluzione islamica, di cui lei racconta nei suoi libri, è irrimediabilmente corrotto e inarrestabilmente in declino: come ci vive, come lo vede e lo legge?
Le risponderò anche in generale, ma prima mi faccia dire una cosa specifica. In occidente, osservando ciò che accade in alcune società governate da regimi totalitari, vi è chi sostiene, e già da un po’, che bisogna rispettare la “loro” cultura e che, in quanto occidentali, non si è nella posizione di poter criticare le culture “altre”. È un ragionamento che mi fa imbestialire. Torniamo al mio Iran: non si può criticare il fatto che una bambina di 9 anni venga data in sposa a un sessanta, settantenne? Non si può criticare chi commina la pena capitale tramite lapidazione di una malcapitata infilata a forza dentro un sacco di tela? Ma come vi permettete di dire che questa è la “cultura” dell’Iran o dell’Afghanistan? Coloro che esprimono queste posizioni vogliono presentarsi come rispettosi ma sono molto più condiscendenti di quelli che affermano che l’Islam è semplicemente orribile; sono atteggiamenti che si dicono progressisti, da parte di persone che affermano di volerci rispettare ma che in realtà ci insultano. Per non dire di coloro che mettono tutto insieme, Iran, Turchia, Afghanistan, Arabia Saudita come rappresentassero un’unica cultura, ignorando le profonde differenze che ci contraddistinguono.
All’inizio della rivoluzione islamica, il 6 Marzo del 1979, quando Khomeini emise la fatwa che rendeva obbligatorio, per le donne, indossare l’hijab, migliaia di iraniani scesero in strada gridando che la libertà non è né occidentale né orientale, che la libertà è universale: uno slogan che non ho ascoltato tra i progressisti negli Stati Uniti. Quando sono arrivata negli Stati Uniti, qui in occidente, ero molto infelice per il modo in cui l’Iran era visto, e appena prima, lasciando il mio paese, mia madre mi ha detto più volte, “Tell them, tell them!”, dillo, dillo, raccontalo a tutti, racconta l’Iran! Perché una delle cose che contraddistingue i regimi totalitari è che provano a isolare il popolo, a fargli credere che nessuno si interessa a loro, che sono soli, e che solo i rappresentanti del regime si possono prendere cura delle loro vite. È per questo che ho scritto Leggere Lolita a Teheran, perché sentivo il bisogno di parlare del vero Iran, dell’Iran che nessuno vedeva e conosceva.
E tornando alla sua domanda generale. Non saprei dirle della fine della civiltà occidentale, in genere non do grande ascolto alle previsioni riguardo la caduta di questa o quella civiltà o di qualsiasi impero. Temo però che sia il mondo intero ad essere in pericolo, che stiamo tutti vivendo un periodo di crisi. Sicché c’è sempre qualcosa di positivo nella profondità delle crisi, ed è ciò che ci porta ad uscire da ciò che ci è familiare, come dicevo già con riferimento a Nabokov. La crisi ci obbliga a pensare, di nuovo, ad assumerci la responsabilità. Siamo, ancora una volta, di fronte a una grande occasione per combattere in nome della democrazia e dovrebbe essere qualcosa di eccitante invece che metterci paura. In Iran, tra i pensatori più letti ci sono Hannah Arendt, Karl Popper, Vaclav Havel, tutti studiosi che sono passati attraverso la crisi. E vale per loro ciò che vale oggi per noi e che Bellow ci invita a considerare, che bisogna passare attraverso la crisi, che dobbiamo combattere contro noi stessi e non solo contro di “loro”, che bisogna assumere il coraggio di accettare che non siamo sempre “… so good!”
Magari con l’aiuto della letteratura e, perché no, affidandosi al divino, per lo meno al modo in cui il mio “Mago” raccomandava, sottoscrivendo un pensiero che mi ha lasciato in eredità:
“L’esistenza di Shakespeare è un buon motivo per credere in quella di Dio!”.







