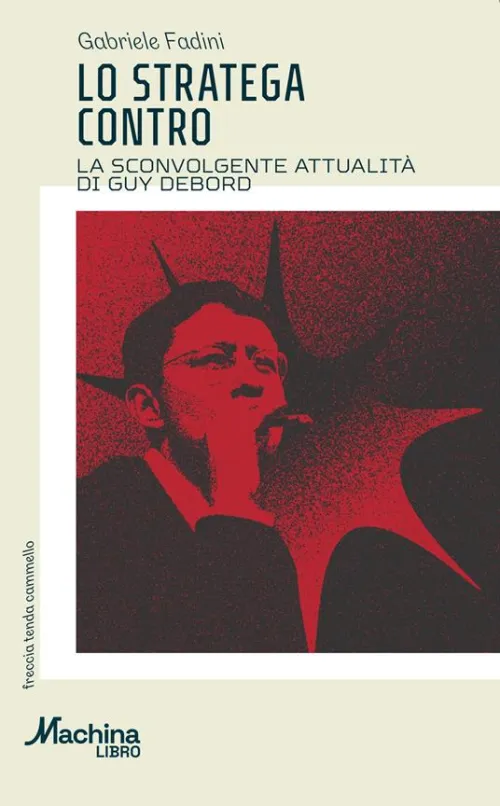Guy Debord: uno, non-uno, centomila
“Une vie pleinement indépendante”: così definisce il progetto della propria stessa vita Guy Debord nel suo ultimo film In girum imus nocte et consumimur igni (1978). Potremmo usare questa formula come una descrizione di sé ma anche, e soprattutto, come un impegno: a che la vita, la vita di ciascuno di noi, sia una vita del tutto indipendente. Ma non è proprio quanto il sistema sociale in cui noi occidentali viviamo ci chiede di fare, essere originali, autonomi, indipendenti? Guy Debord ha cercato in tutta la sua vita di costruire la propria radicale indipendenza, di coincidere con questa stessa indipendenza. Questa formulazione va presa alla lettera: non è che esiste l’identità Guy Debord separatamente dalla vita che conduce, piuttosto, come scrive Gabriele Fadini in Lo stratega contro. La sconvolgente attualità di Guy Debord (DeriveApprodi 2025), “Guy Debord è il nome singolare di un insieme che tiene uniti una molteplicità di aspetti diversi” (p. 5). Debord diventa così il significante di una molteplicità. O per dirla in un altro modo, la sua identità, peraltro fortissima (un essere umano di una intransigenza insopportabile), consiste nell’essere una molteplicità di identità: “la consistenza della propria singolarità”, scrive ancora Fadini, “così come della sua intera esistenza” coincide con “passare del tempo, e quindi non quella di una semplice sostanza, nel senso latino della substantia” (p. 9). L’identità è nemica del tempo, perché il tempo è cambiamento, trasformazione, distruzione di ogni identità. La pratica situazionista, cioè la pratica di vita di Debord, fa al contrario del cambiamento, cioè dell’ininterrotta erosione di ogni sostanza, l’unica possibile consistenza di sé. Ma questo vuol dire, e forse cominciamo a capire che cosa possa significare la formula “une vie pleinement indépendante”, che una vita del genere è ‘piena’ non di cose né di esperienze, al contrario, è una vita sempre più ridotta, minima, una vita che si perde felicemente nel mondo. Fadini coglie questo punto attraverso una citazione di Mille piani, lo straordinario libro di Deleuze e Guattari: “il molteplice bisogna farlo, non aggiungendo sempre una dimensione superiore, ma al contrario il più semplicemente possibile, a forza di sobrietà, a livello delle dimensioni di cui si dispone, sempre n – 1 (l’uno fa parte del molteplice solamente così, essendo sempre sottratto). Sottrarre l’unico dalla molteplicità da costituire; scrivere in n – 1”.
Se il nostro tempo vuole da noi pienezza, autoconsistenza, sicurezza di sé (‘devo pensare a me stesso’, ‘devo volermi bene’ sono gli assiomi dei manuali di Self help), la vita esemplare di Debord ci mostra invece un movimento del tutto diverso, non verso il +1 (che non a caso è quello delle quotazioni di borsa, l’unico indicatore che orienti ormai le nostre esistenze), piuttosto verso il -1. Un -1 che non va però preso come un segno di moderazione, o peggio ancora come una mortificazione. Ricordiamo che l’obiettivo è costruirsi “une vie pleinement indépendante”, ossia una vita singolare, unica, e questo è un obiettivo che richiede un enorme sforzo di individuazione, un’incredibile volontà di resistenza. Ma resistenza a che cosa? Il suo libro più noto, La società dello spettacolo (1967), si apre con questa definizione: “tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che è direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione”. Facciamo qualche esempio: i notiziari non parlano tanto dell’andamento dell’economia, ma delle aspettative sul futuro andamento dell’economia. Non si parla della cosa, ma dello spettacolo della cosa, della sua rappresentazione appunto. Un caso della nostra incredibile quotidianità, la situazione inumana in cui sono tenuti e quotidianamente uccisi i palestinesi a Gaza dall’esercito di Israele: Trump propone di trasformarla in un lussuoso luogo di vacanze per ricchi, una nuova e splendida riviera mediorientale. Uno spettacolo prende il posto della realtà. Un ultimo esempio, più modesto ma non meno esemplare, una festa di laurea. Chiunque vi avrà partecipato si sarà accorto che i festeggiamenti sono inversamente proporzionali al valore della laurea stessa, lo spettacolo ha preso il posto della cosa, definitivamente: “rappresentazione” scrive Fadini, “è dunque sia l’atto della presentificazione di qualcosa già da sempre assente, sia un atto sostitutivo che ri-presenta qualcosa laddove esso non è più” (p. 19). La cosa reale, vera, effettiva non c’è più, rimane invadente e insopportabile lo spettacolo della cosa, il suo idolo, che come tutti gli idoli pretende assoluta e rispettosa devozione. Si pensi allo spettacolo a cui abbiamo da poco assistito, l’elezione del nuovo papa. È sempre successo che i potenti presenziassero a queste manifestazioni, eppure il livello di ipocrisia raggiunto questa volta è incredibile: le stesse persone che postano immagini disgustose di deportazioni e di umani rinchiusi in gabbia che si prostrano con gli occhi socchiusi per baciare la mano nel pontefice. Lo spettacolo, appunto.
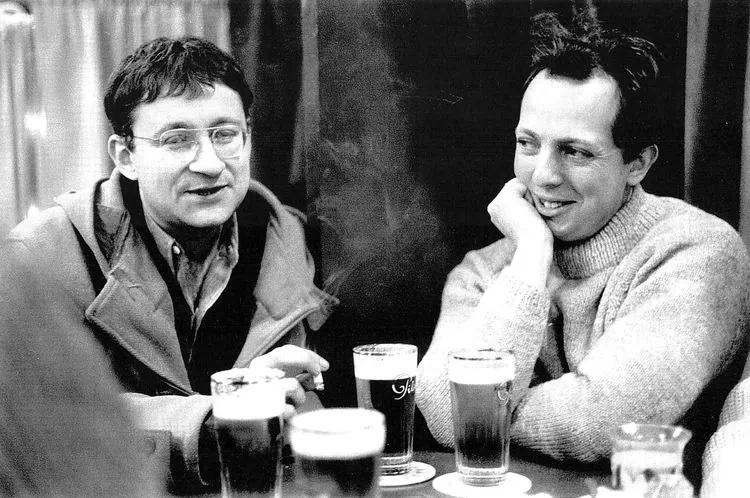
Vivere nel tempo dello spettacolo – che sia economico, religioso, sociale – significa allora vivere nel tempo di una radicale espropriazione, perché credere nello spettacolo non significa altro che rinunciare a sé stessi, perdersi prima ancora che nella menzogna nella assoluta vacuità, in quanto “lo spettacolo è un’imitazione insensata e ingegnosa del reale fatta per non dire nulla” (p. 20), perché, prosegue Fadini, “nello spettacolo integrato proprio delle società del presente, infatti, lo spettacolo permea così tanto la realtà che […] si è mescolato a ogni realtà irradiandola di sé” (p. 76). Non è che lo spettacolo copre la realtà, lo spettacolo è la realtà.
Se ora torniamo all’impegno per “une vie pleinement indépendante”, ci si rende conto che il primo spettacolo da decostruire è allora interiore, quello dell’identità personale, del ‘proprio’ Io, questa entità inafferrabile che esiste solo nei manuali di psicologia. Solo quando questo spettacolo viene messo in crisi, solo allora la possibilità di una esistenza indipendente diventa praticabile. Ma chi effettua questa stessa operazione? In realtà il tentativo di Debord coincide con l’avventura di una individualità non spettacolare, ossia con una inafferrabile individualità non individuale. Il procedimento fondamentale di questa operazione, allo stesso tempo estetico e politico, è quello della “situazione”, da costruire, in particolare, a partire dalle derive urbane. Nella città i diversi luoghi dettano gli usi che se ne possono fare: lavorare, riposare, divertirsi, secondo una logica fissata dai luoghi stessi, che prima ancora che essere contenitori spaziali sono dispositivi che producono azioni (si pensi alla separazione, nell’appartamento borghese, fra il luogo del cibo, quello dei bisogni corporei, dello svago, del riposo e del piacere). La deriva, al contrario, il lasciarsi andare per le città, sovverte tutte queste gerarchie, che sono allo stesso tempo urbanistiche e poliziesche: “la deriva – deviare l’acqua, scostarsi dalla riva, andare alla deriva – non è solo un movimento nello spazio ma anche nel tempo proprio allorché si svincola da un attaccamento esclusivo al suolo, restituendosi alla realtà di un viaggio che ha solo in sé stesso il proprio senso e il proprio fine” (p. 64). Un’azione senza scopo, che quindi non può essere trasformata in produzione di valore (com’è invece il caso del viaggio, a maggior ragione verso le solite mete cosiddette esotiche).
Nella deriva non solo la città smette di essere un luogo organizzato e progettato per diventare più che uno spazio un’occasione di movimento (cioè diventare tempo), è il soggetto stesso della deriva che va incontro alla propria scomparsa, verso il -1 di cui parlano Deleuze e Guattari. Perché è “l’erranza [che è] costitutiva della deriva” (p. 64), e che cos’è l’erranza se non un lasciarsi prendere dai luoghi, e, in particolare, dalle situazioni imprevedibili che ogni erranza permette? E infatti la “situazione” permette il formarsi di una “socialità desiderante” – cioè dei desideri che nascono nel momento, appunto nella situazione, che non esistevano prima di quella stessa situazione – “è creazione di forme non serializzate, non riconducibili alla convenzione produttiva o alla forma serializzata della società o all’idea di una qualsiasi forma di totalizzazione o di sistematizzazione (p. 94). Torna il tema di una vita – non della vita, perché non c’è una regola, un universale che stabilisca come si debba vivere questa vita – “pleinement indépendante”, e quindi affatto singolare, indicibile (i nomi evocano le classi generali, ma non c’è nessuna classe che possa includere in sé questa assoluta individualità), una vita affatto impensabile. Diventare la propria stessa impensabilità, in questo consiste l’idea di libertà di Debord. La libertà non è una dotazione ‘naturale’, non è una facoltà psicologica: non si è liberi, si è piuttosto uno stratega, colui che sul campo di battaglia decide una mossa in risposta ad una mossa dell’avversario, e poi una contro-contromossa e così via, attaccando, difendendosi e contrattaccando: “sostenere che il Kriegespiel sia la metafora della lotta contro la società dello spettacolo, significa affermare che l’irrappresentabile può darsi in quel particolare gioco in cui la strategia rende impossibile determinare in maniera univoca i movimenti dei giocatori, i quali a propria volta si costituiscono come tali proprio nell’atto di giocare. Il fatto che fuori dal gioco il giocatore non esista, significa che fuori dalla strategia lo stratega – ovvero per Debord il soggetto stesso – non esiste” (p. 61). Ecco allora, infine, in che consiste questa ricerca di “une vie pleinement indépendante”: se lo spettacolo è dovunque, se l’idea di una vita ‘autentica’ non solo è puerile ma anche ipocrita, si tratta piuttosto di “perseguire l’unica possibilità che è data ovvero quella di muoversi sulla superficie di immagini che volano via l’una dappresso all’altra e ‘giocarle’ le une contro le altre” (p. 61). Non è molto, ma non è nemmeno poco, in un tempo terribile che sembra del tutto privo di vie di fuga.