Il difficile mestiere dell'architetto
Professione difficile, quella dell’architetto. E difficile non soltanto perché per svolgerla necessitano molteplici competenze: se non tutte quelle che prescriveva Vitruvio nel De architectura (istruzione letteraria, esperienza nel disegno, preparazione in geometria, conoscenza della storia, rudimenti in campo filosofico, padronanza della musica, nozioni di medicina, istruzione giuridica, cognizioni astronomiche), almeno qualcuna tra esse. Ma difficile anche perché costitutivamente – verrebbe quasi da dire: ambiguamente – tesa tra dominio dello spirito e dominio della materia, ovverosia tra idealità e realtà.
Questa difficile tensione tra opposti, tra elementi apparentemente – e fors’anche sostanzialmente – inconciliabili tra loro, non è cosa nuova. Appartiene alla storia dell’architetto come – insieme – figura intellettuale e “pratico”, vale a dire persona capace, se non di fare direttamente con le proprie mani, quantomeno di risolvere problemi concreti con i propri progetti.
Senza bisogno di risalire troppo indietro nel tempo (ma tanto Leon Battista Alberti che Francesco Borromini potrebbero – ciascuno a modo proprio, in forme e con accenti diversi – fornire validissime testimonianze di questo “scontro” a prima vista irresolubile tra elementi in conflitto tra loro), è sufficiente ascoltare quanto Ernesto Nathan Rogers, architetto e teorico di origini ebraiche operante nel periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, afferma nel corso di una conferenza dall’emblematico titolo Il dramma dell’architetto, tenuta nel 1948: «Fra gli altri uomini, l’architetto rappresenta questa personalità singolare cui è devoluto il compito di tentare la sintesi tra gli opposti poli». Si tratta di quella che Rogers concepisce come una vera e propria «lotta tra utilità e bellezza»: «Dobbiamo sentire in ogni momento creativo il dramma fondamentale dell’esistenza perché la vita pone continuamente in contraddizione i bisogni pratici e le aspirazioni spirituali».
Basterebbero queste poche parole – pronunciate tra l’altro da un architetto che ha lasciato, con il gruppo BBPR con cui lavorava, alcune delle opere più significative del secondo dopoguerra, tra le quali la Torre Velasca a Milano – per comprendere quanto il compito dell’architetto sia effettivamente “drammatico”. Al punto che viene da chiedersi come si possano concretamente conciliare quelle diverse contraddizioni senza correre il rischio di tradire l’uno o l’altro aspetto: quello etico, quello estetico, quello economico, quello sociale, per nominarne soltanto qualcuno.
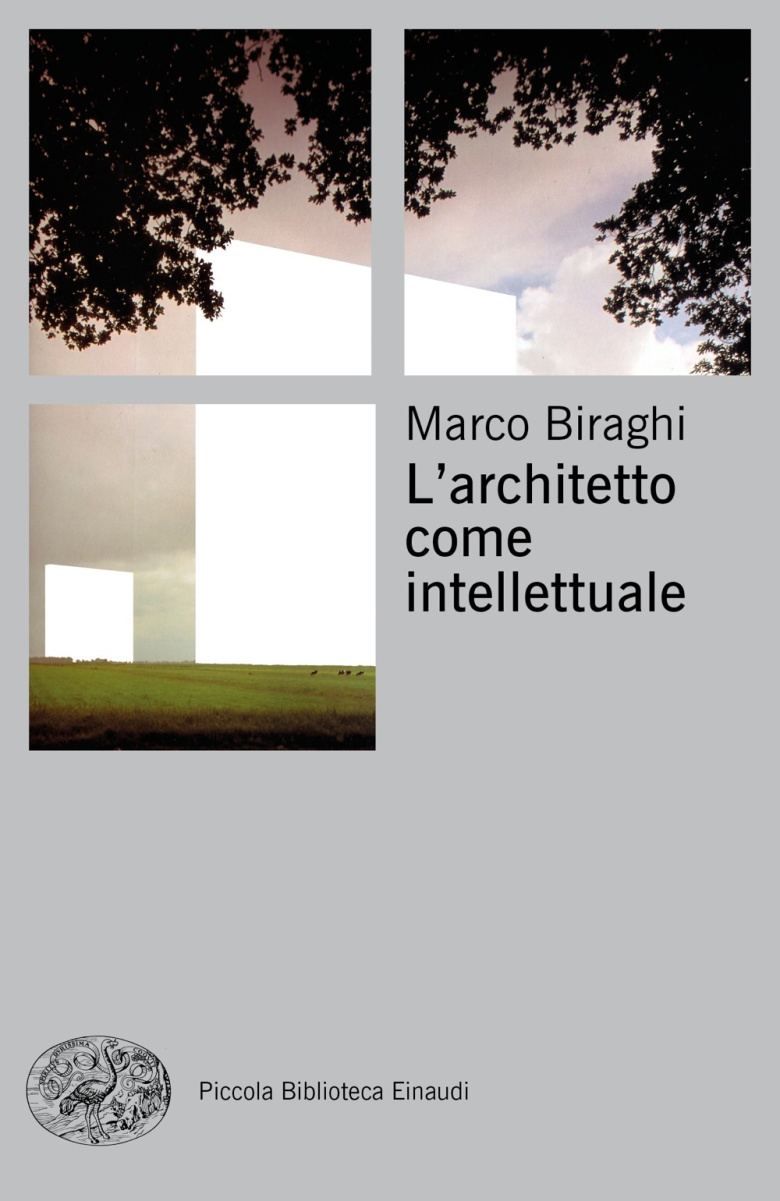
Di certo, la crescita delle città e la proliferazione di edifici al loro interno negli ultimi decenni stanno a dimostrare che una “soluzione” a queste aporie, nella prassi, gli architetti odierni la trovano; e che anzi, forse, niente affatto di aporie si tratta, per loro. Perché se da un lato la conciliazione tra idealità e realtà è ardua da compiersi, dall’altro l’ineliminabile presupposto di tale difficile sintesi è che entrambi i fattori siano presenti. E qui, lecitamente, si possono avanzare dei dubbi in merito alla propensione degli architetti attuali nel coltivare “ideali”. Ma allo stesso modo, si potrebbe interrogarsi sulla propensione della nostra intera società nel coltivare “ideali”. Sempre più difficile riscontrare, al giorno d’oggi, in pressoché tutte le professioni, una “tensione” verso qualcosa che vada oltre ragioni meramente economiche. E se la perdita di ideali da parte di avvocati o di idraulici può avere senza alcun dubbio significativi riflessi sociali, la perdita di ideali da parte degli architetti ha sicuramente ricadute ancora più significative e immediate, interessando città, edifici, ambienti costruiti e spazi di relazione sociale.
Naturalmente, gli architetti non sono i soli responsabili di questa situazione. La perdita collettiva di ideali riguarda infatti anche la “classe politica”(ormai lungi dall’essere tale, peraltro, essendo chi fa politica sempre più di frequente “prestato” da altri settori), così come riguarda pure i committenti, gli investitori, gli operatori immobiliari, i costruttori, gli utenti. A fronte di ciò, non è facile rintracciare le specifiche “mancanze” degli architetti sotto questo punto di vista: è un fenomeno talmente generalizzato e diffuso, quello del “cedimento” ideale (o ideologico), da non consentire più di individuarne singole “cause” o “responsabilità”.
E tuttavia, proprio per il delicato ruolo che riveste, l’architetto – esattamente al pari dal politico – è chiamato comunque a rispondere, se non già per forza ad istanze “ideali”, quantomeno ad istanze morali; istanze cioè dettate dalla propria “coscienza” professionale, anche al di là di quelle imposte dalla deontologia. È anzi proprio il dovere di rispondere a ciò quello che rende (o almeno, dovrebbe rendere) letteralmente “responsabili” architetti e politici: quell’“etica della responsabilità” che per Max Weber deve necessariamente affiancarsi a un’“etica della convinzione”, in questi ultimi (ma perfettamente applicabile anche ai primi, in quanto impegnati sul fronte della città, della polis).
Il venir meno di istanze ideali e – ciò nonostante – il persistere di istanze morali, non è un fenomeno inedito: si è già verificato storicamente. La Milano degli anni ’50 e ’60, sotto questo profilo, costituisce un’esemplificazione perfetta di tale fenomeno. Gli architetti che vi operavano non erano per la gran parte animati da “alti” ideali: erano solidi professionisti, dediti con la massima serietà al proprio lavoro. “Professionisti colti”, come sono stati spesso chiamati: dove la cultura in questione soltanto in qualche sporadico caso corrispondeva a un vero e cosciente posizionamento intellettuale nel panorama architettonico dell’epoca, e nella gran parte degli altri coincideva piuttosto con una perfetta conoscenza della propria attività e delle sue ricadute progettuali e costruttive, ma anche con un’etica che impediva loro di imboccare inammissibili scorciatoie qualitative e di accettare irragionevoli compromessi.

Pur non mancando di comprendere nomi di spicco (si pensi soltanto a Gio Ponti, oltreché progettista, grande designer e fondatore di «Domus»), questa schiera di “professionisti colti” era composta anche da molti nomi “minori”: dove con tale aggettivo non va inteso nulla di semplicemente minorativo, quanto piuttosto quelle figure che più raramente assurgevano agli onori della ribalta, pur essendo autori di una produzione a dir poco eccellente (il caso di Mario Asnago e Claudio Vender, “riabilitati” soltanto in anni successivi, è il più clamoroso di tutti, ma non certamente l’unico). Ciò fa sì che, per quanto riguarda l’architettura della Milano degli anni ’50 e ’60 viga – al pari della biblioteca di Aby Warburg ad Amburgo – la “legge del buon vicino”. Se infatti quest’ultima era organizzata in modo tale che il libro “decisivo” si trovasse accanto a quello cercato, nel caso di quella Milano, l’edificio di fianco al capolavoro ben noto e acclamato si rivela spesso altrettanto interessante di questo, e qualche volta persino di più. Quanto si determina in tal modo è una qualità largamente diffusa, anziché una concentrazione in pochi, e per quanto significativi, episodi. Una città bella, in luogo di una bella architettura (dove “bella” non va intesa in termini puramente estetici, bensì come sinonimo di “ben fatta”).
Naturalmente gli architetti non erano i soli “responsabili” di quella città. Al loro fianco vi erano altre componenti non meno essenziali: un ceto politico, formatosi di sovente nelle file della Resistenza, che – per quanto diversificato al suo interno a seconda dei diversi partiti di appartenenza – era però animato dalla volontà di operare per il “bene comune” (il caso di Antonio Greppi, sindaco della città dal 1945 al 1951, risulta emblematico); una classe imprenditoriale fortemente radicata nella città e nel territorio, e dunque sensibile a tali interessi, percepiti come coincidenti coi propri, e di conseguenza in grado di esercitare con piena consapevolezza il ruolo di committenza “avveduta”; una compagine di costruttori interessati – al pari degli altri attori coinvolti nel processo di modificazione della scena urbana – alla buona riuscita dell’opera, che nel loro caso si traduceva in un’accuratezza esecutiva corrispondente, in un momento di impetuoso sviluppo per un’Italia sotto molti aspetti ancora legata a pratiche artigianali, a un’alta perizia manuale nella realizzazione di lavorazioni ormai spesso industriali.
È da questo quadro, articolato, composito, e ciò nondimeno abbastanza chiaro nei suoi tratti generali, che nasce la felice mediocritas dell’architettura milanese di quel periodo. Mediocritas che si lascia descrivere nei termini di una virtuosa “appropriatezza”, ovvero nel sapersi misurare – o meglio ancora, commisurare – con le preesistenze, con l’assetto viario e con il tessuto edificato; nel saper parlare una lingua moderna, rispondente allo slancio progressista dell’epoca, e insieme risonante di “etimi” profondamente confitti nella storia, negli strati del luogo. Un’“appropriatezza” che si rivelava tale pure nel preciso rapporto che istituiva col tempo, riuscendo l’architettura della Milano della ricostruzione e del boom economico a farsi di sovente compiuta espressione del momento presente: non però di una semplice, fuggevole “attualità”, bensì di una “tensione” attiva, produttiva, tra passato e futuro. Massimi “campioni” di ciò sono i due emblemi complementari di cui orgogliosamente la Milano della fine degli anni ’50 si dota: la Torre Velasca e il Grattacielo Pirelli.
E ancora, precisamente “appropriata” è la sobrietà che caratterizzava quella Milano: quasi il riflesso dello stile di vita frequentemente adottato negli anni in cui essa – oltreché una parte significativa di sé – costruiva anche la propria mitologia di “capitale del lavoro”; sobrietà consistente in una ben proporzionata mistura di raffinatezza, eleganza, semplicità e morigeratezza. Un “senso della misura”, per dirlo con una sola espressione, che va però messo in rapporto con il suo essere già in quel momento la città più ricca e sviluppata d’Italia.
Ma più che in ogni altra manifestazione, l’“appropriatezza” dell’architettura milanese degli anni ’50 e ’60 si dimostrava tale nella sua qualità urbana, nella sua attitudine a “fare città”. Stare bene nel luogo nel quale si trova, da questo punto di vista, costituisce la somma virtù di un’architettura che sappia essere “media”, ossia che sappia stare in mezzo alle cose, intessuta, connessa insieme (con-texta) con esse. In altro modo, si potrebbe definire una tale virtù di quell’architettura milanese una assai ricercata e abilmente praticata arte della conversazione: in senso essenziale, l’arte del mettersi in relazione, che ha quali suoi presupposti la conoscenza e il rispetto dell’altro, e come effetto più o meno diretto la relativizzazione (non certo la diminuzione!) del proprio valore.

E oggi? Non è certo un caso che, in un’epoca come la nostra, dominata dallo strapotere dell’ego e giunta al punto da interrogarsi su “come vivere insieme” (“How we will live together?” era il titolo della 17. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, curata da Hashim Sarkis e svoltasi nel 2021), palesando così le proprie difficoltà al riguardo, l’arte della conversazione sia ormai caduta in disuso.
Ma non si tratta soltanto di questo. Le componenti in gioco nella Milano attuale, pur essendo formalmente le stesse di quelle della Milano del dopoguerra, hanno completamente mutato di-segno: in sintesi estrema, tutte – ceto politico, classe imprenditoriale, architetti, costruttori – “dipendono” ormai pressoché per intero dall’apparato economico-finanziario. Non si tratta certo di una novità: anche la Milano del dopoguerra, come ogni altro contesto occidentale nei tempi moderni/odierni, era profondamente commista con l’apparato economico-finanziario. Non avrebbe potuto costruirsi/ricostruirsi – e con la qualità e l’attenzione per l’“ambiente” in cui s’inseriva – se non avesse potuto contare sulla disponibilità di imprenditori (nella maggior parte dei casi locali), disposti a investire in tali operazioni cospicue risorse.
Si pensi ad esempio al primo grattacielo costruito a Milano in quegli anni, la Torre Breda, 31 piani per 116 metri di altezza: progettata da Luigi Mattioni e dai fratelli Eugenio ed Ermenegildo Soncini tra il 1950 e il 1955, per la sua realizzazione verrà costituita una società apposita, la Grattacielo di Milano s.p.a., comprendente al suo interno imprenditori milanesi e piacentini: dove questi ultimi erano proprietari dell’azienda Fornaci F.lli Rizzi, Donelli, Breviglieri e C., operante del settore dei laterizi e dei prefabbricati. Non si tratta – com’è facilmente intuibile – di colossi della finanza, e ciò nondimeno animati dalla volontà di entrare a far parte di un’impresa rilevante per la città ma che prometteva evidentemente anche di essere vantaggiosa.

Il problema dunque non sono le implicazioni economiche, anche da parte degli architetti: quello dell’architettura è – come tutti sanno – un mercato; e come accade in tutti i mercati, a fronte di qualcuno che compra c’è qualcuno che vende. È piuttosto una questione di “misura”: quale sia il peso che hanno tali implicazioni. Non si sta parlando qui di “illeciti” scambi economici, quanto dell’adesione ormai generalizzata di tutte le componenti sopra citate a un modello che ha nell’“economico” il suo unico parametro di riferimento. Così, se da un lato gli investitori si sono progressivamente spersonalizzati e “finanziarizzati”, gli amministratori politici si sono ridotti a semplici esecutori dei voleri dei primi, mentre le imprese sono state costrette a gettarsi nell’assai poco gloriosa “gara al ribasso” per ottenere gli appalti.
E gli architetti? Per molti di loro (ma non per tutti, ovviamente: ogni generalizzazione, in questioni di questo genere, sarebbe azzardata) la professione si è ormai ridotta a un semplice esercizio di “rispecchiamento” dei desideri del cliente: un’affannosa rincorsa ad accaparrarsi a qualunque costo la “commessa d’opera”, costo che spesso consiste proprio nel bene stesso dell’opera. Un descensus ad inferos di qualsiasi compromesso in cui spesso ne va, insieme alla dignità dell’architetto, proprio la qualità dell’architettura. Basti soltanto pensare a Cascina Merlata (per tacere del resto).
Quello che spinge in questa direzione gli architetti sono del tutto comprensibili – e più che leciti, del resto – interessi di natura economica, ma anche l’ambizione di “posizionarsi” negli ambienti che contano, con tutti i vantaggi che possono derivarne. E se un tempo Nietzsche poteva scrivere che «l’architetto è sempre stato sotto la suggestione della potenza», oggi – sollecitato da brame ancora maggiori ma privo in compenso di quella pur piccola dose di “idealità” che anche la “volontà di potenza” in quanto tale comporta, l’architetto soggiace a una pura e semplice volontà di potere: potere fare, potere decidere, poter guadagnare, poter esserci.
Ancora una volta, va chiarito: sono “sirene” che incantano tutti (o quasi), nella società contemporanea, e non gli architetti soltanto: fama, denaro, potere. E tuttavia, cedervi è un “peccato” molto più grave per l’architetto che per gli esponenti di altri mondi professionali, dal momento che l’architetto è (o dovrebbe essere) portatore di responsabilità sociali e civili, oltreché di interessi individuali. Ma il vero aspetto insidioso di tali “cedimenti” è costituito dal fatto di ridurre quello che per sua natura è un’arte/tecnica (precisamente in questo duplice modo va tradotta la parola greca techné, a cui appartiene di diritto quella architettonica) a un semplice “mestiere”. Quali siano le insidie sottese all’applicazione del termine “mestiere” al campo operativo dell’architetto lo rivela ancora una volta la sua stessa radice etimologica: “mestiere” deriva dal vocabolo latino minister, aiutante, servitore, che si contrapponeva in origine alla parola magister, maestro. Se infatti magister è composto da magis (maggiore) più il suffisso -ter, minister è composto da minus (minore), più lo stesso suffisso -ter.

Nel suo significato originario (evidentemente molto diverso da quello che oggi gli attribuiamo), il ministro è dunque il “servitore” dell’arte, mentre il maestro è colui che ne possiede il pieno controllo, colui che ne detiene i “mezzi di produzione”, come si potrebbe anche dire. Che cosa significa allora ridurre l’architettura a “mestiere”? Significa riconoscerne – coscientemente o meno, ha poca importanza – la costitutiva debolezza, e addirittura l’assoluta inferiorità, nella situazione presente, rispetto alle figure e alle pratiche che sulla scena urbana contano davvero, vale a dire quelle riconducibili all’apparato economico-finanziario.
Da questo punto di vista, l’aspirazione al potere di alcuni architetti contemporanei (e forse segretamente di tutti) non si traduce affatto in una restituzione di tale potere all’architettura, come invece andrebbe correttamente fatto: giacché il potere che ha in sé l’architettura – qualora venisse attivato dall’architetto – corrisponderebbe perfettamente al bene dell’opera; ma, esattamente all’opposto, si traduce nel tentativo di esercitarlo per interessi del tutto soggettivi, per ottenerne “vantaggi” puramente personali.
Al contrario, l’architetto che volesse – oggi – avere davvero potere, ovvero non quel relativo “potere” derivante dal rispecchiare i desiderata delle potenze imperanti, facendosi unicamente “servitore” dei loro interessi, dovrebbe cercare piuttosto di tornare ad essere libero: libero professionista, anzitutto, e non professionista a “sovranità limitata”. Dovrebbe cercare insomma di esercitare non già un “mestiere” bensì un magistero, se mai ne fosse capace. Potrà sembrare – quella appena espressa – un’idea stravagante, o peggio ancora, una sognante utopia. E tuttavia, esiste la possibilità di accordare libertà professionale e mercato. Certo, chi sul serio si impegni in tal senso, nella prospettiva – ma si potrebbe anche dire, nell’interesse – dell’arte/tecnica dell’architettura, si troverà a dover affrontare la difficile conciliazione, non tanto più tra bisogni pratici e aspirazioni spirituali, o tra utilità e bellezza, e neppure tra idealità e realtà, quanto tra potere dell’architettura e potere economico-finanziario.
Aporia irrisolvibile? Contraddizione apparentemente insanabile? Oppure è dato – da architetti – cercare in qualche modo di scioglierla? Professione difficile, quella dell’architetto, si è detto. Louis Kahn, un grande architetto – o meglio ancora, un maestro dell’architettura –, negli Stati Uniti d’America, la patria del capitalismo e la culla dell’economia di mercato, ha dovuto confrontarsi precisamente con la medesima aporia. Lo ha fatto rifiutando per sé il ruolo di semplice esecutore, ma non per questo ha rinunciato alla possibilità di mettere in pratica il proprio lavoro. Lo ha fatto esprimendo nei fatti la massima philía nei confronti dell’architettura, anziché più semplicemente tradirla, tradendo con questo le responsabilità alle quali – da architetto – era chiamato. Lo ha fatto imprimendo alle proprie opere una superiorità qualitativa (magis), in luogo di limitarsi ad amministrare (minus) il progetto come una “pratica” burocratica.
Ma Kahn ha fatto ancora qualcosa di più: ha compreso qualcosa che alla gran parte degli altri è sfuggita. E lo ha scritto anche con grande chiarezza: «Se guardiamo il lavoro di Le Corbusier, di Aalto o di Mies, penso che sia giusto chiedersi: cosa c’è di Mies, di Le Corbusier, di Aalto che appartiene all’architettura? Ciò che vi è di ineluttabile o di eterno, quello naturalmente appartiene all’architettura». Quel che se ne evince è che i grandi architetti – i veri maestri dell’architettura – non sono coloro che in essa proiettano maggiormente se stessi, i propri soggettivi interessi: sono invece coloro che danno spazio a ciò che appartiene all’architettura, a quel potere che in essa vi è.
Potrà sembrare una “conclusione” idealistica. Eppure, per un maestro come Louis Kahn, essa può avere ricadute sorprendentemente concrete. Si legga: «Credo che se creassimo spazi che esprimono compiutamente le attività che vi si svolgono, le istituzioni avvertirebbero la necessità di cambiare i loro programmi. Credo che farebbero molte più concessioni agli architetti se le loro opere rispecchiassero di più il potere dell’architettura».
Osservando le opere di Kahn, questo principio sembra aver funzionato. Anche osservando la Milano del dopoguerra, questo principio sembra aver funzionato. Altri tempi? Altri mercati? Può essere. E allora, non resta che accettare il perpetuarsi ad aeternum della situazione attuale, con tutte le problematiche che ne conseguono. Oppure no. È troppo pensare che possa funzionare anche per noi?
Leggi anche:
Maria Luisa Ghianda | Tecnico, oppure archistar? / L’architetto come intellettuale







