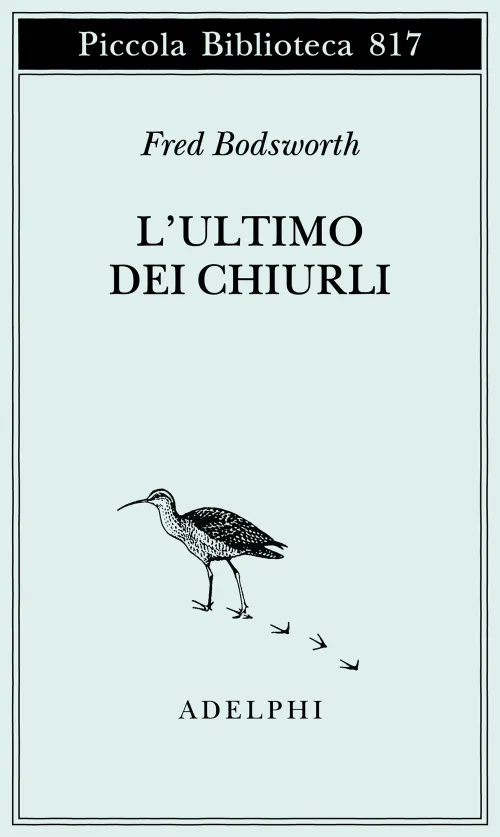L'estinzione dei chiurli polari
A rendere riconoscibile il chiurlo eschimese era il lungo becco ricurvo che terminava con un’appendice simile a una falce con cui, “rapido come l’ago di una macchina da cucire”, estraeva dal terreno le larve e gli insetti acquatici di cui si nutriva. Ma la sua fama, tra gli uccelli, era soprattutto data dalla straordinaria capacità di volo che gli permetteva di coprire migliaia di chilometri senza mai posarsi e quindi senza mai mangiare. L’uso dell’imperfetto è d’obbligo. Perché stiamo parlando di una specie estinta, i cui ultimi avvistamenti risalgono alla metà dello scorso secolo. Per i luoghi in cui viveva si è trattato di un evento impossibile da non notare. Fino agli ultimi decenni dell’Ottocento era l’uccello più presente nel continente americano.
Gli stormi contavano migliaia di esemplari che, a terra, occupavano ottocento metri in lunghezza e cento metri in larghezza. Ma i chiurli non erano soliti difendersi, incapaci di avere paura dell’uomo. Cacciarli era davvero un gioco da bambini, talvolta era sufficiente un bastone. Venivano mangiati, la loro morbida carne era considerata particolarmente saporita. Già ad inizio Novecento erano diventati rarissimi, annientati come i colombi migratori, l’altra specie di volatili che scomparve in quel periodo. È in questo contesto che bisogna collocare L’ultimo dei chiurli, il romanzo dello scrittore e naturalista canadese Fred Bosworth, pubblicato nel 1955 e proposto ora da Adelphi con la traduzione di Cristiana Mennella. Sono gli anni in cui negli Stati Uniti nasce una coscienza ambientalista, come rivelano anche i libri di Rachel Carson, tra cui il seminale Storie dalle profondità del mare (1941). Si comincia ad avere le idee chiare sul ruolo giocato dall’uomo nell’estinzione delle altre specie e, in particolare, si evidenzia quanto l’estinzione di un gruppo di viventi non sia in fatto in sé concluso ma determini profondi rivolgimenti all’intero ecosistema. Quello di Bosworth, in aggiunta, è un romanzo. Il presupposto è dunque che ad elementi legati al piano della realtà si aggiunga l’apporto immaginativo dell’autore e che il personaggio protagonista incontri altri personaggi con cui condivide un’avventura.
Insomma, il romanzo impone almeno un’ombra di plot. Il chiurlo di Bosworth è un eroe senza consapevolezza. Se c’è un tratto su cui lo scrittore canadese insiste – probabile indizio del behaviourismo particolarmente radicato in Nord America – è proprio quello della sua incoscienza. Il chiurlo ha un “cervello rudimentale”, è tutto istinto “cieco e millenario”, moto inconsapevole, risposta meccanica agli stimoli forniti dall’ambiente. Non ha se non una grossolana capacità di ragionamento, memoria debolissima, né è capace di sperimentare emozioni: le pulsioni hanno origini dalle ghiandole e dagli ormoni, qualsiasi dimensione ulteriore gli viene negata dalla natura. Fa quello che la legge della specie gli detta. Così, all’inizio della storia, lo troviamo nella tundra artica, quando, durante la breve estate, i membri della sua specie si ritrovano per nidificare. Il problema è che il chiurlo non sa di essere l’ultimo. L’attesa della femmina, l’eccitazione sessuale, la difesa rabbiosa del proprio territorio non portano a nulla. Il chiurlo rimane solo, prigioniero di impulsi a cui non può essere data soddisfazione. Intorno a lui, oltretutto, la vita pullula.
Ci sono migliaia di altri uccelli, compresi quelli che più gli si avvicinano, i chiurli hudsoniani, con cui, comunque, non potrà mai convivere. Bodsworth sembra riconoscergli una labile capacità riflessiva: il chiurlo, immalinconito, talvolta è attraversato dalla domanda sul perché, solo lui, sia sempre solo, da almeno cinque anni. Ma non è nulla di profondo. Così, quando l’istinto riproduttivo lascia il campo all’istinto migratorio, il chiurlo sente il bisogno di muoversi. Il viaggio verso il Sudamerica, come si verifica da generazioni, è preferibile farlo insieme a dei compagni e i pivieri dorati sono gli unici che possiedono le qualità necessarie per resistere al suo fianco. O meglio, dietro di lui, perché il leader dello stormo, disposto in cielo con uno schema a V, sarà solo lui, il chiurlo con “le sue ali lunghe, strette ed elegantemente appuntite”. L’epica subentra all’elegia. Il chiurlo evidenzia tutte le sue qualità nella discesa verso le aree meridionali del continente.

Mosso dalla sua bussola interiore (“una sorta di navigatore con il quale certe parti nascoste del suo cervello erano sottilmente sintonizzate”), ovvero da una “cognizione semplice, incolore, pragmatica”, dopo aver rifocillato lo stormo con le energetiche bacche di empetro del Labrador, affronta il percorso verso est via mare, resiste ad una furiosa tempesta, non smette mai di trascinare il gruppo, dorme in volo muovendo le ali per inerzia, prima di affrontare sessanta ore di traversata senza mai fermarsi fino ai tropici e di lì all’Orinoco. Da qui prende avvio l’ultimo tratto della migrazione che spinge il chiurlo verso le pietrose terre della Patagonia, a “tredicimila chilometri dalle aree di nidificazione artiche”, a un solo giorno di distanza dall’Antartide. Esaurita la spinta migratoria, uno “strano torpore” si impossessa dei pivieri e del chiurlo: “Mangiavano, sonnecchiavano e volavano svogliatamente, aspettando, come un attore che ha scordato le battute, che l’istinto suggerisse cosa fare”. Per il chiurlo c’è anche altro. Il riposo fa riaffiorare il senso di solitudine e la “vaga brama di sempre”, una “nostalgia di casa” che faceva riemergere il desiderio di rimettersi in cammino verso Nord.
Quando ormai sembra che nulla possa cambiare nella vita del chiurlo, destinato a continuare ad essere “per nove mesi di migrazione”, la pedina “di un’immensa scacchiera composta da due continenti”, mossa dalle “forze cosmiche della natura e della geografia”, Bodsworth regala il colpo di scena. Improvvisamente, davanti agli occhi del chiurlo, si profila la femmina: nel romanzo “è lo strano momento clou, banale e sottotono” che forse non ci si attendeva. I due si riconoscono subito, anche se “quel riconoscersi non implicava un ragionamento. Fu istantaneo ed intuitivo”. Non avendo mai visto un proprio simile l’agnizione nasce da un insieme di dettagli: “Fu la combinazione fra voce, postura e movimenti dell’altro uccello, non il suo aspetto, a segnalargli all’istante che era arrivata la sua compagna”. Con il dono di una lumachina alla femmina, ha inizio la passionale storia d’amore. I chiurli non si separano più, procedono affiatati anche se rimandano l’accoppiamento al momento opportuno, quando l’eccitazione del maschio e l’ovulazione della femmina saranno complete. Da soli decidono di risalire verso le zone artiche, dove avverrà la nidificazione.
La coppia affronta situazioni di estrema difficoltà, perché la via del ritorno avviene lungo un altro itinerario, che prevede l’attraversamento delle Ande, “l’imponente barriera di calcare, tempesta e neve”, che ogni anno il chiurlo si sorprende di riuscire a superare. La sorte sembra aiutarli, nonostante le fasi drammatiche e la scarsità di cibo offerta dalle strette spiagge peruviane lambite dalla gelida Corrente di Humboldt. Arrivano nello Yucatan, poi in Texas, dove sono avvistati per l’ultima volta, quindi in Nebraska e in Dakota. Procedono con calma, è maggio, la tundra artica non è ancora pronta ad accoglierli. Ma il caso ha previsto che il sogno non si compia. È proprio nel momento in cui finalmente i loro corpi si uniscono, tra le zolle di un campo destinato ad essere coltivato a mais, che un uomo, il contadino, imbraccia un fucile e spara, colpendo mortalmente la femmina.
Il chiurlo, di nuovo solo, non può che proseguire verso l’estremo nord, convinto dall’istinto che qualcosa accadrà, che un’altra femmina si presenterà nel territorio che lui le ha, ancora una volta, preparato. È la terza trasformazione del protagonista, che questa volta assume la fisionomia del personaggio tragico, prigioniero di quanto è stato programmato dal suo organismo. Ma, nella prospettiva del romanzo, c’è un’altra forza in gioco, in qualche modo anch’essa indebitamente prigioniera del suo istinto. Si tratta della brutalità umana, quella di cui Bodsworth lascia traccia attraverso la serie di documenti che intervallano la narrazione con brevi capitoli tutti intitolati allo stesso modo, “La sfida”. Cosa significa? Fino ai primi del Novecento, si legge in uno dei resoconti, dei chiurli gli esseri umani hanno fatto strage. La ferocia degli uomini non ha trovato ostacoli, perché i chiurli “erano così fiduciosi, così solidali con i compagni, che cadevano in file compatte, facili vittime di quella carneficina. Queste miti creature hanno affrontato ogni volta la sfida e nessuno ha mosso un dito per proteggerle fino a quando non è stato troppo tardi…”. Insomma, se l’istinto tiene il chiurlo dalla parte della vita, l’autocoscienza umana produce tragedie.