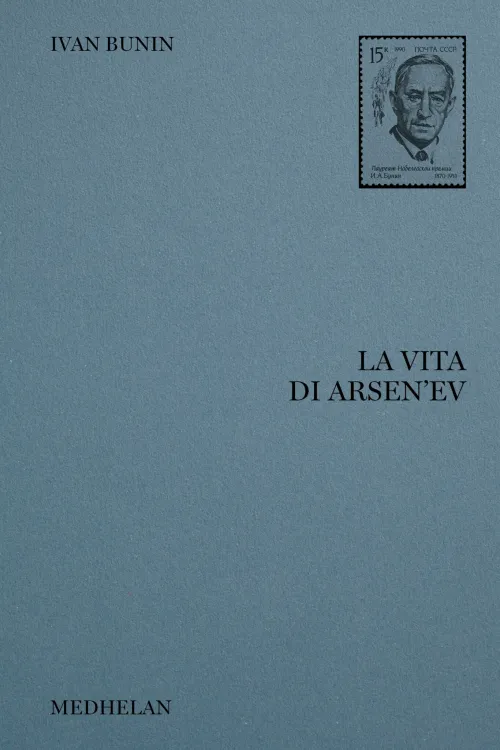Bunin, un Nobel russo da riscoprire
Il 6 febbraio 1930 Ivan Bunin da Parigi mandò al giovane Nabokov, con il quale intratteneva uno scambio epistolare da diversi anni, una copia della Vita di Arsen’ev con una dedica lusinghiera: lo elogiava per il suo talento e gli augurava un cammino «lungo, felice e glorioso». Nabokov, che aveva già letto l’opera uscita prima su rivista, era rimasto così colpito dalla sua bellezza e dalla sua perfezione che aveva sùbito scritto una recensione elogiativa sul quotidiano dell’emigrazione russa a Berlino «Rul’», in cui affermava di trovarsi nella stessa situazione di stupore in cui si trova Arsen’ev nel capitolo VI del libro III di fronte alla meraviglia di una notte di luna. A Bunin, invece, rispose così: «le mie gambe sono a Berlino, tutto il resto è nella Russia di Arsen’ev». È una Russia, quella di Arsen’ev, rivisitata e idealizzata negli anni Venti del Novecento da un inviato dell’Ottocento (così è definito Bunin da Igor’ Suchich), come se nel presente atemporale dell’emigrazione la tradizione ottocentesca, cui lo scrittore rimane fortemente ancorato, fosse l’unica possibile per conservare la memoria, orgogliosa e leggendaria, di un intero mondo perduto.
A distanza di quasi cento anni dalla pubblicazione a Parigi della Vita di Arsen’ev, opera in quattro libri che il poeta Vladislav Chodasevič, elegantemente e in modo quasi ossimorico, definì «autobiografia immaginaria» o «autobiografia di una persona immaginaria», e in tempi tra l’altro di una nuova ondata dell’emigrazione russa, l’editore Medhelan ha dato vita a un’operazione editoriale molto interessante: nel 2024 ha ripubblicato con una Prefazione di Andrea Tarabbia la traduzione di quest’opera che Ettore Lo Gatto firmò nel 1966 per Fabbri; oggi questa versione appare un po’ invecchiata, o quantomeno segnata dalla patina del tempo, ma resta pur sempre molto efficace e rispettosa dello stile di Bunin – elegante, ad alto tasso di lirismo e particolarmente dettagliato. Altrettanto efficace è la traduzione italiana di Lika, parte V e ultima della Vita di Arsen’ev, che l’editore ha dato alle stampe nel 2025, affidando questa volta l’intero lavoro a Tarabbia – la sua breve nota introduttiva è molto utile a inquadrare meglio questo libro, che uscì nello stesso anno in cui fu conferito a Bunin il Premio Nobel, il 1933, sulla rivista dell’emigrazione russa a Parigi «Sovremennye zapiski» e poi come parte conclusiva della Vita di Arsen’ev solo nel 1952, per la Chekhov Publishing House. Completa il quadro, in Lika, un’Appendice, Una strana osmosi: sguardo italiano su Bunin-poeta, a cura di Alessandro Niero, che seleziona, introduce (in pagine dense di informazioni fondamentali sulle traduzioni poetiche precedenti e sul contesto letterario russo di fine XIX-inizio XX secolo) e traduce quattordici poesie di Bunin.
Tarabbia riprende le parole di Chodasevič e intitola così il saggio introduttivo della Vita d’Arsen’ev: L’autobiografia di una persona immaginaria, quasi a suggerire una qualche parentela con il romanzo di Proust (di cui è protagonista un je «qui n’est pas moi») o magari con il capolavoro di Svevo (che con Zeno sosteneva di aver scritto «un’autobiografia e non la mia»); e a ricordare che le scritture dell’io oggi più in voga – a cominciare dall’autofiction – non sono un’invenzione del secondo Novecento. Ma a proposito di definizioni, Bunin ha chiamato La vita di Arsen’ev un «poema in prosa»; e Tarabbia giustamente invita il lettore a non cercare qui «un arco narrativo, uno sviluppo», perché il libro è la rievocazione in prima persona di un flusso continuo di immagini liriche cariche di colori e sensazioni legati all’infanzia e all’adolescenza del protagonista nella Russia dell’ultimo quarto dell’Ottocento – esemplare, nella parte conclusiva, l’immagine della stazione di Orël affollata, mentre passa il feretro di Alessandro III, che dalla Crimea viene trasferito nel 1894 a San Pietroburgo.
Una tavolozza dalle tinte intense, alcune delle quali più ricorrenti, come il lilla (per esempio dei bordi delle nuvole), o il turchino (del cielo, spesso sfumante in lilla); e poi il canto delle allodole, delle gracchie o di altri uccelli; la vastità dei campi, da sùbito motivo d’orgoglio per il protagonista, perché l’aperta campagna russa «un europeo non può nemmeno immaginarla»; la precisione di certi oggetti impressi per sempre nella memoria (un lucido per le scarpe, per esempio): tutto questo trama le prime pagine della Vita, insieme a un diffuso senso di malinconia e di paura.
Paura della perdita, del vuoto, del distacco dal nido familiare. Di sua madre, il protagonista scrive: «Mia madre era per me un essere del tutto speciale tra gli altri, inseparabile dal mio proprio essere; l’avevo notata e sentita, probabilmente, quando avevo sentito me stesso…». Il padre, invece, ci viene presentato così: «Avevo cominciato a interessarmi a lui ed ecco che già sapevo qualcosa: che non faceva mai nulla, e, veramente, passava i suoi giorni in quel felice ozio che era allora tanto consueto non solo nell’esistenza della nobiltà campagnola, ma in generale in ogni russo; che si rianimava sempre dopo pranzo e a tavola era allegro». E proprio al padre, che aveva dissipato tutto il patrimonio costringendo la famiglia a vivere quasi in miseria, Arsen’ev dedica alcune tra le pagine più profonde ed empatiche dell’intero libro, ritornando a lui con riconoscenza e affetto nelle pagine finali della Vita di Arsen’ev e, con il rimorso di non averlo amato abbastanza, anche in quelle di Lika.
I veri avvenimenti, nei primi diciassette anni di vita del protagonista, si contano sulle dita di una mano: l’incontro spaventoso con l’immagine di sé allo specchio all’età di sette anni, quando capisce che «non era ormai più un bambino» (anni dopo il regista Andrej Tarkovskij, grande estimatore di Bunin, ricorrerà allo stesso procedimento, caricandolo di analoghi valori simbolici nel film autobiografico Lo specchio); la morte improvvisa della sorella, la piccola Nadja, dopo che, due mesi prima, Arsen’ev si era gravemente ammalato e poi era guarito – proprio come nel Tifo di Čechov (di cui Bunin si considerava allievo, poi divenne suo grande amico); l’ammissione al ginnasio e il vero distacco da casa, con la conseguente percezione, per la prima volta, «che ero russo e vivevo in Russia e non semplicemente a Kamenkа, in un certo distretto, in un certo comune, e d’un tratto la sentii, questa Russia, sentii il suo passato e presente, le sue selvagge, terribili e tuttavia affascinanti caratteristiche e il mio legame di sangue con essa…»; e infine, tra pochi altri avvenimenti, l’incontro conclusivo con Lika a Orël, città nel sud-ovest russo, nella redazione di una rivista, quando oramai la vocazione poetica di Arsen’ev si sta delineando, nutrita dalle sue crescenti peregrinazioni e alimentata dallo stretto contatto con una natura che lo sorprende e lo ammalia, con il suo «fumo lunare» o lo scintillio della neve «bianco-turchina» nelle notti invernali di luna.
In Lika, che riprende dove La vita di Arsen’ev si era interrotta, ci troviamo di fronte, pagina dopo pagina, a una vera e propria esplosione di impressioni, sensazioni, emozioni, colori, odori, e per questo di nuovo vengono in mente le parole di Nabokov: si avrebbe voglia di moltiplicare le citazioni, di riportare innumerevoli frasi che assomigliano a piccoli «miracoli», perché diversamente il senso profondo che scaturisce dalla narrazione è inesprimibile. In questo scorrere di immagini catturate dallo sguardo inquieto del protagonista-poeta adepto del tolstoismo (come Bunin nei tre anni successivi al suo esordio poetico nel 1891), si perde la dimensione temporale degli avvenimenti, e i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni rotolano via in una corsa fatta di accelerazioni e rallentamenti, di ripetizioni e di moti pendolari che possono anche disorientare – alla fine, il protagonista avrà solo vent’anni, eppure sembra che un’intera vita sia già stata vissuta.

Al centro di questo turbinio di colori e suoni si stagliano due nuclei tematici centrali, collegati fra loro: in primo luogo, l’innamoramento e la relazione con Lika, all’inizio spesso rievocata in modo vago con il pronome personale di terza persona femminile. È un rapporto tormentato, fitto di ostacoli, fatto di dolorose separazioni, ma anche di radiosi ritrovamenti, come quando i due vivono insieme a Poltava – è questa una parentesi inizialmente felice del loro amore, prima di un definitivo e tragico addio: oramai tormentata dalla gelosia, da crisi di follia e dalla solitudine, Lika sparisce lasciando solo un biglietto e, sparsi sul pavimento della loro stanza, alcuni indumenti che le erano appartenuti. La notizia della sua morte per polmonite pone per sempre fine alla speranza di Arsen’ev di un nuovo incontro.
Il secondo grande tema è legato alla postura di Arsen’ev poeta, che cita versi di nomi della tradizione ottocentesca cara a Bunin: Fet, Polonskij, Žukovskij, introducendo nelle citazioni lievi modifiche (ma più che di imperfezioni della memoria, secondo uno specialista di Bunin come Evgenij Ponomarev, si tratterebbe di un adattamento consapevole dello scrittore, che procede con i testi altrui come con i propri, rielaborandoli di continuo), oltre a passi dalle opere di Gogol’, Tolstoj, ecc. Di fronte all’insensibilità iniziale di Lika, che non comprende il simbolismo del linguaggio poetico, la reazione del protagonista è questa: «Ero indignato: descrizioni! Cominciai a spiegarle che non esiste una natura separata da noi, e che ogni minimo movimento d’aria è un movimento della nostra stessa vita». Commenti di questo tipo, uniti a intere citazioni dai suoi taccuini – si tratta per lo più di annotazioni cariche di sfumature sensuali che nascono dai vagabondaggi in giro per la Russia e l’Ucraina; dalle soste nelle stazioni ferroviarie o dall’ingresso nelle chiese (anni dopo, nei Diari, Tarkovskij avrebbe particolarmente ammirato queste pagine per «quella nostalgia, quella speranza, quell’esigenza di austerità, che la gente miope chiama temperamento bilioso»); dagli incontri con mendicanti, una vecchia sarta, una lavandaia, ucraine seducenti e avventori di taverne – conferiscono all’opera un tono dichiaratamente metaletterario. Arsen’ev poeta, infatti, ci sta spiegando come avviene il processo creativo, dichiara il suo interesse esclusivo per i dettagli (spesso quelli meno evidenti, come, per esempio, un vassoio, lo spago bagnato), e mai per la vita del popolo nel suo complesso, mostrandoci così dall’altra parte dello specchio il volto dello stesso Bunin, che inizialmente appuntava su pacchetti di sigarette, foglietti di calendari o di giornale una sua impressione, un dettaglio, una frase, e poi trasferiva tutto in un quaderno, quindi riutilizzava questi appunti e li sviluppava nelle sue opere, cancellando l’annotazione per non riutilizzarla una seconda volta.
Infine, giunto al termine della sua dolorosa rievocazione, prima di affidare al sogno la possibilità dell’ultima apparizione di Lika, Arsen’ev abbozza una riflessione sulla natura del ricordo, anticipando così uno dei temi centrali dell’opera successiva, Viali oscuri: «I ricordi sono così pesanti e terribili che esiste perfino una preghiera speciale che implora di esserne salvati».
Dopo queste pagine di intensa prosa lirica, troviamo in Appendice una scelta di poesie. L’editore ha scelto opportunamente un modello di libro «à la Bunin» – come ebbe a dire Nabokov, commentando non senza un filo di bonaria polemica la combinazione di racconti e poesie scelte all’interno di uno stesso volume –, per valorizzare un lato meno conosciuto dello scrittore: il quale, prima di tutto, si considerava poeta e, dato significativo, quasi smise di scrivere versi in concomitanza con la partenza dalla Russia nel 1919. Grazie all’Appendice, dunque, è possibile osservare da vicino quel «sistema di vasi comunicanti tra lirica e narrativa», secondo la felice definizione di Niero, che tanto caratterizza l’opera di Bunin; e forse anche iniziare a rivalutare veramente un aspetto della sua opera rimasto troppo schiacciato dal confronto con l’«immensa stagione dell’Età d’argento» della poesia russa.
Delle quattordici poesie scelte, tutte con testo a fronte, tredici sono state composte tra il 1888 e il 1917; a queste, se ne aggiunge una del 1952, Notte, in evidente dialogo con Notte, strada, fanale, farmacia… di Aleksandr Blok: la poesia si apre con il verso «Notte diaccia, mistral» e si chiude con un verso analogo «freddo, brillìo, mistral», mentre nel mezzo ci sono il poeta e Dio, cui solo è dato conoscere la «morta mestizia» dell’io lirico – Bunin morirà l’anno dopo a Parigi. Notte, luna, solitudine e tristezza sono forse le parole più ricorrenti nelle prime poesie e sembrerebbe quindi che al poeta bastino loro, come a Arsen’ev, che nel capitolo XII di Lika, quando vorrebbe scrivere ciò che osserva, afferma: «sì, sì, ecco che cosa bisogna scrivere, e bastano tre parole in tutto: neve, baracca, lampada…».
Poi, però, fa capolino anche la gioia di un bambino che vorrebbe «volteggiare insieme al turbine chiassoso per il bosco»; in Infanzia, questa fase della vita è pervasa di calore («Brillìo ovunque e ovunque luce vivida, sabbia di seta…»); in Giovinezza il cuore «in gioia arcana, va struggendosi perché la vita è vuota e vasta come la steppa». Il ricordo del passato è soave e in Giorno verrà che sparirò irrompe la realtà oggettuale: quando il poeta sarà morto, oltre al volo di una farfalla (che «frulla, fruscia e freme / per il soffitto azzurro»: ottima la riuscita della traduzione allitterante), resteranno dopo di lui un tavolo, una panca, un’icona «antica e schietta»; in modo analogo, nella Vita di Arsen’ev, lo sguardo del protagonista si posa sulle pantofole dello zio morto e pensa che «lui non c’è più, ma le pantofole sono sempre lì e possono starvi magari per cento anni ancora!»: a riprova di quella «strana osmosi prosopoetica» che Alessandro Niero annuncia nella sua Prefazione.
Ritorna la realtà del quotidiano, ma con un più deciso abbassamento prosastico, anche nel verso «Comprare un cane non sarebbe male» che chiude Solitudine, in cui il protagonista viene abbandonato dalla donna amata. Avrebbe voluto gridarle «Torna da me, ormai mi sei nel cuore!» (in Strinsi le mani sotto il velo scuro Anna Achmatova invertirà le parti: sarà la protagonista a soffocare in un grido le parole «Muoio se te ne vai»), ma alla fine mette in sordina il sentimento e lo distanzia, nella consapevolezza che i tempi non consentono più l’assoluto dell’amore romantico – e qui, nel verso finale di questa bella poesia, sembra perfino di sentire il tono ironico e scanzonato del padre di Arsen’ev, che della Russia rurale e nobiliare di fine Ottocento, idealizzata e rimpianta da Bunin nell’esilio, incarnava al tempo stesso la solare vitalità fuori dal tempo e le contraddizioni votate alla catastrofe.