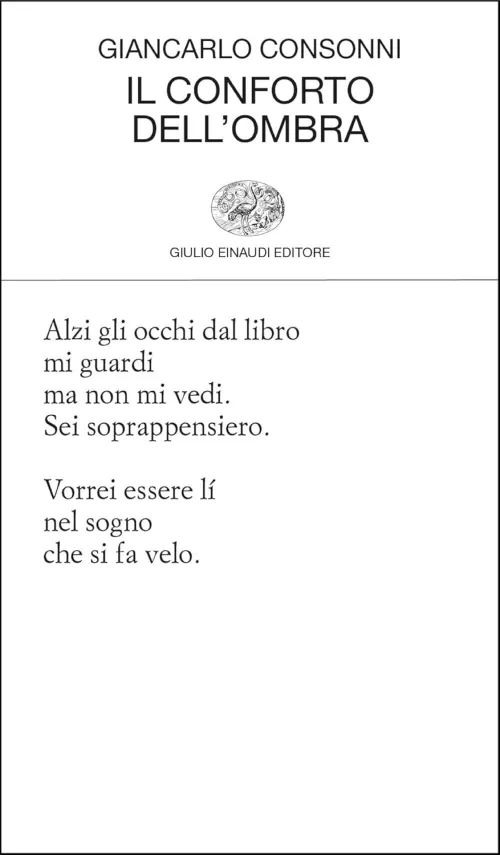Giancarlo Consonni oltre il velo delle cose
In un tempo che preferisce il brodo insipido della tuttologia alla specializzazione e alla competenza critica, qual è il ruolo degli autentici “talenti multipli”, quale il loro compito?
La risposta, ovviamente, va trovata caso per caso, sebbene in giro di casi se ne vedano pochi. Tra i pochi c’è senza dubbio Giancarlo Consonni, del quale dirò qui nella rinverdita veste di poeta (nel mese di febbraio ha dato alle stampe Il conforto dell’ombra per Einaudi) ma ribadendo in premessa quanto contino, nella sua pronuncia lirica, la lunga militanza accademica (al Politecnico di Milano) di insigne urbanista-umanista, la coloratissima creatività di pittore (e di penetrante lettore di pitture altrui), l’estro satirico di saltimbanco della lingua che purtroppo da parecchio tempo non produce più libretti pseudonimi – era lui il D’Avec che, negli anni a cavallo del secolo, ci deliziava coi suoi rebusi sulle pagine rimpiante di «l’Unità».
Il talento multiplo di Consonni s’è dato una missione non facile: contemperare l’arguto e impietoso sguardo critico sul decadere delle forme di convivenza civile con una prospettiva scevra da toni apocalittici perché nutrita da una sostanziale fiducia nella forza trascinante dei colori della vita, nello svariante spettacolo della natura nella possibilità che l’essere umano si ricreda e ritrovi l’indispensabile humanitas quando sembra ormai sporto inesorabilmente sul definitivo precipizio. È, questa, l’impressione che l’attività complessiva del talento multiplo Consonni non da ora mi ha dato e che di recente era stata confermata dal nitidissimo Non si salva il pianeta se non si salvano le città (Quodlibet, 2024), ultima incursione in volume del Consonni saggista, che insegnerebbe molte cose a chi si occupa di urbanistica soltanto sull’onda di clamorose inchieste giudiziarie.
Ma torniamo a Conforto dell’ombra, che sembra invece, fin dal titolo, elogiare la scelta della ritrazione, dell’accortezza, della «parola che abita il silenzio», apparentemente contrapposta alla «parola che sa stare tra la gente»: ho citato gli ultimi due versi di Parola, lirica-esergo della raccolta, posta in posizione prefatoria, alla quale seguono tre sezioni, intitolate “I gelsi spaesati”, “Babylo minima” e “Dono” e che contengono rispettivamente liriche di proustiano movimento memoriale; poesie ispirate da Milano, minima Babilonia contemporanea; testi di sapienziale domesticità o doni, talvolta ecfrastici, per amici e affetti assai vicini.
L’organizzazione coerente del libro di poesia è una forma già sperimentata da Consonni, del quale vorrei ricordare, in successione cronologica, i titoli precedenti: Viridarium (1987) e Vûs (1997) nel dialetto di Verderio, In breve volo (1994), Luì (2003), Filovia (2006), Pinoli (2021) in lingua italiana. Poiché il poeta Consonni esordisce in età non verdissima (è nato a Merate nel 1943), i temi e le forme preponderanti della sua poesia hanno avuto modo di presentarsi con chiarezza fin dall’inizio, e poi via via di rafforzarsi, di diventare stilemi: la memoria dell’infanzia e dell’adolescenza, la configurazione della comunità metropolitana, la presenza vivificante della vita animale e vegetale, nelle forme predilette della brevitas epigrammatica o, più spesso, contemplativa (ma vorrei scartare il troppo facile riferimento al modello haiku, vista la felice libertà di trasgredire le regole metriche nipponiche che, giustamente, Consonni ha scelto). Tutto questo è ribadito, ma anche ulteriormente chiarito, nel segno sempre più sapiente di una felicissima senilità, da Conforto dell’ombra; e in esso la già citata lirica incipitaria riafferma, con sommessa dichiarazione di poetica, la centralità della parola rispetto all’articolazione del periodo. Ma Consonni evita l’oltranza scarnificata della parola ungarettiana, optando piuttosto per una confidente semplificazione del dettato, per un “parlare all’orecchio” che dal Leopardi più puro viaggia attraverso il Novecento su percorsi triestini, liguri, appenninici e lombardo-ticinesi per arrivare, limpidissimo, fino a noi.
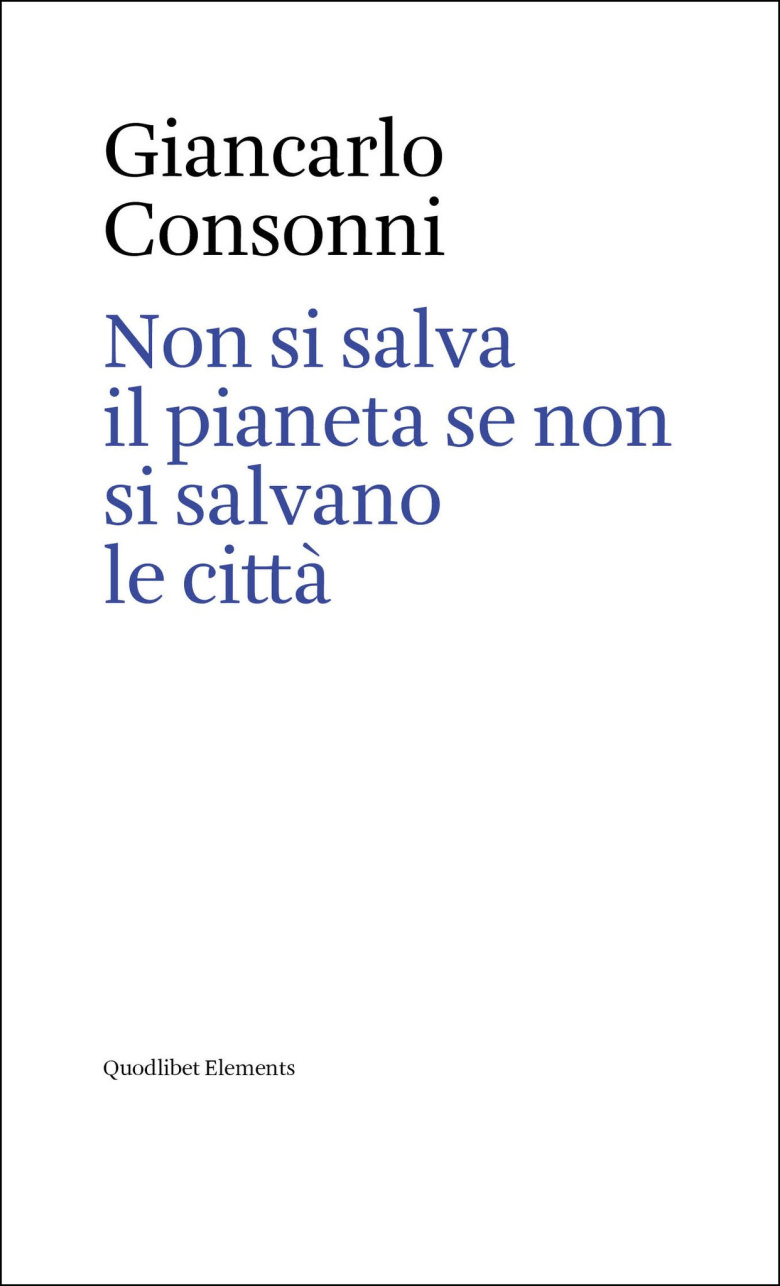
Pure in questo libro la resa poetica del ricordo-madeleine si accampa, come ha scritto Clelia Martignoni a proposito delle prime opere di Consonni, «in misure asciutte e arcaiche, atemporali e circolari, con forte materialità e corporalità», sebbene in questa produzione più recente siano più espliciti i riferimenti a un orizzonte di anni, quelli della Ricostruzione, decisivi per il Consonni bambino e per un’Italia che ancora non aveva del tutto reciso i legami con la civiltà contadina. La temporalità, dunque: talvolta la precisione è massima, come in Volantini, dove la pioggia di foglietti elettorali dal distico finale è perfettamente datata a una svolta epocale: «È l’inizio di aprile / del millenovecentoquarantotto»; altre volte è minore, come quando l’adolescente incontra la sua prima lametta da barba: «Ma la guerra era alle spalle / e a quel poco sangue sul viso rasato / rispondeva il sorriso / inalberato sulla povertà». O come quando ritornano alla mente i miti orrorosi, nutriti dalle parole udite nei racconti a veglia o in parrocchia, di un piccolo mondo compreso tra fiumi, campi, orti e sacrestie: a proposito dell’Adda, che «Strisciava come un serpente / ma non si vedeva la testa» o di più sinestetici trasalimenti: «I temporali impetuosi / cavano alle strade polverose / odore di zolfo. / Da ogni poro / la terra trasuda demòni». Mentre il dato economico contingente investe, al di fuori di qualsiasi idillio, il rapporto con gli animali più prossimi, come le talpe «scuoiate ed essiccate» che, rivendute allo straccivendolo, fruttavano «venti lire al pezzo» perché «Appena finita la guerra / c’era chi confezionava pelliccette / con pelli di talpa». Eppure le trasfigurazioni fantastiche tipiche dell’età infantile garantivano un legame stretto tra la comunità e il sacro, come si deduce da Rothko: «Per tappeto alle statuine / il verde scuro del muschio / e, a fare da cielo ai portici, / il giallo oro delle pannocchie appese. / Rothko pensaci tu»; oppure, ancora più chiaramente, dalla tornita e chiastica quartina di Presepe: «Uscivi dal paese / entravi nel presepe, / uscivi dal presepe / entravi nel paese».
Una delle note più suggestive della prima sezione è quella offerta dal cortocircuito fra la nitidezza del ricordo infantile e il sovrapporsi dell’elaborazione culturale successiva: lo si è già visto in Rothko ma accade anche in Vasèl, in Ciliegi o in Morlotti.
Non esemplifico ulteriormente ma quel che conta è la sorridente serenità con cui l’intellettuale Consonni ci suggerisce che l’immediatezza del ricordo è un falso mito, e quel che conta è l’incastro a ritroso tra memoria “ingenua” e substrato colto, di cui l’essere umano non può fare a meno, sebbene il trionfante populismo contemporaneo cerchi di farci credere il contrario. E si diceva di come lo sguardo poetico non sia scindibile dalle conoscenze tecniche dell’architetto-urbanista: si veda l’opposizione, in Asfalto, tra i ricordi sussultori determinati dai selciati fatti di sassi e l’avvento dell’asfalto, «praticissimo demone / della dimenticanza». Va da sé che le poesie più ricche di spunti siano, in tal senso, quelle dedicate a Milano, talvolta ispirate da libri d’artista o dal ricordo di persone che, loro malgrado, hanno lasciato traccia evidente di sé nel vissuto collettivo (come si legge nella strofe conclusiva di Per Milano con Enzo Rocca e Alberto Scibona: «Chiamare al gran finale / i personaggi / le situazioni / i luoghi / l’allungarsi delle ombre / quel che rimane della nebbia»): per esempio, la coppia formata da Alinka e Tolek Prusicki (si legga la magnifica Fili: «Se ti rubano la vita, / per quel che ti resta / puoi tirare fili sul baratro / e provare, / come il funambolo, / a fare del vivere un gioco») o come il ferroviere Pinelli (Giuseppe Pinelli: «È silenzio nel cortile. / Il sangue scorre senza fare rumore. / Da quel 19 dicembre / non smette di scorrere»).
Non manca la satira delle asfissianti stupidaggini della vita odierna: il curriculum vitae, il meteo, le location, le password da ricordare ossessivamente (ma «Mai che mi ricordi / come si aprono / i cancelli del cielo»). Come resistere? Tenendoci saldamente alle acquisizioni della cultura che permettono, tra l’altro, di ancorarsi al possesso della ricchezza linguistica, premessa indispensabile d’una ludica saggezza (si legga Guscio: «Il gheriglio / ha un nascondiglio / come la tenerezza / nel cipiglio»). Aggrappandoci alla cura degli affetti (Tienimi stretta, L’albero del pepe), magari traslati nell’ecfrasi di una serie di dipinti che molto hanno interessato Consonni perché hanno in comune la presenza dell’oggetto libro, in mano a lettrici, lettori o studiosi (ne derivano splendide e brevissime liriche, come, tra le altre, Velo, ispirata da un quadro di Boccioni: «Alzi gli occhi dal libro / mi guardi / ma non mi vedi. / Sei soprappensiero. // Vorrei essere lì / nel sogno / che si fa velo»).
Se poi è lecito comparare a quello che apparentemente è incomparabile, direi che le ultime liriche del libro rammentano gli ultimi canti del Paradiso dantesco, giocate come sono sul desiderio, sulla luce, sul tempo, sulla parola poetica, sull’inesprimibile. E non soltanto perché il Paradiso è evocato nella chiusa di Ci sono giorni, che offre il titolo a tutto il libro («Come faranno in Paradiso / senza il conforto dell’ombra?») ma perché è in queste liriche finali che Consonni ha fatto coagulare le sue provvisorie conclusioni sul senso dell’essere, del vivere. Con una matura e affettuosa comprensione di quello che in fondo sono il tempo e il passato: elementi del vivere quotidiano rispetto ai quali non deve darsi rimpianto o strazio (in estate il tempo «è cenere che canta»; i giorni passati «sono lanuggine / in fondo alle tasche»). Soltanto così l’occhio saprà cogliere nei fenomeni naturali l’essenza, il necessario (come in Attesa), che forse consiste, simbolicamente e concretamente, nell’equivalenza di luce e ombra, racchiusa nella forza insormontabile del dire poetico. Lo rivela, con chiarezza, Grembo, la lirica conclusiva: «Si sfa la luce, / si sfa l’ombra. // Tornano insieme / nel grembo della parola».