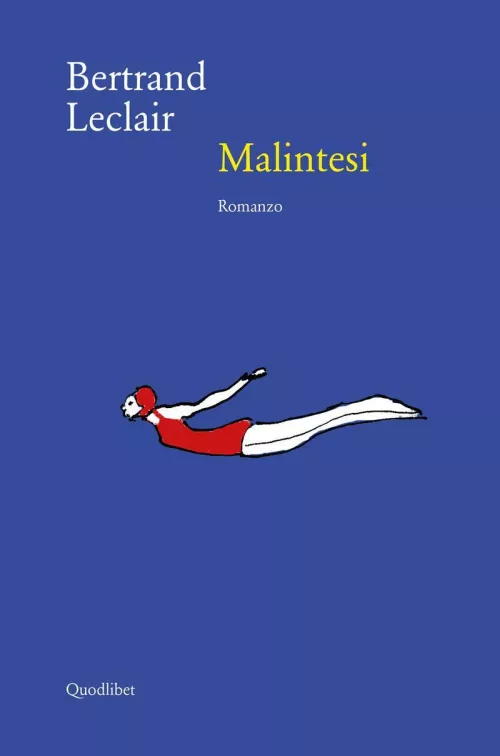La Giornata internazionale delle persone con disabilità / La violenza della parola pura
Ricorre, nel discorso dei Disability Studies, l’omologia tra la forma dell’affermatività disabile e ciò che viene chiamato minority model, la modalità di lotta iniziata negli anni Sessanta da gruppi minoritari, donne, afroamericani, LGBTQI+, e in qualche modo è così: una rivendicazione su base identitaria vincolata a un’interpellazione parziale determinata dal genere, dall’origine etnica, da condizioni esistentive particolari. Forse però il modello andrebbe predatato di quasi due secoli, per coglierne la matrice nella nascita e nell’affermazione della comunità Deaf. Non sto dicendo che vadano predatati i Disability Studies, e ciò per una ragione semplice e insindacabile: le persone Sorde non si considerano disabili, ma minoranza linguistica.
Lennard Davis, teorico dei Disability Studies, udente ma legato alla comunità Deaf, in Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body (1995) sostiene la tesi “in qualche modo assurda che l’Europa sia diventata sorda nel Diciottesimo secolo”. La sordità, nel tempo dell’Illuminismo, viene ad assumere una valenza simbolica centrale in ragione di un evento, la codificazione del linguaggio dei segni da parte di Charles-Michel de L’Épée, più noto come l’Abbé de L’Épée, filantropo la cui finalità era salvare dalla dannazione eterna i Sordi insegnando loro la parola divina. Davis sostiene che in precedenza la sordità non esisteva, era una condizione che non trovava luoghi al di fuori delle famiglie, correlata al mutismo. La creazione dell’istituto per giovani Sordi a Parigi e la diffusione del linguaggio dei segni aprirono lo spazio per la nascita della più coesa tra le comunità linguistiche. Questo venire alla luce della comunità Sorda entra in risonanza con lo spirito del tempo, è una forma esemplare dell’“uscita dallo stato di minorità” di cui parla Kant.
Da qui parte una delle due storie che in Malintesi di Bertrand Leclair (Quodlibet, 2019) si sviluppano e si sostengono reciprocamente. Una pubblica, quella della comunità Sorda, una privata, la vicenda della nascita nella famiglia Laporte di un figlio sordo. Come in moltissime circostanze in cui i temi della disabilità (o della peculiarità sensoriale, come in questo caso) prendono forma letteraria, – si pensi a Pontiggia di Nati due volte, a Il figlio eterno di Cristovão Tezza, a La caduta di Diogo Mainardi –, a monte c’è un’interpellazione personale dell’autore, in quanto Bertrand Leclair è padre di una ragazza sorda. La narrazione è esemplare, nel senso che racconta una vicenda che si ripete nella vita di moltissime persone Sorde, il rifiuto di una formazione oralista e l’adesione radicale alla comunità Sorda. Il padre Yves Laporte, tipografo infatuato per la figura di Alexander Graham Bell, inventore del telefono e teorico radicale della formazione oralista dei Sordi, impone al figlio Jules l’acquisizione della “parola pura”, del linguaggio verbale senza il sostegno della scrittura e tanto meno di supporti gestuali, violentemente preclusi. Su Jules ricade il peso della storia ottocentesca della repressione del linguaggio dei segni, che in Bell, figlio e marito di donne sorde, trova una figura cardine.
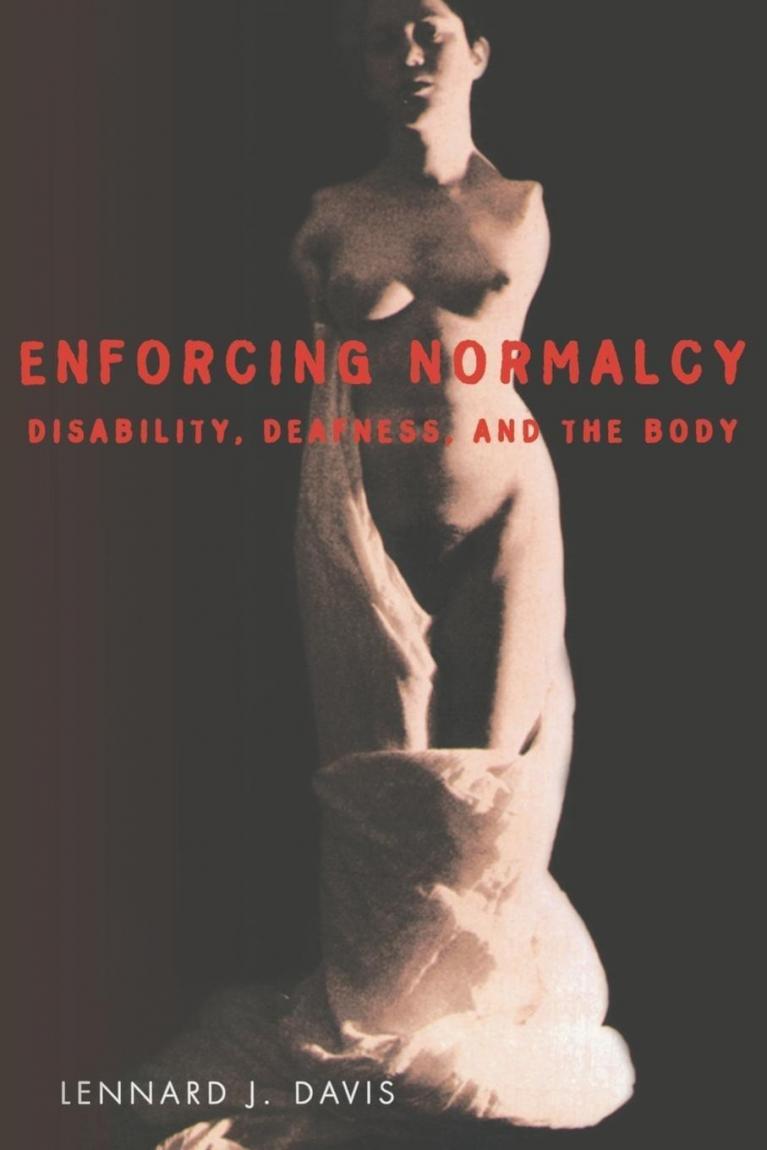
Le ingenti risorse ottenute dalle sue invenzioni furono impiegate per promuovere l’oralismo e per reprimere la lingua dei segni, nel frattempo migrata dalla Francia in Europa, in Italia grazie a Tommaso Silvestri e negli Stati Uniti per opera del discepolo dell’Abbé de L’Épée Laurent Clerc. Ciò che costituiva problema nella cultura dei segni era in primo luogo l’alterità della lingua, comprensibile solo a chi era nella comunità, un affronto all’omogeneità linguistica su cui si è strutturata l’ideologia nazionalista ottocentesca. I sordi erano uno Stato nello Stato, non si trattava più di farli accedere ai sacramenti e quindi al Paradiso, ma di integrarli nella comunità linguistica nazionale. La gestualità che sostanzia i segni era poi stigmatizzata come forma di linguaggio del corpo e non dello spirito, liquidata come espressione animalesca, malgrado la sua straordinaria capacità espressiva e la duttilità semantica. La pietra tombale sulla formazione ai segni venne posta dal “Congresso Internazionale per il miglioramento della sorte dei Sordomuti” tenutosi a Milano nel 1880, che affermava la necessità di una formazione oralista e la dismissione del linguaggio dei segni.
Anni di formazione oralista, di apparecchi acustici, di marginalizzazione sociale e di riduzione delle aspettative di vita spingono il figlio Jules a fuggire dal contesto familiare borghese di provincia in cui era cresciuto per unirsi alla comunità Sorda di Parigi, in cui trova modo di coltivare le sue risorse spirituali diventando attivista Sordo e insegnante della lingua dei segni.
Come detto, si tratta di una scelta esemplare. Conoscendo la complessità della questione, le contrapposizioni radicali sedimentate nel tempo tra le diverse e incompossibili modalità di relazione educativa alla sordità, mi ero interessato qualche anno fa a un progetto in stato nascente che l’università presso cui svolgevo il dottorato stava intramando. Tutto era nato dal fatto che il figlio di un docente, giunto alla maggiore età, aveva dismesso la formazione oralista, disattivato l’impianto cocleare e si era messo a studiare il linguaggio dei segni, generando sconcerto nel genitore. Progetto immediatamente imploso, come mi aspettavo, non appena venne tentata la costituzione di un tavolo di lavoro che comprendesse medici, educatori e associazioni. Esattamente in ragione dell’imposizione storica di una modalità di comunicazione loro impossibile, e della repressione violenta della loro lingua, i Sordi hanno estremizzato la loro posizione e totalizzato il fronte identitario, fino a estremi come l’assalto a cliniche che installano impianti cocleari e a congressi medici a tema. La repressione violenta chiama una violenza contraria, e la rigidità del padre si ritrova a fine romanzo in Jules, la violenza della “parola pura” subita preclude qualunque mediazione.
Non è il caso di ridurre libri interessanti e ben scritti, e quello di Bertrand Leclair lo è senz’altro, a formulette e apologhi morali, ma certamente la storia della comunità Sorda illustra come ogni tentativo di imporre la modalità comunicativa egemone a chi ne ha una propria, e non solo ai Sordi, ma vale anche per gli autistici e per chi è costretto a sradicarsi dal proprio contesto di vita da ragioni economiche, culturali o politiche, è un gesto violento di inclusione condizionale forzata, che porta a un’esclusione reale che chiama una violenza reattiva, tanto sacrosanta e comprensibile, quanto radicale.
Quest’anno è stato pubblicato un altro romanzo in cui la sordità gioca un ruolo fondamentale, ed è interessante giustapporlo a Malintesi, per quanto a un tempo simmetrico e distante. Claudia Durastanti in La straniera (La nave di Teseo, 2019) ripercorre la sua esistenza in una specie di autofiction, la cui struttura è in qualche modo isomorfa rispetto al libro di Leclair, se là si trattava di un figlio sordo di genitori udenti, qui di una figlia udente di genitori sordi. Il padre dalla nascita, la madre in seguito a morbillo infantile.
A differenza di Malintesi, giocato sulla contrapposizione tra due identità forti, padre e figlio, ciascuno con un simbolico di riferimento granitico, La straniera è un libro sullo spaesamento, sullo sradicamento come condizione ontologica, sul fluttuare tra frammenti significanti senza speranza nella loro ricomposizione in un quadro coerente. Nata a New York e trasferitasi bambina in un paesino della val d’Agri, la protagonista sconta nell’infanzia e nell’adolescenza la conflittualità e la problematicità dei genitori, incostanti, borderline, inaffidabili. La loro sordità è sempre in minuscolo, si vergognano a segnare, non cercano integrazione con un soggetto collettivo ulteriore, è una sordità in sé, che non si riconosce, che si nega come identità.
La prima ricorrenza nel libro di ciò che gli dà il titolo, la straniera, è in riferimento al modo in cui viene individuata la madre, in ragione del suo modo strano di esprimersi, e l’essere straniera in ogni luogo è la sorte che tocca alla protagonista, tanto nella New York frequentata durante le vacanze, quanto in Basilicata, esclusa dal dialetto, a margine del tessuto sociale del paese, e a seguire nella Londra post brexit. Neverland, riferimento con più ricorrenze, come luogo dell’anima, senz’altro scomodo: “Straniero è una parola bellissima, se nessuno ti costringe a esserlo; il resto del tempo, è solo il sintomo di una mutilazione, e un colpo di pistola che ci siamo sparati da soli” (p. 179).
La scrittura di Durastanti, precisa, incalzante, icastica, sembra generarsi in reazione al caos familiare, luogo proprio in cui abitare. Espediente per venire a capo di un mondo frammentato e affettivamente scomposto, che trova nel fratello prima, e nel compagno a seguire, le uniche figure stabili di riferimento. In tutt’altro modo, tutt’altra “parola pura”, si confronta con la sordità, in un serrato sforzo interpretativo in cui si redime la propria storia familiare.
Bertrand Leclair sarà presente a Più libri più liberi (Roma) con il suo libro Malintesi sabato 7 dicembre. Interverranno la linguista Virginia Volterra e la giornalista Lara Crinò. Sala Polaris, ore 15.30.