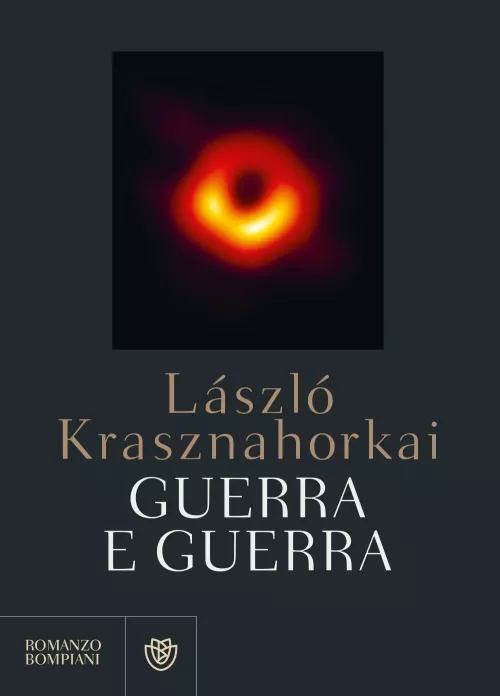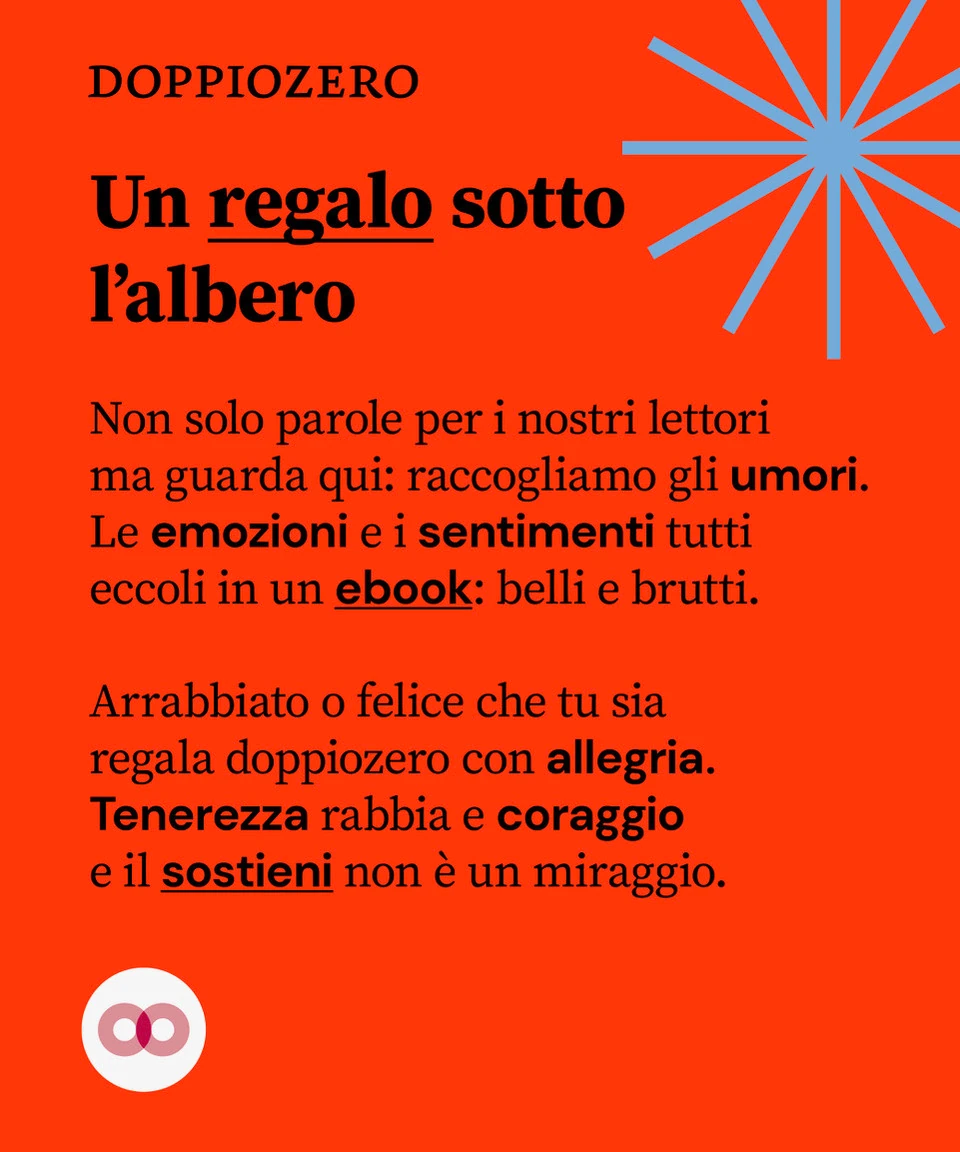László Krasznahorkai / Guerra e guerra, Storia e romanzo
Bompiani traduce finalmente Guerra e guerra di László Krasznahorkai (1999), proseguendo nella scelta di offrire ai lettori italiani i libri più importanti di questo autore (sono già usciti Satantango, 1985, una nuova edizione di Melancolia della resistenza, 1989, precedentemente portata in Italia da Zandonai, Il ritorno del Barone Wenckheim, 2016). La scelta dei volumi non è casuale: Guerra e guerra era il volume mancante di una ricerca romanzesca che, ha dichiarato l’autore, «un unico libro che [ha] affrontato e cercato di riscrivere per ben quattro volte». Guerra e guerra riprende i grandi temi dell’autore ungherese, come l’inquietudine da “fine della storia” che affligge i paesi post-sovietici (e i protagonisti di Satantango) o l’atmosfera in bilico tra sogno e realtà di Melancolia della resistenza, l’isolamento e la separazione dal consesso umano che caratterizzano i due protagonisti del Ritorno del Barone Wenckheim. Come nelle altre opere citate, il tempo di Guerra e guerra è un tempo sospeso, incerto, che risulta ancora più aleatorio grazie al continuo andirivieni nel tempo storico. Se nel Barone il tono è dostoevskjiano, per l’afflato metafisico e spirituale dei due protagonisti, qui il nume tutelare sembra Kafka (altro autore fondamentale per Krasznahorkai) a causa dell’alternarsi di slancio folle-immaginifico della trama e determinazione spaziale dei dettagli, insomma per la discrasia tra un cronotopo potenzialmente realistico (l’ambientazione newyorkese nello spazio angusto di un piccolo appartamento di Manhattan) e il flusso verbale (e verboso) che scardina quell’elemento realistico – ma l’abisso da affrontare qui non è tanto nell’opposizione al soggetto di un potere inconoscibile e bizzoso, come in Kafka, quanto nel soggetto stesso, nello sgretolarsi dei legami e del pensiero: se il Barone e il professore del Ritorno cercavano a modo loro Dio, qui, come si dichiara all’inizio, il protagonista è un angelos che non sa più a chi annunciare cosa.
Anche questo romanzo si muove su due piani: la cornice segue György Korin, ex archivista di una piccola città ungherese che ha ritrovato un manoscritto dal quale è rimasto ossessionato al punto da volerlo consegnare all’eternità e permettere a tutti di leggerlo. Il secondo piano è la storia del manoscritto stesso che segue le vicende di quattro personaggi, Kaiser, Falke, Bengazza e Toot. In ogni capitolo del manoscritto, misteriosamente, essi si trovano in diversi punti dello spazio e del tempo — nell’antica Creta, nella Colonia del 1869, a Venezia nel 1423 e ancora in Inghilterra all’epoca della costruzione del Vallo di Adriano e nella Spagna nel 1493, mentre si attende il ritorno di Cristoforo Colombo. Ogni volta arrivano in quello che credono «un eden», come il duca d’Auge di I fiori blu alla ricerca di un’uscita dalla Storia, e ogni volta poco dopo il loro arrivo il sogno crolla abbattuto da venti di guerra e devastazione giunti contemporaneamente al sinistro Mastemann. Ogni capitolo – ogni «eden» perduto – sembra delineare diversi modi di raggiungere la pace e di ottenere la felicità: la vita semplice dei cretesi; la tensione all’assoluto (divino e architettonico insieme) simbolizzato dalla costruzione del Duomo di Colonia, sempre interrotta e destinata a non completarsi; la distanza dalle beghe politiche locali e viceversa i legami con popoli lontani dovuta al commercio marittimo che il doge Tommaso Mocenigo aveva in mente per Venezia; la separazione dal caos dei barbari auspicata dalle fortificazioni romane (simbolo del «trionfo sullo stato di pericolo perpetuo, il trionfo sull’eterna permanenza del bestiale nell’uomo», 276); il gusto della scoperta simbolizzata dal viaggio di Colombo.
Di converso, ognuna di queste scene segna l’arrivo di una disgrazia: la guerra di conquista che sottomette Creta a Micene; il nazionalismo (simboleggiato dalla guerra franco-prussiana); la predilezione per la dimensione locale della politica che cancella le grandi arcate idealistiche qui simboleggiata dal successore di Mocenigo, Francesco Foscari (al quale si deve l’espansione di Venezia sulla terraferma); l’insopprimibilità degli istinti primordiali (rappresentata dalle forze naturali che contrastano i quattro mentre lasciano l’Inghilterra); infine la finanza «lo spirito [...] di Genova», anzi addirittura il
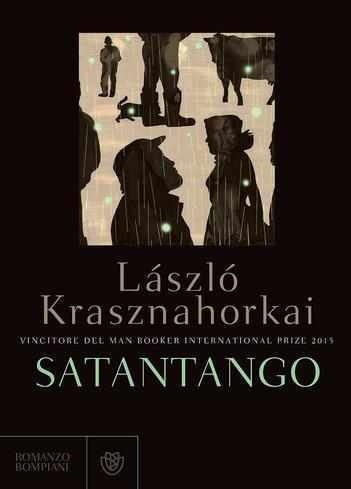
[...] genio di Genova, tuonò Mastemann, che con gli asientos e i juros de resguardo, le cambiali e i crediti, le obbligazioni e gli interessi, o per dirla con un’unica espressione, l’elaborazione del sistema della borsa generale, con cui si creava un globo completamente nuovo, dove i soldi e le relative operazioni non si basavano più sulla realtà, bensì sull’ingegno. (291)
Perché in un libro esasperato come questo, non è possibile la medietas, l’accordo virtuoso tra gli estremi che consente moderazione, anzi. L’idea di poter mediare sembra un tranello del mefistofelico Mastemann, il quale infatti elogia Giovanni II di Portogallo perché «basava le sue decisioni non sulle emozioni, sugli impegni assunti o sui giochi della sorte, bensì decideva in accordo alle emozioni, agli impegni o ai giochi della sorte sottoposti al vaglio della ragione» (284-5). Allo stesso modo il romanzo sembra dimidiato, sempre sul punto di disfarsi tra i suoi due principi: la precisione (elenchi, date, descrizioni dettagliate) e l’arcata compositiva basata sul ritmo (l’esuberanza stilistica), insomma: Crusoe e Tristram Shandy.
E fuori dell’arte, dove domina la medietas, c’è solo guerra; l’Eden è sempre perduto non appena conquistato, ovunque resta solo «l’incomprensibile e dolorosa e totale devastazione» (192) che, ci suggerisce Korin nella cornice, è proprio la Storia.
Anche se fin qui è stata utilizzata, la classica distinzione cornice-racconto è ardua da applicarsi a Guerra e guerra: da una parte la storia del manoscritto occupa un po’ meno di un quarto del volume, e compare solo a pagina 148 (sulle circa 350 del libro). Dall’altra, il racconto del manoscritto è filtrato dalla voce di Korin, che a sua volta parla per tramite di un narratore, così riducendo la distanza tra i due piani diegetici e rafforzando l’idea che il manoscritto sia una sorta di exemplum delle vicende di Korin. Dunque, la cornice: incontriamo Korin mentre arriva in un bar, farneticando, e si spara a una mano, nel 1992. Lo ritroviamo sette anni dopo mentre parte per New York, che per lui è il centro del mondo, con il manoscritto, intenzionato a renderlo eterno trascrivendolo e pubblicandolo su Internet. Come i quattro personaggi, anche Korin crede di essere arrivato, finalmente, nel suo Eden quando viene accolto da un connazionale conosciuto in aeroporto. Ma esattamente come per i suoi personaggi, l’Eden non è tale: il connazionale è dedito a brutti traffici e malmena abitualmente la compagna portoricana alla quale Korin ogni giorno riassume il pezzo di manoscritto che ha battuto al computer (è attraverso questi riassunti che noi conosciamo la storia dei quattro).
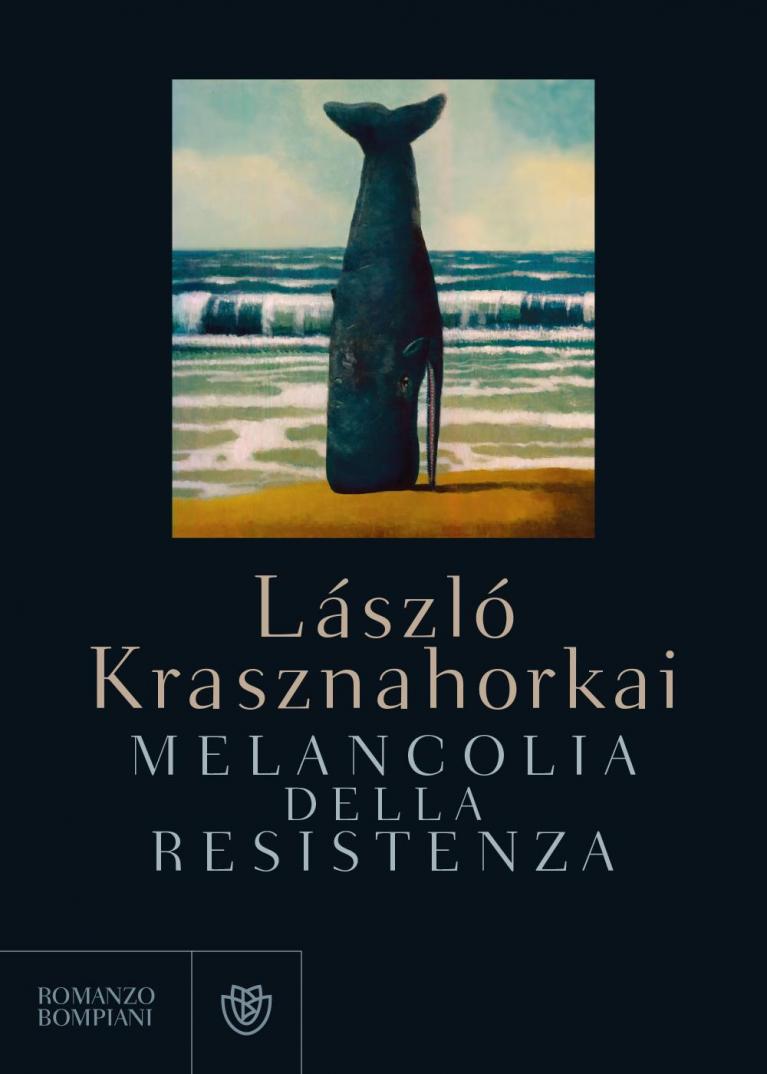
Il mondo in cui si muove Korin è il mondo «della compiuta peccaminosità», come avrebbe detto un altro György – ungherese come Krasznahorkai –, Lukács, dove gli dei non esistono e nessun gesto umano ha senso perché nessun uomo ha valore. In questo quadro si può leggere l’incontro con l’inquietante baby gang avvenuto alle porte di Budapest all’inizio del viaggio del protagonista: i ragazzini vorrebbero rapinare Korin, questi inizia uno dei suoi lunghi, incomprensibili monologhi, e loro lasciano perdere, senza nemmeno ricordarsi di ucciderlo, come pure avrebbero voluto fare. Uccidere o meno, vivere o morire: addirittura questi sono gesti senza senso in un mondo senza domani. Ancora, gli anfitrioni newyorkesi di Korin, uccisi per una faccenda di droga, muoiono senza che nessuno – a parte il protagonista – noti la loro assenza. Gli individui non hanno peso, non hanno spazio nella storia. La storia d’altra parte sembra essere questo vuoto, questo trascorrere di epifanie e distruzioni: è ciò che non contempla nobiltà, eccezionalità, straordinarietà. La storia è «inarrestabile nella tragica assenza di nobiltà e nel labirinto di volgari interessi opportunistici» (17).
È una storia senza grandezza, senza sogno, dove manca il male ma anche il bene (24): sembra quasi che sia stata concepita e si dipani nell’olimpico distacco in cui vivono i super-uomini ingegnerizzati che narrano Le particelle elementari. Come a dire, la post-historie, la fine della storia, è la Storia stessa. Di qui la follia di Korin, che per lui è «illuminazione», uscita dai vincoli del mondo dominato da una siffatta Storia. Viene meno al suo dovere di archivista sottraendo il manoscritto, vende la casa, lascia la sua terra. Addirittura non riesce più a parlare in modo pienamente comprensibile — una volta negli Stati Uniti per problemi di lingua, per cui le sue relazioni alla ragazza portoricana sono sempre confusionarie, ma già prima per una sorta di urgenza narrativa che gli taglia le parole in bocca («svlt» per “svolta”, «fsst» per “fissato”...), come se arrivasse a quel linguaggio primigenio vagheggiato da Walter Benjamin, mosso da una «necessità propulsiva» irrefrenabile:
questa spinta propulsiva ormai fuori controllo era in grado soltanto di sospingere e far scontrare tra loro i singoli elementi costitutivi delle parole, come una locomotiva in corsa che urtando contro un treno in sosta finisce per spingere e accatastare uno sopra l’altro i vagoni fermi, richiedendo all’interprete insieme celeste e terreno testimone dell’evento la capacità di riuscire a ricavare da “svlt” la parola “svolta” (24).

Il linguaggio di Korin è idiosincratico come il suo fraseggio: esagerato, enorme, dilatato per pagine e pagine, «monologo infinito che continu[a] ad attorcigliarsi» (53) nello stile tipico di Krasznahorkai. D’altra parte, come i quattro sono signa di Korin, Korin è signum del suo autore. Il protagonista, infatti, dopo avere eternato i quattro mettendoli a disposizione di tutti su Internet, si sacrifica affinché essi siano ricordati in un museo. L’arte è ciò che nega la storia di devastazione e distruzione in cui siamo immersi, che le si oppone: «Tra le cose vicine c’è una forte connessione, tra le cose lontane invece c’è una connessione debole, mentre tra le cose lontanissime non c’è connessione, e questo è dio» (262), dice Korin. Il romanzo, invece, riesce a rendere coeso ciò che apparentemente è sfilacciato, il flusso di pensieri del protagonista, le vicende dei quattro, la Storia stessa. L’antico agone tra romanzo e storia (come lo chiama Massimo Rizzante) è ancora in corso. E non, come in tante opere recenti, perché il romanzo riscrive la storia, dà spazio ai vinti, agli sconfitti, ma perché scrive un’altra storia. La storia della fantasia e dell’io, il locale (il minimo) e il generale (la fantasia), sempre evitando qualsiasi tendenza compromissoria.
Poiché l’arte non si limita a catalogare, archiviare, gli eventi, essa può essere «la realtà descritta fino alla pazzia, con tutte quelle dissennate minuzie, quelle maniacali ripetizioni, che oltre a evocare una situazione, la incidevano nell’immaginario» (268), come si dice del manoscritto in un passaggio chiaramente metadiscorsivo. Allora ci vuole un folle per rigettare la geometrica potenza della storia: solo l’arte può «narrare tutto insieme», senza «struttura», solo attraverso «ritmo e... pienezza» (50). Ci vuole il punto di vista di un folle – secondo una lezione antica quanto il romanzo – per vedere «l’essenza» delle cose, l’unica «inconcepibile eppure esistente realtà» (206). Alla fine, come si dice all’inizio del romanzo, al massacro della Storia sfuggono solo ombra e poesia.