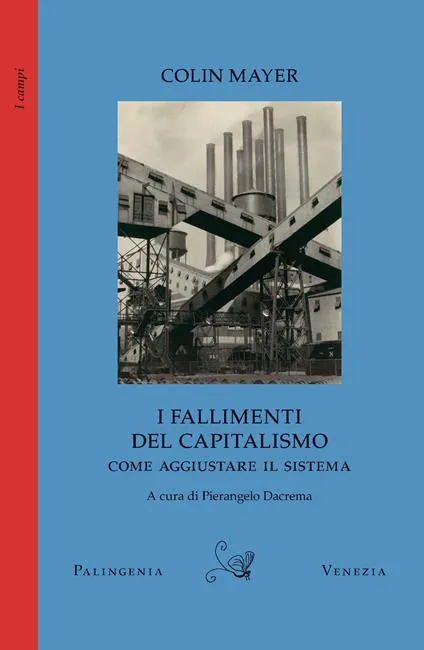Il capitalismo oltre i fallimenti
Colin Mayer è uno dei più influenti studiosi contemporanei di corporate governance. Professore emerito alla Saïd Business School dell’Università di Oxford, dove ha insegnato lungo quasi tutto l’arco della sua carriera, è noto sia per i suoi studi di finanza sia, più di recente, per aver ripensato in chiave innovativa lo scopo dell’impresa e il ruolo del diritto societario nella creazione di valore sociale.
Egli fa parte di quella ristretta cerchia di accademici capaci di parlare al grande pubblico senza semplificare il proprio pensiero, ma cambiando stile: meno teoria e più racconto, meno analisi empiriche e più immagini. I fallimenti del capitalismo è il terzo atto di una lunga riflessione su impresa e capitalismo, ma è anche il suo libro più leggibile per chi non è specialista di diritto societario o finanza.
Mayer intreccia autobiografia, storia europea e catastrofi contemporanee – guerra, crisi climatica, pandemia, fragilità delle democrazie – per arrivare a una tesi semplice e radicale: il problema del capitalismo non è la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma il fatto che si permetta alle organizzazioni private di fare profitti creando problemi agli altri, anziché soltanto risolvendoli.
Su questo sfondo si apprezza ancora di più il lavoro del traduttore, Pierangelo Dacrema. Chi traduce saggi di economia è abituato a prosa asciutta e precisa. Qui invece si è trovato davanti un autore che mescola teoria morale, teoria dell’impresa, riferimenti filosofici e il gusto molto letterario per le metafore, i giochi di parole, il ritmo delle frasi e gli artifici retorici. Restituire in italiano questa voce è un’impresa titanica (e in alcuni casi impossibile, come quando Mayer gioca sulla parola equity, che in inglese indica sia l’equità sia il patrimonio netto di una società per azioni), e si vede quanto Dacrema vi abbia riflettuto anche nel saggio finale, Gli antidoti contro i veleni del capitalismo, dove egli sviluppa riflessioni originali sul ruolo del denaro e degli incentivi e sulla misurazione del “profitto giusto”.
L’idea chiave del libro è la proposta di una nuova “Legge morale” del capitalismo: lo scopo delle imprese è produrre soluzioni redditizie ai problemi delle persone e del pianeta, non trarre profitto dalla creazione di problemi per gli altri. I profitti sono legittimi se e solo se sono il prodotto della risoluzione di problemi, non il risultato di danni arrecati a terzi – lavoratori, comunità locali, ambiente.
Mayer insiste perché questa “Legge morale” diventi principio giuridico, in particolare attraverso una lettura originale (ma ineccepibile secondo i canoni dell’interpretazione giuridica) della section 172 della legge inglese sulle società per azioni: il dovere degli amministratori di promuovere l’interesse della società viene reinterpretato come dovere di perseguire uno scopo che produca profitti solo risolvendo problemi, tenendo conto degli impatti della società su ambiente, lavoratori, comunità locali e così via.
In questo modo, il capitalismo non sarebbe più il sistema che, pur soddisfacendo i bisogni di tanti, produce crisi a ripetizione, ma diventerebbe un sistema in cui ricerca del profitto e neminem laedere diventano una cosa sola.
La domanda di fondo che questa proposta suscita è: si tratta di una ricetta compatibile con gli incentivi?
Compatibilità con gli incentivi, nel lessico degli economisti, significa che una regola ha caratteristiche tali per cui i partecipanti sono naturalmente spinti a rispettarla, perché farlo è nel loro stesso interesse. Se una regola non ha questa caratteristica, assicurarne il rispetto diventa un’impresa quasi disperata.
Mayer si richiama all’Adam Smith della Teoria dei sentimenti morali, secondo cui le regole di una comunità vengono rispettate non per puro altruismo, ma perché interiorizziamo lo sguardo di uno “spettatore imparziale”: obbediamo alle norme di decenza, equità, correttezza perché sappiamo che gli altri se lo aspettano. Se violiamo le regole, ci esponiamo al loro biasimo e all’esclusione.
La moralità smithiana, dunque, tende ad essere compatibile con gli incentivi: non richiede santi, ma individui sensibili alla propria reputazione e alle reazioni altrui, dunque motivati dall’aspirazione ad evitare di provare vergogna per i propri comportamenti.
Un elemento chiave perché ciò avvenga, tuttavia, è che l’ambiente sociale in cui si vive sia sufficientemente “civile” e, al contempo, uniforme: un macellaio della Glasgow dei tempi di Adam Smith si vergognava di comportamenti molto diversi da quelli da cui, per evitare il biasimo del proprio spettatore imparziale, deve guardarsi lo spacciatore al soldo di una gang di Boston. Spettatore imparziale che a sua volta sarà molto diverso da quello che, pochi isolati più in là, costringerà a comportamenti virtuosi il professore di Harvard o da quello, ancora diverso, del suo studente.
Mayer disegna un modello di capitalismo in cui un meccanismo analogo a quello dello spettatore imparziale opera al livello delle imprese. La “Legge morale” impone che le imprese che fanno profitti danneggiando sistematicamente gli altri vengano stigmatizzate, sanzionate, magari escluse dai mercati finanziari; quelle che risolvono problemi e internalizzano i costi ambientali e sociali siano invece premiate da consumatori, lavoratori e investitori.
Ma davvero questo equilibrio è raggiungibile in un mondo di concorrenza globale, arbitraggi legali e frammentazione culturale, ossia in un mondo più complesso, più aperto, più eticamente differenziato della Glasgow del diciottesimo secolo? Prima di affrontare questo interrogativo, è utile mettere in luce qualche criticità dell’idea di fondo di Mayer.
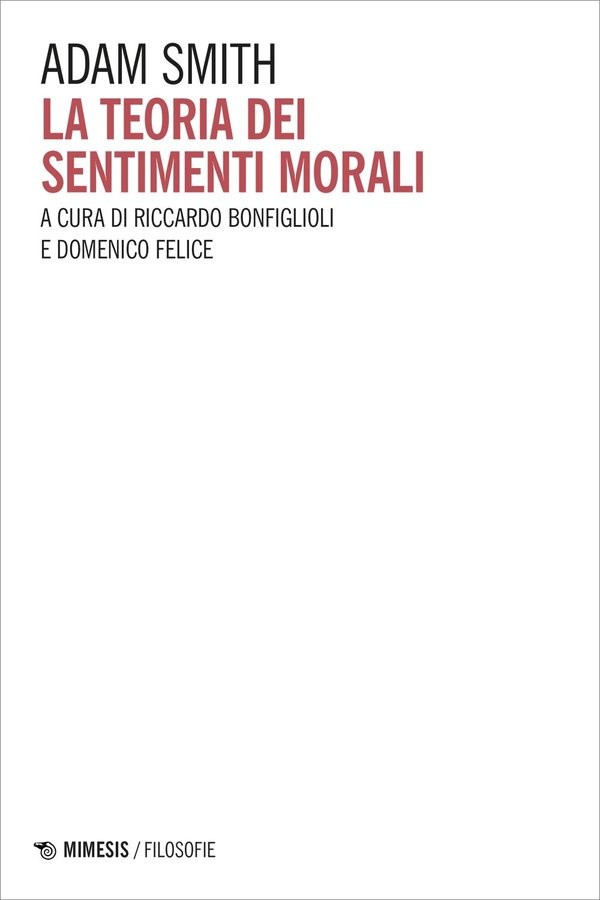
Uno dei passaggi più ambiziosi del libro è l’idea che le imprese possano e debbano sapere quando e quanto danneggiano gli altri, per poter evitare profitti che nascono dal creare problemi.
Qui emergono almeno tre difficoltà.
La prima è concettuale: che cos’è un danno? Un investitore repubblicano negli Stati Uniti potrebbe non considerare “dannose” le emissioni di CO₂ o la vendita di armi senza controlli; un investitore europeo, al contrario, potrebbe considerarli inaccettabili. Per alcuni il problema è il cambiamento climatico, per altri è la “cancel culture”, per altri ancora le politiche di diversità e inclusione. La Legge morale di Mayer presuppone un consenso di fondo su ciò che costituisce un’ingiustizia, un danno, un costo inaccettabile per gli altri – consenso che oggi, in molte comunità polarizzate, semplicemente non esiste.
Oppure si consideri una leggenda metropolitana che circola nell’ambiente degli architetti viennesi. Una società di sviluppo immobiliare acquistava interi palazzi fino ad allora di proprietà pubblica, abitati da anziani con affitti calmierati e il diritto di viverci fino alla morte. Una volta diventata proprietaria, la società installava un ascensore.
Gli inquilini erano entusiasti: finalmente potevano evitare le scale, uscire più facilmente, portare la spesa senza fatica. Ma il calcolo dell’immobiliare era che quella comodità avrebbe reso la loro vita più sedentaria, accorciandone l’aspettativa di vita e così anticipando il momento in cui gli appartamenti sarebbero tornati liberi e riallocabili a canoni di mercato.
La seconda difficoltà è conoscitiva: spesso non conosciamo gli effetti delle innovazioni tecnologiche. Mayer stesso, a un certo punto, allude al caso dei social media: davvero, negli anni Duemila, qualcuno avrebbe saputo prevedere la portata dei loro effetti sulla salute mentale degli adolescenti, sulla qualità del discorso pubblico, sulla stabilità dell’ordine democratico? E, una volta che li abbiamo scoperti, fino a che punto è ragionevole chiedere alle piattaforme di farsi retroattivamente carico di tutti i danni che hanno creato fino a quel momento?
La terza è contabile: per rendere operativa la Legge morale occorre misurare in termini monetari i danni e i benefici sociali connessi all’attività d’impresa. È l’idea di ricontabilizzare l’economia incorporando nei bilanci, previa monetizzazione, benefici e costi sociali che oggi ne rimangono fuori. Dacrema, nel suo saggio conclusivo, coglie bene l’ambivalenza: I fallimenti del capitalismo demitizza il denaro come feticcio, ma poi deve affidarsi proprio al denaro – alla sua capacità di misurare – per definire che cosa sia un profitto “giusto”.
Un secondo blocco di obiezioni riguarda le attuali caratteristiche del capitalismo, ancora globale e aperto, nonostante i dazi di Trump, e tuttora caratterizzato, almeno in alcuni paesi, da ampi spazi di libertà per gli imprenditori.
Mayer concentra la sua proposta sulla “società per azioni” e sul diritto societario che la disciplina. Ma le attività economiche possono essere organizzate in molte forme: ditte individuali, partnership, veicoli ibridi: forme di organizzazione dell’impresa che sfuggono in tutto o in parte alle regole pensate per le società per azioni. In un mondo in cui è relativamente facile scegliere tra forme giuridiche diverse, caricare solo la corporation di doveri ulteriori rischia di spostare semplicemente attività e profitti verso altre forme giuridiche.
Lo stesso vale a maggior ragione su scala internazionale. Mayer è consapevole che la sua interpretazione della section 172 ha senso solo se diventa la regola ovunque: se un paese obbliga le imprese a internalizzare tutte le esternalità negative, a pagare salari più alti del minimo competitivo, a rinunciare a profitti “tossici”, mentre i concorrenti che operano in altre giurisdizioni non devono fare altrettanto, la Legge morale smette di essere compatibile con gli incentivi: diventa un handicap competitivo. La risposta del libro – più che altro affidata all’ottimismo della volontà – è che, prima o poi, anche gli altri paesi si adegueranno.
Non lo si può escludere del tutto. La storia della regolazione ci racconta anche momenti di convergenza virtuosa. Ma è difficile non notare l’asimmetria: servirebbe una governance alla danese (Mayer guarda con grande ammirazione al modello scandinavo) in un mondo i cui motori economici sono sempre di più a Silicon Valley, con i suoi predatori amorali, e a Shenzhen, con il (per noi) distopico collettivismo aziendale delle imprese cinesi popolarizzato dalla docuserie American Factory.
Tutto questo significa che I fallimenti del capitalismo è un libro ingenuo? Al contrario. È un libro deliberatamente deontico, che sceglie di esporsi alle obiezioni pur di spingere il dibattito pubblico a immaginare un capitalismo migliore.
Il suo merito principale è di riformulare in modo semplice una domanda la cui risposta si tende a dare per scontata sia da chi ragiona in termini di creazione di valore per gli azionisti senza interrogarsi sulle storture che ne derivano sia da chi, viceversa, rifiuta in toto l’idea che il capitalismo è il peggiore sistema economico possibile, ad eccezione di tutti gli altri: a che cosa servono le imprese? Non “che cosa producono?”, non “quanto valgono in Borsa?”, ma perché sono indispensabili? Come possono anche meglio contribuire ad accrescere il benessere collettivo?
Resta il dubbio, serio, che la sua Legge morale non sia “compatibile con gli incentivi”; che non si possa imporre sulla scena del mondo. Ma è un dubbio che il libro non nasconde, anzi assume come sfida: come fare in modo che le norme, giuridiche e sociali, spingano le imprese a guadagnare solo risolvendo problemi, senza offrir loro scorciatoie profittevoli attraverso la lesione degli interessi altrui?
Che si condivida o meno la risposta, quello di Mayer è uno di quei rari libri scritti da un grande accademico che si possono consigliare a chiunque voglia capire perché il capitalismo, oggi, è sia insostituibile sia prono ai fallimenti – e come potremmo, almeno in teoria, aggiustarlo. Che lo si legga con il piacere con cui si sfoglia un saggio letterario, e non un manuale di finanza, è quasi una piccola applicazione della sua Legge morale: è un libro che lascia al lettore più stimoli e idee per trovare soluzioni ai problemi del capitalismo che ragioni per disperare delle sue sorti.