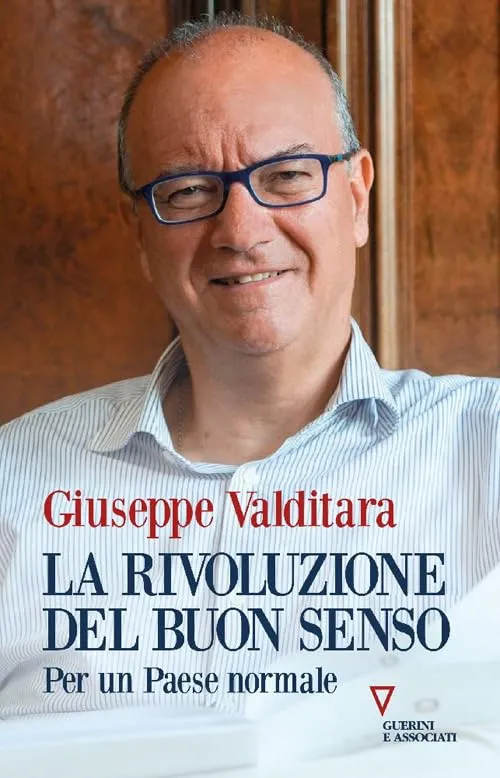Valditara: un sovranista all’Istruzione
In La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista Pierre Dardot e Christian Laval sostengono che sovranismo e neoliberismo non siano in opposizione: governance globale e istituzioni stato-nazionali sono le due facce del governo del capitale, dei mercati, dei flussi di merci. Tutto questo trova conferma nelle idee elaborate dall'attuale ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara: Sovranismo. Una speranza per la democrazia (2017), La scuola dei talenti (2024) e La rivoluzione del buon senso (2025) delineano il ruolo di un intellettuale impegnato nella costruzione di una piattaforma valoriale sovranista capace di aggregare le diverse sensibilità delle destre di governo anche attraverso coerenti politiche scolastiche complessivamente neoliberali e sovraniste.
Valditara è ordinario di diritto privato e diritto pubblico romano presso l’università di Torino. Come egli stesso racconta in La scuola dei talenti all'età di trent’anni è stato “folgorato” da Gianfranco Miglio, entrando nel 1993 nel consiglio direttivo della sua Fondazione Salvadori e partecipando alla stesura della Costituzione Federale approvata al congresso di Assago. Nelle file di An e poi del PdL, matura tre legislature parlamentari (dal 2001 al 2013). È con Gianfranco Fini in Futuro e Libertà quando questi rompe con Silvio Berlusconi per dare vita a “una destra moderna, che andasse oltre il berlusconismo: i conservatori inglesi, i gollisti francesi, Aznar”. Deluso, si riavvicina alla Lega e inizia a collaborare con Salvini nel 2014. Attivo organizzatore di cultura, negli anni seguenti fonda Logos e Lettera 150, spazio critico nei confronti delle attuali classi politiche volto a promuovere – per il dopo COVID-19 – “il rilancio della nazione che amiamo” attraverso la centralità del binomio competenza e merito. Nel 2022 pubblica presso Piemme, con Alessandro Amadori, È l'Italia che vogliamo. Manifesto della Lega per governare il paese, le cui considerazioni sulla scuola sono poi riprese dal programma elettorale del 2022.
La sua nomina al ministero dell’Istruzione non è sembrata controversa. Viene presentato come tecnico in quanto relatore di maggioranza della (contestata) riforma Gelmini dell’università (Legge 240/2010), “strumento per superare la decadenza del sistema universitario” come scrive in un appassionato articolo di difesa del provvedimento. Capo di dipartimento per la formazione e la ricerca al Ministero per l’Istruzione e Università nel 2018 con il ministro Bussetti nel governo Conte I, si muove a suo agio tanto negli ambienti del cattolicesimo conservatore, essendo Preside della facoltà di giurisprudenza dal 2005-2012 presso l'università europea di Roma, fondata anni prima dalla congregazione religiosa dei Legionari di Cristo, quanto negli ambienti economici, come certifica la posizione di eminent advisor presso l’associazione TreeLLLe, think tank sull’istruzione e sulla formazione vicina a Confindustria. Possiede dunque una navigata esperienza politica, conosce le burocrazie ministeriali, ha reti di relazioni importanti, si presenta come intellettuale conservatore con pedigree accademico. Chiosa Il Foglio: il professore potrà dal MIUR “condurre la sua battaglia sovranista” contro il “globalismo”.
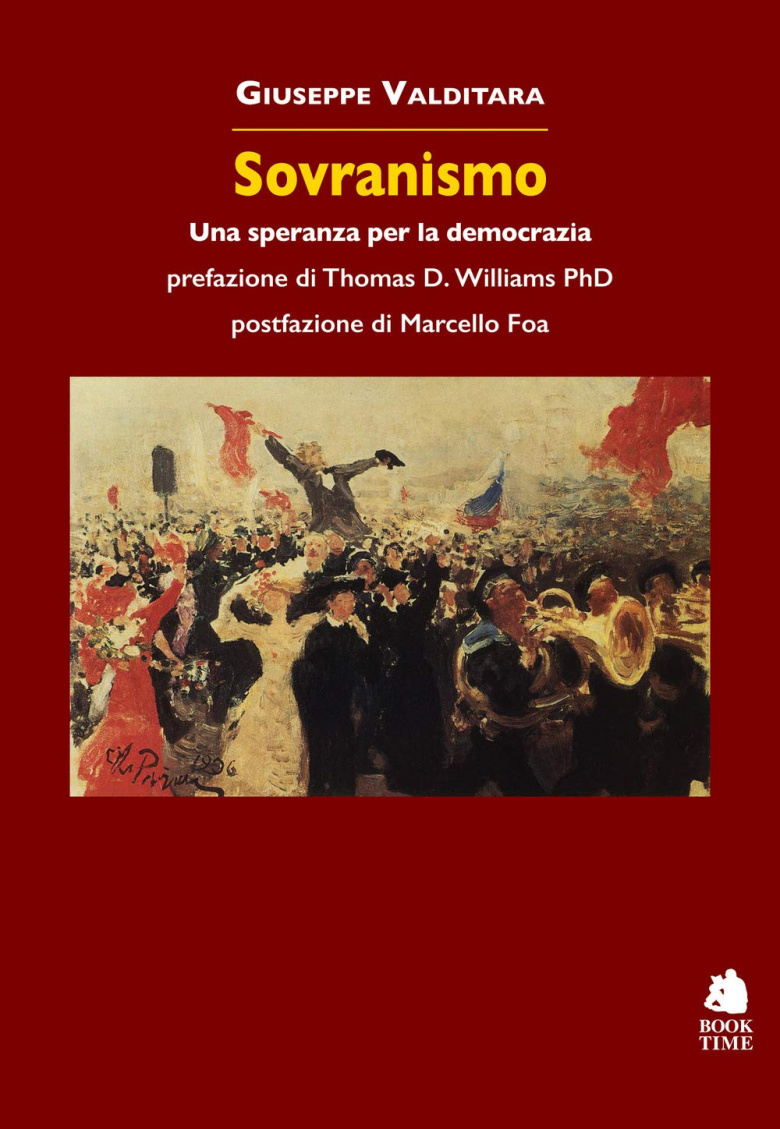
Un sovranismo eterno
Il concetto di sovranismo nasce in Quebec, dove i souverainistes sostengono una forma di larga autonomia da Ottawa, e passa poi in Francia negli anni Novanta dove si assiste a una sua ri-semantizzazione in cui prevale la polemica contro gli effetti dell’integrazione europea e la perdita di competenze dello Stato-nazionale. Le destre italiane se ne impadroniscono con una quindicina d’anni di ritardo. Tra il 2017 e 2019 vengono pubblicati diversi libri sul tema: il già citato testo di Valditara, Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale (2018) di Alessandro Somma e Sovranismo. Le radici e il progetto (2019) di Gianni Alemanno. Il concetto – osserva Marcello Veneziani – sembra essere capace di unificare le varie ramificazioni delle destre europee e internazionali da Orban a Salvini, da Meloni a Trump. Che il testo di Valditara abbia il timing corretto lo si deduce anche da chi ne scrive la prefazione: Thomas D. William, teologo e giornalista, ma soprattutto all’epoca direttore di Breitbart Italia il cui sito fino al gennaio del 2018 era diretto da Steve Bannon, stratega del movimento politico MAGA (Make American Great Again). Contiene un elemento di verità l’icastica osservazione di David Allegranti sul Foglio: lo scopo del libro è quello di fornire “un pensiero a Matteo Salvini”, una “sovrastruttura teorica a chi si fa i selfie a Milano Marittima impegnato a twittare su qualunque argomento”.
Veniamo ai punti qualificanti di Sovranismo. Vi si legge che per contrastare la pulsione autodistruttiva dell’Occidente è necessaria una rivoluzione identitaria, mondiale, “non contro qualcuno ma per qualcuno e per qualcosa: è la rivoluzione che rivendica il rispetto dell’identità di ciascun popolo contro lo sradicamento e l’alienazione del globalismo”. Il sovranismo “se correttamente inteso e intelligentemente espresso [...] non è la base di un superato nazionalismo, ma coinvolge l’essenza stessa della democrazia” in quanto cultura politica capace di riattivare la sovranità popolare. Infatti alle radici del sovranismo vi è “l’eterno conflitto tra chiusure oligarchiche e istanze democratiche, tra élites, e i loro clienti, da una parte, e i ceti popolari dall’altra”. Di tale conflitto sarebbe già espressione la Legge delle dodici Tavole prima norma che – a detta dell’autore – attribuisce alla volontà popolare la fonte del potere politico. L’opera non presenta particolari elementi di novità rispetto alle retoriche populiste o a tematiche tipiche delle destre radicali transnazionali recentemente oggetto di un’imponente indagine. Ha un debito intellettuale nei confronti di George Scruton, Alain Finkielkraut, Giulio Tremonti. Ampio spazio trova l’immigrazione, “il problema numero uno per gli Stati a economia avanzata”. Qui la polemica prevale sull’analisi, Valditara denuncia Open society di George Soros, seguendo un tropo tipico delle retoriche antisemite contemporanee; critica l’Onu colpevole di voler regolare i fenomeni migratori fino a prospettare una “immigrazione sostitutiva” con cui colmare il calo demografico europeo; contrasta le politiche di accoglienza UE fondate sulla propaganda terzomondista che “ha utilizzato il colonialismo come arma di pressione psicologica per colpevolizzare, quindi per indebolire la coscienza e l'identità europea”. L’estensione temporale della categoria concettuale di sovranismo comporta sia una perdita di potere esplicativo della stessa sia l’uso della storia come deposito di esempi virtuosi da insegnare in quanto emotivamente coinvolgenti: l’eroismo “dei giovani soldati italiani nella battaglia degli Amba Alagi” (1895) per i quali “la menzogna, l’inganno, la viltà, la furberia, la slealtà erano difetti spregevoli”. In particolare è la romanità (coerentemente con gli studi dell’autore) elogiata per la cura della propria identità culturale, per la capacità di risolvere – fino a un certo punto – l’integrazione\l’assimilazione dei conquistati. L’Occidente diviene categoria analitica escludente: Gerusalemme, Atene, Roma (Noi) e gli Altri.
La scuola dei talenti
Il libro, articolato in 16 capitoli, intende spiegare quali siano i principi culturali che hanno animato le scelte di politica scolastica del governo, illustrare alcuni provvedimenti appena emanati o in corso, riflettere sullo stato dell’istruzione in Italia. L’opera attinge a una pedagogia personalistica, di stampo cattolico, che ha nel consulente ministeriale Giuseppe Bertagna il principale promotore. La scuola costituzionale, si legge, è quella che mette al centro la persona dello studente, che cioè è al servizio per realizzarne al meglio i talenti”. Per fare questo deve adottare strategie volte alla personalizzazione degli apprendimenti: è necessario passare da “istruire tutti nello stesso modo” a “educare secondo il potenziale di ciascuno”, dall'uguaglianza del livello di istruzione alla pari opportunità nel ricevere la migliore educazione”. Il lessico richiama l’esperienza Gelmini. Di qui l’enfasi sulla non coincidenza tra pubblico e statale, una più significativa presenza delle imprese nel mondo della formazione, l’uso di termini vaghi, prescrittivi ma estremamente seducenti quali talento, merito e impegno.
Mettiamo a fuoco quest’ultima triade. Occorre, innanzitutto dire, che nella storia della normativa scolastica l’espressione “valorizzazione del\i talento\i appare a partire dal 2009, ma poi diventa centrale con la cosiddetta Buona scuola del governo Renzi, segno che le politiche neoliberali precedono (e di gran lunga) questo governo. Nel volume non è presente una definizione specifica di 'talento', dall’impianto complessivo si ricava che è tanto una dotazione cognitiva (il riferimento è alle intelligenze multiple di Gardner) quanto un saper fare. L’autore sembra considerarlo come qualcosa di individuale, il che è perlomeno parziale dal momento che le ricerche pedagogiche e psicologiche mostrano come abbia anche una dimensione sociale (è la qualità dell’esperienza di apprendimento a determinare la sua maggiore o minore emersione; il dato socio-economico condiziona la disponibilità verso l’esperienza all’apprendimento).
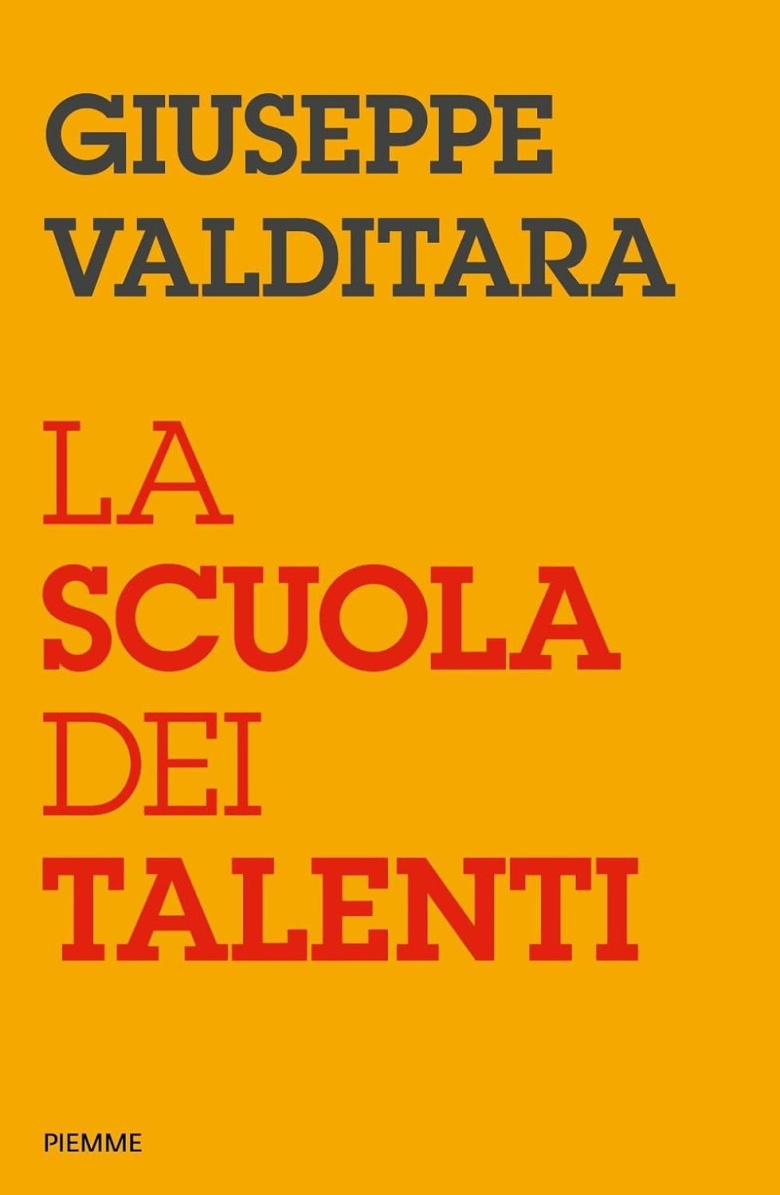
Il principale problema della retorica del talento è che naturalizza il merito e l’impegno dimenticando, ad esempio, che quest’ultimo non può essere un dato di partenza del discorso educativo ma semmai l’esito di un processo che tiene conto del peso dell’ambiente familiare nei confronti degli atteggiamenti verso il lavoro scolastico. E, nuovamente, non vi è alcun merito nell’essere nato in una famiglia sensibile verso la scuola e prodiga di incoraggiamenti. E nemmeno demerito in caso contrario. Nonostante Valditara ripeta che merito non significa eccellenza assoluta ma relativa (“il raggiungimento del meglio che ciascuno, con impegno e responsabilità può dare”) l’idea di scuola che si ricava dal testo, e dalle politiche attuate, rientra a pieno titolo in un paradigma meritocratico-puro. Date tali premesse non sorprende trovare apprezzamenti a testi quali Meritocrazia di Abravanel e Il danno scolastico di Ricolfi- Mastrocola. L’autore sostiene velatamente che il ‘facilismo educativo’ tipico della cultura scolastica progressista abbia prodotto immobilità sociale perché una scarsa qualità dell’offerta formativa penalizza soprattutto i figli delle famiglie a basso reddito. Su tale narrazione, diffusa anche tra chi lavora nell’istruzione, sono opportune due osservazioni. Giancola e Salmieri, in una densa e originale ricerca comparativa ricca di dati sulla povertà educativa, spiegano che alla base di tale ragionamento c’è una relazione causale invertita: la scuola riproduce (spesso amplifica, a fatica riduce) le disuguaglianze che si sono generate altrove. Non il contrario. Infine non è affatto dimostrato che la (presunta) scarsa qualità attuale dei sistemi educativi “sia dovuta agli approcci democratici che i critici della scuola attuale spacciano per permissivismo, zero disciplina e valutazioni di manica larga”. La mobilità sociale è scomparsa per ragioni interne alle attuali forme di capitalismo come ha spiegato Francesco Farina in Il merito tradito; numerosi studi internazionali dimostrano che la mobilità intergenerazionale dei redditi non è legata alla mobilità educativa (cioè il fatto che i figli abbiano titoli di studio più alti dei genitori). L’incentivo istruzione non funziona in società a forte disparità economica. Gli stessi dati proposti nel capitolo 4 ne sono una conferma.
Personalismo e individualismo
L’unione di personalismo cattolico e neoliberalismo è la cifra di molte pagine del libro così come di molte scelte attuali di politica scolastica. Con finezza lo ha chiarito Michele Dal Lago nell’opera collettanea Alfabeto della scuola democratica: “non c'è nessuna contraddizione tra valorizzazione della persona e meccanismi di mercato. Ma attenzione, non si tratta di creare una corrispondenza funzionalista tra scuola e apparato produttivo limitando le possibilità di scelta e di autorealizzazione del soggetto. Al contrario, il mercato è considerato esattamente come un mezzo per la realizzazione del ‘fine persona’”.
La scuola dei talenti discute di centralità del lavoro ma ne appiattisce la concezione sullo sbocco professionale” coerente con i propri talenti”. Segue una polemica contro la scuola gentiliana e gramsciana unite da un disprezzo per il sapere pratico; una difesa della riforma dell’istruzione tecnica e il potenziamento degli Istituti tecnici superiori (ITS) nella logica del 4+2 capace di rispondere al “grido di dolore di imprenditori piccoli, medi e grandi” che lamentano l’assenza di manodopera specializzata “sebbene gli stipendi per un ‘bravo saldatore’ possano arrivare a 4000 euro mensili netti, retribuzione che un laureato senza particolari competenze spesso si sogna”. Al di là del fatto che lo stipendio medio per un saldatore risulta di 1500 euro, il sottotesto del ragionamento è una curvatura dell’istruzione in funzione dell’occupabilità futura.
Personalismo cattolico e teoria del capitale umano, peraltro, rimuovono il tema delle disuguaglianze sociali come variabile esplicativa dei fenomeni educativi. La prima in quanto prospetta una società interclassista; la seconda poiché le riduce alla responsabilità individuale. Valditara, per esempio, analizza i dati della dispersione implicita a Milano e a Torino, cioè del mancato raggiungimento di competenze in linea con il grado di scuola. I dati Invalsi sugli apprendimenti gli documentano i ritardi delle periferie. Quali le cause? La presenza di un maggior numero di studenti stranieri di prima o seconda generazione. Nessuna riflessione sulla stratificazione sociale degli abitanti delle periferie; nessuna riflessione su un assetto normativo che, liberalizzando le iscrizioni scolastiche, ha prodotto effetti di segregazione scolastica (ricerca delle scuole del centro cittadino). Lasciata cadere è la riflessione sul legame (a Torino) tra dispersione e “disagio sociale legato a fattori di crisi endogena, probabilmente determinati dalla pesante deindustrializzazione subita dalla città”. Il problema che Valditara non vede o non vuole vedere si chiama trasmissione intergenerazionale della povertà educativa che, ad oggi, è marginale nell’agenda del Governo come ha osservato il Forum per le diseguaglianze e diversità. Enfatizza l’efficacia di alcuni provvedimenti presi dal governo come Agenda Sud e Piano Estate sui quali, però, occorre attendere azioni di monitoraggio. Sul secondo in particolare mi sembrano del tutto pertinenti le osservazioni critiche di Simonetta Fasoli.
Giuseppe Valditara ha lavorato e lavora per l'egemonia culturale attraverso la scuola perché essa è, tra le altre cose, un potente catalizzatore di senso comune (tutti parlano di scuola). Il destinatario dell’operazione è la “maggioranza morale” che rispetto alle sfide della società liquida vuole essere rassicurata. Si tratta di ripristinare “la naturalità, la normalità di certi valori e di certi principi nella società, partendo dalle scuole, dalle università, per finire nei tribunali e quindi nella cultura”. L’operazione in atto, dunque, salda elementi sovranisti e neo-identitari (Linee guida per l’educazione civica e le Indicazioni Nazionali per il curricolo Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione. analizzati qui e qui) a politiche dell'istruzione orientate alla promozione dell’eguaglianza delle opportunità educative in senso debole: nel libero mercato dell’istruzione occorre informare adeguatamente le famiglie per canalizzare i figli nella filiera educativa adeguata ai loro talenti. In tali termini va vista tutta la recente normativa sull’orientamento scolastico. Il merito è di fatto un concetto ideologico costruito per ‘ripulire’ un'allocazione del vantaggio che è fondamentalmente ingiusta. Sintetizza Mino Conte: “le istanze conservatrici e socialmente regressive, dunque ostili al progetto emancipativo della scuola democratica, possano benissimo essere perseguite anche sotto la copertura di rassicuranti ma insidiose insegne inclusive e innovatrici, con un effetto democratico solo di superficie (La scuola democratica e suoi nemici)”. Varrebbe la pena chiedersi se esiste un progetto di scuola alternativo altrettanto sistematico capace di ritornare a parlare di ristrutturazione dei cicli scolastici, biennio comune alle superiori, obbligo a 18 anni, eguaglianza dei risultati formativi e non solo delle opportunità.