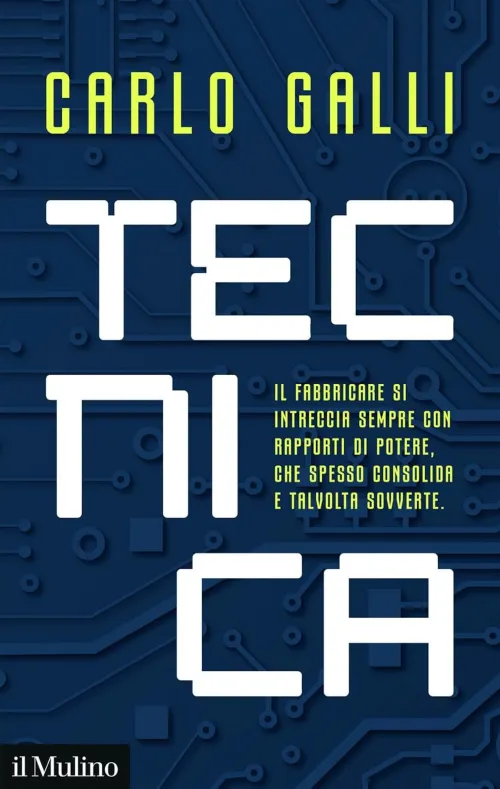Carlo Galli e il controllo della tecnica
La scienza scopre, l’industria applica, l’uomo si adegua – era il motto molto positivista à la Saint-Simon & Comte (industria e società sono sinonimi) dell’Esposizione Universale di Chicago del 1933. E da allora ad oggi le cose – il nostro rapporto con la scienza e con la tecnica – non sembrano cambiate, ci siamo adattati alla rivoluzione industriale, alla catena di montaggio, alla bomba atomica e ora ci adattiamo al digitale e all’intelligenza artificiale e alla crisi climatica.
Senza mai renderci conto che il nostro adeguarci a ciò che la scienza scopre e che la tecnica applica, nasconde anche, sotto il velo del progresso, una negazione concreta della libertà e della democrazia, una negazione del sapere aude! kantiano e illuministico, una rimozione della libertà, uguaglianza e fraternità della rivoluzione francese, dei principi del liberalismo e della democrazia e dello stato di diritto. Viviamo in un gigantesco deficit di democrazia, come scriveva Luciano Gallino, ma non lo vediamo né percepiamo; in realtà possiamo decidere di quasi tutto – in democrazia – ma mai su scienza tecnica e industria – cioè proprio su quei poteri che più intensamente e pervasivamente di ogni altro potere impattano sulla nostra vita (qualcuno dice: colonizzano la nostra vita).
E quindi, tornando alla citazione iniziale, qual è il nostro rapporto con la tecnica – tema e problema antico e mai davvero risolto? Davvero usiamo le macchine oppure ormai siamo usati dalle macchine (e dal capitale) e ci comportiamo come macchine, a discrezione delle macchine (e del capitale)? La tecnica (le macchine) è un mezzo oppure ormai è diventata (l’accrescimento dei sistemi tecnici) il fine unico per cui dobbiamo vivere e lavorare – in un drammatico rovesciamento tra fini e mezzi, con l’uomo non più fine (come dovrebbe sempre essere, e rimandiamo a Kant), ma mezzo per l’accrescimento ulteriore del sistema (da ultimo, noi che produciamo dati per addestrare l’IA e accrescere i profitti di OpenAI)? Forse perché, come scrive Carlo Galli, “non vi è cura per la tecnica, in quanto questa non è una malattia ma è il fare produttivo rivolto a una utilità concreta” – che da tempo però non sembra essere più una utilità per l’uomo (semmai il contrario, vedi crisi climatica) – e “la cura non può essere che la comprensione e la gestione della tecnica”, attraverso “una critica dialettica e genealogica”.
Ma qui le cose si complicano perché la tecnica, scrive sempre Galli, “se non piena di capricci teologici, come la merce secondo Marx, certamente [è] tanto elusiva quanto iperpresente, difficile da isolare e troppo facile da sovrarappresentare e da ontologizzare”; cioè “è infinitamente ambigua”, sì che serve per infiniti scopi (la sua strumentalità, appunto), “ma è anche portatrice di coazioni e quindi comanda; è agita e agisce; […] ma non è solo una protesi dell’essere umano: serve certamente a riempire quel vuoto originario che è l’uomo, ma è anche capace di svuotare, di nullificare la consistenza della persona”, tradotta appunto in numeri/dati. E ancora: “la tecnica è indispensabile, ma non è neutra” – e ci si divide tra tecnofobia e tecnolatria restando così “lontani da una sua “comprensione strutturale”, mentre “il senso comune non se ne fa un problema e la vive come naturale”, quasi con empatia (è facile familiarizzare con la tecnica – senza tecnologia l’uomo non sopravvive – ma è ancora più facile per l’industria, aggiungiamo, farci familiarizzare/adeguare con la tecnica/macchine che produce).
Da qui l’esigenza (l’urgenza diciamo) di un pensare criticamente alla tecnica (e se non è critico, il pensiero non è pensiero), che invece ci manca (quasi) del tutto. Noi continuiamo infatti a credere che la razionalità tecnica (oggi algoritmica) sia la vera e unica razionalità possibile perché basata su numeri e calcolo e calcolabilità di tutto e di tutti (a questo servono i dati, alla predizione/pianificazione dei nostri comportamenti – e nella “funzione predittiva della IA si mostra con la massima evidenza la tendenza del paradigma algoritmico a replicare il presente nel futuro, a eliminare ogni discontinuità”); essa però “non è tutta la ragione” (ancora Galli) e dovrebbe esserci una eccedenza di pensiero rispetto a questa razionalità, cioè un “pensiero che pensa quella ragione” strumentale, “che non se ne accontenta, che va oltre”, che critica la tecnica senza negarla, per riorientarla. Ne siamo capaci?
Sembrerebbe di no (chiosiamo e aggiungiamo) se chiamiamo intelligente l’IA, quando è solo (e ancora, ma sempre di più) industria ed è la nuova forma del vecchio taylorismo, un taylorismo cognitivo: sì che se Taylor espropriava i lavoratori di conoscenza e di esperienza per riassumerle in schemi e tabelle (la Direzione di fabbrica come detentrice della conoscenza), producendo un lavoro impoverito, standardizzato, di mera esecuzione, ma reso molto più efficiente e produttivo, l’IA (anche quella generativa) procede sostanzialmente allo stesso modo: si nutre (ci espropria) di dati, di conoscenza e di pensiero umano che trasforma e accentra/centralizza in algoritmi, chiamando tutto questo intelligenza: che si offre certo in forme sempre apparentemente diverse, ma sempre rimasticando ciò di cui è stata nutrita, quindi non creando pensiero nuovo e meno che meno pensiero critico, piuttosto riproducendo lo status quo. E quindi, così come è impossibile definire intelligente il taylorismo (per la contraddizione che non lo consente), altrettanto dovremmo fare con l’IA, perché anch’essa serve soprattutto ad aumentare la nostra produttività (Sam Altman) per il capitale; perché i dati – riprendiamo Galli – “sono estratti forzosamente […] ed espropriati da grandi e voraci megasoggetti economici, per i quali i dati sono una sorta di res nullius, a disposizione di chi li scopre e se ne impossessa” e non invece, come sono e come dovrebbero essere, la nostra vita intera come soggetti, quindi inappropriabile e non mercificabile. Ed è sempre, ma di più, capitalismo estrattivo – che considera il mondo e l’uomo come miniera da sfruttare. E noi ci adeguiamo.
Ma non è surreale vivere in una società ipertecnologizzata e però non sapere nulla di come questa società funziona e di come noi, adeguandoci, la facciamo funzionare? Una domanda ulteriore, questa, che ci fa entrare ancora meglio in un libro prezioso per provare a risolvere il nostro totale disallineamento cognitivo (come individui e come società) al procedere della tecnica (e del capitalismo) e dell’ontologia che la pre-determina e insieme produce l’incantesimo della tecnica. Un libro che dovrebbe essere letto e meditato soprattutto dai cosiddetti nativi digitali, che credono di usare questa tecnica ma che ne vengono usati e soprattutto formattati a credere che vero sia solo che appare sullo schermo. Il titolo è Tecnica; il suo autore è il già citato Carlo Galli, filosofo della politica che ha insegnato Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna; editore è il Mulino (a cui rivolgiamo un personalissimo consiglio: evitare per il futuro quelle lugubri e inquietanti pagine nere che dividono un capitolo dal successivo), nella Collana Contemporanea e al prezzo di copertina di € 16,00.

Un libro che “ha l’obiettivo di precisare il profilo di ciò che va criticato perché se ne tenti l’emancipazione [e sottolineiamo emancipazione]. Di fornire metodi ed elementi per una critica della tecnica che sia una critica della società e del suo dinamismo: che è il dinamismo del potere, del controllo, del profitto e del conflitto, che la tecnica potenzia e legittima coprendo con una patina di razionalità l’irrazionalità dei fini, ponendosi come autorità immanente, imparziale, oggettiva” – ciò che invece non è ma che tuttavia “detta l’agenda dell’avvenire: una pretesa di cambiamento perenne” che in realtà non cambia nulla (siamo sempre dentro alla e formattati dalla rivoluzione industriale e dalle esigenze del capitale), se non la potenza del potere tecnico. Ovvero (Galli), “se la digitalizzazione della società è una rivoluzione, è una rivoluzione dall’alto” – e rimandiamo alle nostre riflessioni iniziali – “una rivoluzione del potere economico e/o di quello politico che si garantiscono una presa potentissima sulla società e sui singoli individui”, più o meno “spontaneamente catturati, misurati, valutati in ogni ambito della vita – pubblico e privato, interiore ed esteriore”.
Un libro che nei suoi primi capitoli riflette sul problema della tecnica portandoci poi a conoscere chi ha pensato filosoficamente nel passato anche recentissimo, criticamente o entusiasticamente, alla tecnica. Partendo da Talos dell’antica Grecia (“un automa costruito da un fabbro divino”), passando per Platone e la techne, per la trappola per topi del mago Wiz e poi a Bacone (Francesco ma anche il meno noto Ruggero, vissuto nel XIII secolo), a Cartesio, al positivismo industrialista di Saint-Simon, a Leopardi, a Marx, a Nietzsche, alla dismisura connaturata alla modernità e alla sua tecnica, alla tecnica come arché; e poi al Gestell heideggeriano, alla Scuola di Francoforte, alla megamacchina di Anders, Mumford o Latouche – posto che sempre meno esistono macchine singole nella libera disposizione di chi le usa, e sempre più macchine che convergono, per loro essenza, in macchine sempre più grandi e integrate e con uomini sempre più integrati ed eterodiretti da tali macchine e dalla razionalità strumentale, una megamacchina che per Galli, con il digitale, diventa una metamacchina astratta che muove però macchine concrete (e uomini); e poi arrivando a ingegneri che prendono il posto dei filosofi nel capitalismo industriale, a Taylor e a Ford e alla catena di montaggio, ai fratelli Jünger (non solo Ernst ma anche Friedrich Georg) e poi a Wiener e la cibernetica (ma anche Heidegger), a Turing e poi a Simondon e Stiegler e a Emanuele Severino e ad altro ancora, compresa l’ideologia californiana e il transumanesimo. Capitoli genealogici – per arrivare all’intelligenza artificiale.
Perché con il digitale tutto sembra cambiare, ma è appunto sempre industrialismo capitalistico, con però un di più di sfruttamento dell’uomo (e della biosfera e l’IA è energivora alla massima potenza): perché se “la società automatizzata era costituita da macchine che sostituivano la mano dell’uomo, la sua fisicità, ora la svolta digitale va verso la sostituzione anche del cervello umano”. E nella società digitalizzata, “l’accesso alla vita sociale può avvenire solo se tutta la vita è trasformata in dati” – così appunto desoggettivizzandoci e da persone diventando numeri. E “nulla è fattibile se non ci si assoggetta alla codificazione della materia in dati processabili” – vero, sempre più vero, rimandandoci alla Scuola di Francoforte che paventava il rischio di arrivare a una società total(itaria)mente automatizzata e amministrata da macchine.
Ne nasce – Galli – “un gigantesco automa diffuso, un formicaio elettronico” – a cui si applica ancora meglio il concetto/processo jüngeriano della mobilitazione totale industriale, “mentre il sistema digitale […] si muove spontaneamente per accrescersi, e così satura la società intera con infinite operazioni di profilazione, catalogazione, valutazione, controllo, governo, riproducendo, complessivamente, il reale […], con una rappresentazione granulare e sempre più cangiante”, ma soprattutto pervasiva e sussumente, “con la connessione di tutti con tutti e con tutto”. Così producendosi “un appiattimento digitale, un marcusiano mondo a una dimensione”, mediato e favorito da una passività individualistica attivata da “un continuo invito mediatico a disertare la dimensione pubblica”, cioè la partecipazione attiva alla polis.
Cancellando ogni soggettività (anche se offrendola come massima libertà e massima soggettivazione), rimuovendo ogni pensiero critico in nome della ripetizione, della standardizzazione, della conformazione – ancora il taylorismo, ancora la tecnica e il capitale: che temono (come nessuna altra cosa) il pensiero critico e la conoscenza/sapere e l’autonomia e la libertà dell’uomo e quindi preferiscono accentrare tutto in macchine/algoritmi: perché anche la società digitale rifiuta e nega che “il soggetto [ciascuno di noi] sia capace di progetto e sia portatore di autonoma attività”. E quindi non può che prodursi anche la scomparsa “della convinzione che sia l’uomo a costruire un mondo di cui abbia piena comprensione e responsabilità” – meglio le macchine, appunto, meglio l’IA. E dunque la società digitalizzata “è intrinsecamente squilibrata, a vantaggio di oligarchie che disperdono i rischi nell’intera società mentre si appropriano integralmente dei benefici – dei profitti e del potere”. E noi ci adeguiamo a questo nuovo/vecchio “rapporto di dominio”, “del quale i dati sono le matrici”.
E allora chiudiamo questa recensione-non-recensione al suo libro, con Galli che ci ricorda una cosa fondamentale: che “la macchina non pensa come l’uomo […] perché a tal fine non basta rispondere a domande utilizzando formulari raccolti da miliardi di dati trattati statisticamente: il pensiero umano è situato, orientato, potenzialmente originale, e quindi potenzialmente critico […] – e la sorpresa, lo stupore, non sono una fallacia [come invece pensava Alan Turing, padre, guarda caso, dell’IA], ma è l’inizio del filosofare”, cioè del pensare. Da qui anche l’urgenza di recuperare la politica, che però “deve smarcarsi dalla tecnica”, diventata a sua volta politica, tornando a pensare ai fini e non solo ai mezzi.
Eppure, oggi tutti vogliono l’IA (“la cui vittima più evidente è la Verità” – “se tutto è possibile, tutto si equivale”), senza vedere che essa (Galli) “si presenta come un dogma in cui credere, qualunque cosa elabori e mostri”. Ma i dogmi – dovremmo saperlo – sono la negazione del pensiero.