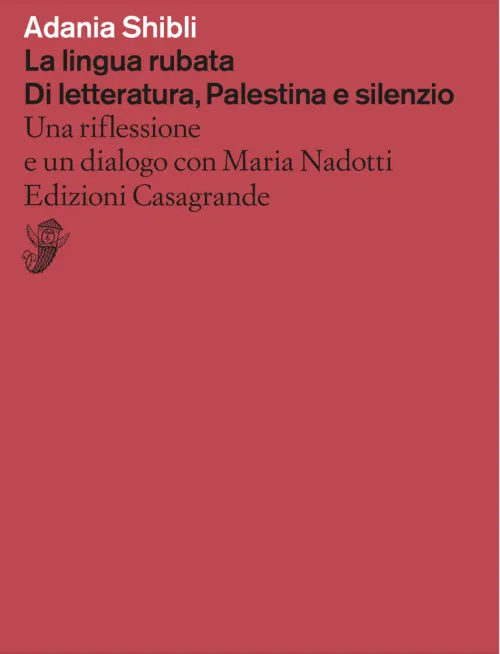Adania Shibli: Palestina e silenzio
Le parole sono svanite, mi hanno abbandonata. Non riesco più a parlare con nessuno. Adania Shibli, scrittrice nata in Palestina, comincia così la sua riflessione in La lingua rubata (Casagrande, 2025), un breve e intensissimo libro impreziosito dalla prefazione di Maria Nadotti e da una loro mirabile conversazione.
Quand’è che si ruba una lingua? Chi o cosa fa sentire derubati della propria capacità di esprimere quello che si sente, di raccontare quello che accade, quello che di terribile si ha davanti agli occhi, e alla fine dentro la testa, in ogni parte del corpo?
Di sicuro l’angoscia paralizza, quando si ha l’animo rotto da troppa violenza vista e subita, quando segnali di distruzione e morte arrivano ogni giorno senza saltarne uno, tra uccisioni, umiliazioni continue, separazioni forzate e relazioni interrotte. Quando i corpi vengono affamati, feriti, assassinati brutalmente, si resta muti.
Quando soffriamo davvero molto la prima cosa che perdiamo è il linguaggio, dice Shibli. Il suo silenzio è un silenzio che segue il dolore. Sono cresciuta in una casa in cui non si parlava, sono cresciuta nel silenzio, i miei avevano quindici anni quando è cominciata la Nakba e hanno visto coi loro occhi la distruzione della Palestina… gli sono venute meno le parole per raccontare. Cosa puoi raccontare quando assisti a un disastro, a una devastazione? Quali sono le parole del disastro? Finiscono per cadere a terra come le case, come i corpi, cadono morte anche loro?
Eppure. C’è anche qualcos’altro. Chi scrive è figura ingombrante, dice Maria Nadotti, lo è quando rivela, quando dice la verità, quando smaschera il potere con le sue narrazioni menzognere, quando svela e magari dileggia chi confonde il potere con la sua volontà di dominio.
Zittire chi scrive con questa postura può diventare necessario per chi voglia affermare un discorso che si autolegittimi attraverso non-verità, toni arroganti, presunzione di sapere e tanta, tanta fame narcisistica di supremazia mediatica e quindi, ormai, politica.
Ecco che quindi ammutolirsi coincide con l’essere zittiti, fa parte della logica suprematista, è un punto cruciale del piano di chi vuole avere ragione sulle contraddizioni, sulle incertezze, sui dubbi e quindi sui desideri. Non occorre che sia intelligentissimo o coltissimo, chiunque voglia zittire; anzi, l’ignoranza è dalla sua parte, con la sua inclinazione naturale alla semplificazione, il suo innato gusto per il ragionamento binario, la capacità miracolosa di deresponsabilizzarsi, di discolparsi recitando la formula magica del vittimismo che tutto ribalta, che tutto il male fatto lo ritorce contro l’altro.

Chi zittisce è solitamente divertente, un po’ pazzo, incoerente, fasullo, un bugiardo patologico, uno con tanti amici, tutti belli e buoni finché gli servono e lo esaltano, un opportunista che ti fa fuori subito dopo averti accarezzato, un narcisista, e quindi un insicuro travestito da sicuro di sé, un salvatore che ti uccide salvandoti la vita. Chi zittisce ti lascia senza parole, perché si è messo lì a togliere di mezzo il loro valore condiviso, storico, politico, sociale, magari anche esistenziale. E allora è questo, anche, che zittisce, ammutolisce, toglie parola oltre che fiato. L’annullamento, l’azzeramento o anche solo il distorcimento di quel che serve a definire la realtà, a raccontarla, a immaginarla, a smontarla e ridarle significato. La fabbricazione politica e mediatica di parole che non lasciano spazio al confronto, alla smentita, al dubbio, alla negazione, perfino alla ragione. Come si fa a parlare dopo qualcuno che dipinge un mondo che non c’è, che racconta di violenza brutalità fame distruzione assassinio dicendo pace bellezza eternità bontà costruzione accordo mediazione lavoro, anzi, buon lavoro? Come si fa a non restare ammutoliti se per dire opportunità per tutti dice, con il denaro non c’è niente che non si possa costruire? È il discorso di chi mentre parla di libertà di parola censura, mentre parla di libertà di pensiero licenzia, caccia, imprigiona, di chi mentre parla di democrazia costruisce un regime. Non è che non abbiamo esempi a portata di mano. È il discorso di chi fa sembrare vera la realtà della bolla in cui ti ha messo.
Chiamiamola pure propaganda, non è difficile riconoscerla, e potremmo dire che non è la prima volta che imbambola le masse, e che occupa lo spazio mediatico e politico, e mette a tacere con la forza, con il ricatto, con la violenza. Quello che c’è forse di nuovo, è che siamo forse più tristi, più bisognosi di non pensarci, meno arrabbiati, più ignoranti, meno amanti della libertà? Non so. Di sicuro, siamo più addolorati, siamo pieni di dolore, e ci vogliono così, non vedono l’ora, quelli col potere di zittire, non ci vogliono certo felici, e appassionati di realtà. Perché per muoversi ci vuole un po’ di affetto, quindi un po’ di gioia.
Che in Europa, ma nel mondo, si muovano le piazze, è un fatto. Che si muovano finalmente gridando parole solidali con un popolo sfinito di anni, non due, ottanta, di occupazione, colonialismo, ingiustizia deliberata. E che siano piazze anch’esse da zittire è un fatto, inchiodare al muro dell’inutilità, della vanità, da parte di chi temendole le sminuisce, di governi che preferiscono svilirne il valore politico per non doversi interrogare e soprattutto ammettere che non le avevano previste, addormentate come le credevano, avvilite e spente dopo anni di mistificazione del discorso politico.
Ci vuole resistenza, e invenzione, perché quel fatto andato storto che è la politica, come diceva Hannah Arendt, non si opponga con tutte le sue forze alla voglia di stare lì con il proprio corpo insieme ad altri corpi, contro tutto il disastro di politiche fatte per il bene di pochi, per il benessere di alcuni.
Il silenzio è uguale morte, titolava Maria Nadotti un suo libro, l’indifferenza è complicità, la non-verità passata per verità dai media prima ancora che dalle istituzioni è una forma di asservimento: la bugia ripetuta mille volte è più credibile della verità detta una volta sola.
La letteratura per me è stata un terreno etico fin dall’infanzia. In arabo, la parola per indicare la letteratura e l’etica è la stessa: Adab, ricorda Adania Shibli. Ecco, che sia questo l’esercizio da fare, scrivere pensando che la scrittura ha un’etica da rispettare, che etica e politica stanno insieme, che certe parole non le si può pronunciare slegandole dal loro valore etico, che certe parole bisogna amarle, volerle sentire usate con responsabilità e chiarezza da chi governa, e soprattutto da chi scrive, ovunque scriva, volendo parlare di ciò che accade al mondo. Chiarezza, sì, come diceva John Berger accettando e allo stesso tempo facendo a pezzi il Booker Prize dividendo il premio in denaro con il Movimento londinese delle Pantere Nere: per finire come anche per cominciare, dice Berger, la chiarezza è più importante del denaro.
Leggi anche:
Maria Nadotti | Adania Shibli, una storia di violenza dissepolta
Maria Nadotti | Ascoltare la Palestina. Babel: Festival di letteratura e traduzione