Menopausa tabù
«Sarò onesta, questa è la fase migliore della vita. […] sento di avere ancora 25 anni». A 56 anni suonati, la famosa cantante, attrice, imprenditrice e molte altre cose ancora, rilasciava poche settimane fa, a un rotocalco italiano, un’autocertificazione di buona, anzi, di ottima salute. Il tempo per lei non era passato, congelandosi al contrario in un eterno presente, quello dei suoi 25 anni. Gli ultimi tre decenni risultavano così solo all’anagrafe: spariti, volatilizzati, senza lasciare tracce sul suo corpo e, presumibilmente, neppure nel suo spirito. Con alle spalle quattro matrimoni – di cui due con lo stesso uomo, Liz docet -, due figli, 9 album musicali, all’incirca una quarantina di film, tralasciando tutto il presumibile investimento emotivo, la patinatissima Jennifer Lopez dichiarava tranquillamente di sentirsi ancora la venticinquenne di trentun anni fa. Confesso che leggere i toni tranquilli dell’ammissione di una simile débâcle mi aveva un pochino sconcertata: per Jennifer Lopez la vita era trascorsa inutilmente, senza lasciarle niente. Tutto sommato, l’aveva presa bene. Pensai a tutta la letteratura femminista letta e discussa, e d’improvviso le parole di Simone de Beauvoir, per la quale donna non si nasce ma si diventa, non avevano più nessun significato: essere donna non era più un’esperienza, non era il viaggio empatico attraverso tappe a volte sofferte, altre di liberazione, per esempio dal tempo lineare della società patriarcale. Nelle primissime righe del suo saggio La donna è mobile. Filosofia della menopausa (Einaudi, 2025), Gloria Origgi, filosofa italiana di stanza a Parigi dove è direttrice di ricerca al CNRS, si chiede se una donna in menopausa sia ancora una donna, ossia se resti tale anche dopo aver attraversato, con la scomparsa quasi totale degli estrogeni, uno dei più potenti e turbolenti cambiamenti che modifica per sempre corpo, mente ed emotività femminili. Una delle risposte arriverà verso la fine del libro, dopo aver accompagnato il lettore (o forse solo le lettrici, e questo è un altro problema della menopausa) in un travolgente excursus medico, filosofico, psicologico, finanche endocrinologico: “oggi, a cinquantotto anni, mi sento più donna che a venti”, con buona pace della cara Jennifer. È noto come nella vita (di una donna) gli avvenimenti che veramente contano e trasformano non sono tanti. Infatti, l’organismo, regolato da un efficiente principio omeostatico, risponde a ogni minaccia con reazioni atte a riportare in un equilibrio rassicurante l’intero sistema, investendo così la maggior parte delle sue energie. All’aggressione si reagisce cercando di ripristinare al più presto sicurezza, protezione, abitudini. La menopausa rompe il cerchio della donna che collassa su se stesso con la conseguente perdita della routine per circa dieci anni, questo è grossomodo il tempo che ci mette a consumarsi la perimenopausa, termine introdotto solo nel XIX secolo, a indicare la fase più profonda e radicale nella vita femminile. Oggi da più fronti, se pur timidamente, viene messa in discussione l’equivalenza di climaterio e vecchiaia, almeno per la nostra cultura. Detrito dopo detrito, la menopausa sta lentamente uscendo dall’oscuro antro del tabù della “donna scaduta” e della superstizione, di cui le stesse interessate parlano ancora poco e con vergogna, scisse tra la tacita adesione a una precoce vecchiaia, con conseguenti ingiustizie sociali per esempio sul lavoro, o a forme di estremo giovanilismo.
Recentemente leggevo Il coraggio di parlarne. Tutto quello che avrei voluto sapere sulla menopausa (2025) dell’attrice Naomi Watts. Confesso che mi aveva stupito che una giovane donna molto in vista, stimata attrice amata da alcuni tra i più importanti registi degli ultimi decenni, avesse trovato il coraggio di parlare a cuore aperto e di raccontare il suo sgomento di fronte a una precocissima diagnosi di perimenopausa… Ho smesso di scrivere, riletta la riga precedente, ho resistito alla tentazione di cancellare col tasto della tastiera Canc la parola ‘coraggio’. Perché mai mi è venuto spontaneo usarla, col rischio di ripetermi rispetto al titolo del libro (peccato spesso imperdonabile nell’ambiente di chi scrive per professione) e, soprattutto, di sottolineare l’ardire della scelta di trattare pubblicamente un tema così drammatico per una giovane donna? Che fossi anche io complice, in qualche modo, dell’omertà intorno all’argomento, usando male le parole (secondo peccato capitale, vedi sopra)? Naomi Watts ha descritto senza veli le sue paure rispetto alla possibilità che vedeva allontanarsi di formare una famiglia, delle conseguenze nel lavoro. Le sue non erano preoccupazioni infondate: nel mondo del cinema l’età delle attrici è da sempre un temibile buco nero, all’origine di episodi a dir poco grotteschi. Solo per citare qualche episodio: nel 1967, all’uscita di Il laureato (The Graduate), i due attori principali avevano, nell’ordine, Dustin Hoffman 30 anni e Anne Bancroft 36. Con sei anni di differenza, alla Bancroft era toccata in sorte la parte di una fascinosissima coetanea della madre del neo dottorino che avrebbe sedotto con appena due dita infilate in un collant (per inciso, Katharine Ross ne aveva 27 di anni e chi ha visto il film sa di cosa sto parlando). Pochi anni prima era uscito Va' e uccidi (The Manchurian Candidate, 1962), film diretto da John Frankenheimer. Nel film Angela Lansbury interpretava l’ambigua madre di Laurence Harvey. Al tempo, quella che in seguito sarebbe diventata famosa come “la signora in giallo”, era maggiore di appena tre anni dell’attore che vestiva i panni del figlio. Ma il maestro assoluto anche in questo genere di miracoli della celluloide sarebbe rimasto ancora una volta Alfred Hitchcock. In Intrigo internazionale (North by Northwest, 1959), Cary Grant veste i panni del figlio di Jessie Royce Landis che, all’epoca del film, aveva 8 anni di differenza con l’attore feticcio del regista inglese: senza voler indulgere alla perfidia, potrebbe essere fonte di una piccola soddisfazione che l’intera disavventura che stravolgerà l’appagata esistenza del protagonista nasca proprio dalla necessità di raggiungere telefonicamente la madre che sta giocando a bridge con le amiche (sempiterno il caro Edipo).
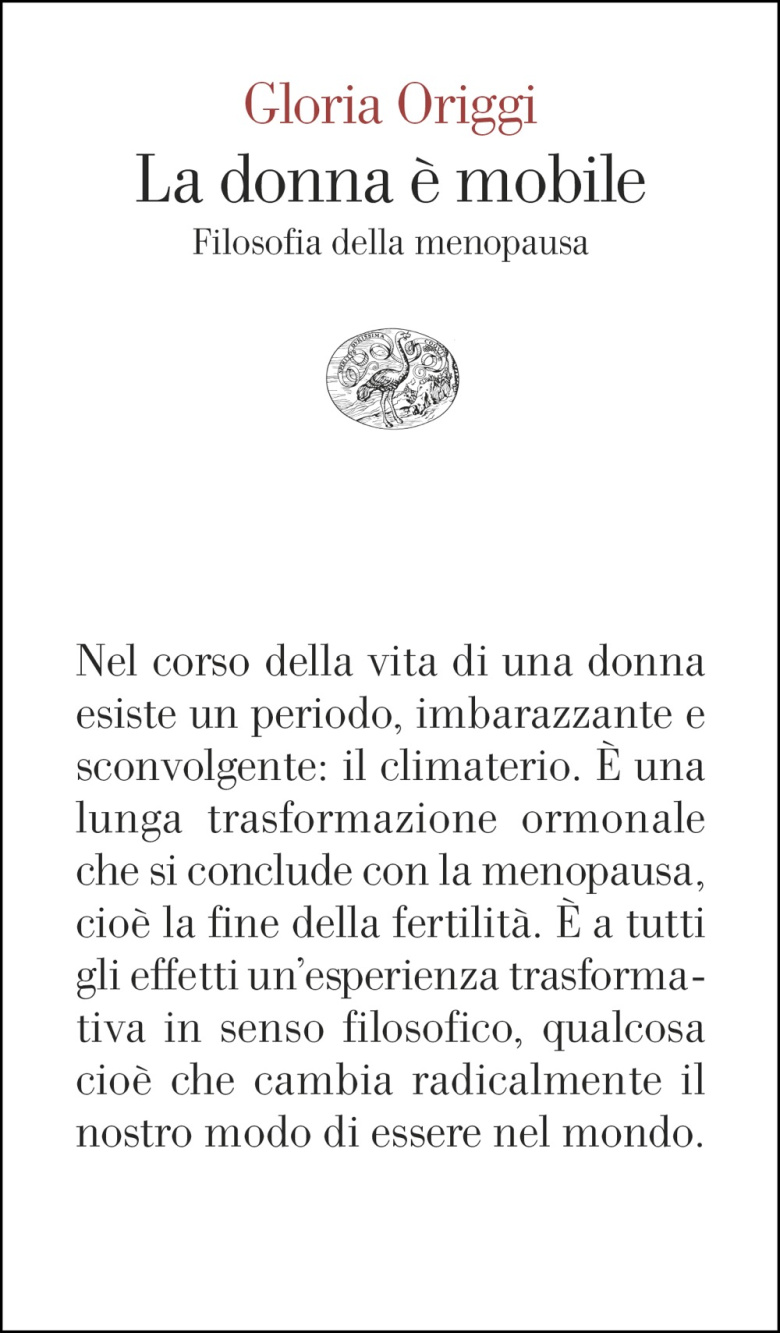
Leggendo il libro di Naomi Watts, attraversando il suo dolore ma anche la gioia di aver scoperto quali prospettive nuove scorgesse all’orizzonte, non potevo non ripensare al silenzio imbarazzato che scendeva a casa mia quando ero piccola, ogni volta che si parlava della mia nonna paterna, la quale, da un giorno all’altro, aveva perso il ciclo a trentotto anni. “Morirà giovane”, aveva sentenziato il vecchio medico di paese scuotendo il capo. La previsione del medico non fu mai dimenticata, soprattutto dalla nuora, ossia mia madre, che la ripeteva come un mantra a ogni loro litigio, mentre mia nonna sopravviveva nel tempo, per morire nel sonno alla soglia dei novant’anni. Ecco, io ero stata testimone oculare del fatto che la menopausa non fosse sinonimo di vecchiaia. Nonostante il sistema di omissioni e sostanziale disinteresse stia scricchiolando, e qua e là si parli più liberamente del tema, ancora oggi alla donna, col passare del tempo, non è concesso il cambiamento, anche quando è fisiologico. Si pretende da lei che non muti nel corpo, così come nella psiche o nella vita, e qualcosa ci dice il numero di donne uccise oggigiorno nel momento in cui decidono di abbracciare il cambiamento, in quel fenomeno orrendamente definito ‘femminicidio’, riducendo così la vittima all’insieme biologico dei suoi gameti e privandola di tutto quello che compone una persona (il mito di Pigmalione e le sue conseguenze aveva già dato indicazioni in questo senso). Non in tutte le società funziona allo stesso modo: nella lingua giapponese, per esempio, per definire la menopausa si usa la parola “konenki” (更年期) che letteralmente significa “periodo di cambiamento, rinnovamento dell’età”. La parola è composta da tre kanji: 更 (kō) → “cambiare, rinnovare”, 年 (nen) → “anno, età” e 期 (ki) → “periodo, stagione, fase,” letteralmente: “periodo di cambiamento dell’età” o “fase di rinnovamento”.
Nella società dei Baruya, della Nuova Guinea, la menopausa conferisce alle donne la libertà e soprattutto l’autorità che non sono concesse alle donne fertili. Nella tribù dei Lobi del Burkina Faso, la donna in menopausa diventa come un uomo, e può assumere ruoli normalmente maschili. A questo proposito, ricordiamo uno dei più improbabili incontri del secolo scorso, dopo quello tra Groucho Marx e T.S. Eliot. Nel giugno 1927 quella che ormai era per tutti la grande Colette accolse nei suoi appartamenti al Palais-Royal un timido Walter Benjamin. Il filosofo stava scrivendo un articolo che sarebbe stato pubblicato sulle pagine di “Die literarische Welt” il novembre successivo. Pieno di ammirazione, interrogò la famosa scrittrice a proposito del suo noto antifemminismo. “Posso contare, fra le mie conoscenze, un numero sufficiente di donne equilibrate, in buona salute, molto colte, intelligenti, che sarebbero capaci quanto un uomo di far parte di una commissione o di una giuria. Solo che tutte quante hanno, ogni mese – e vi posso assicurare che si tratta di donne normali, di ottima costituzione – dei giorni in cui sono irascibili, incontrollabili, imprevedibili. Gli affari pubblici seguono nonostante tutto il loro corso anche durante quei giorni, non è vero? E bisognerà votare e prendere decisioni”. Vale la pena ricordare che il voto alle donne in Francia fu concesso nell’aprile 1944, mentre, lento pede, la scienza proseguiva con le ricerche nel misterioso universo degli ormoni. Per lunghi secoli l’evento della menopausa non ha mai trovato una effettiva sponda medica, né rimedi se non vaghi (si consigliava di prestare massima attenzione alle correnti d’aria, al punto che per “la malata” era preferibile rimanere chiusa in casa. Un po’ come quando, nella campagna padana dove sono cresciuta, le nonne impedivano alle giovani nei giorni del ciclo di toccare le foglie delle piante che sarebbero altrimenti inevitabilmente morte. Adesso si dice semplicemente che non si ha il pollice verde, senza scomodare acrobatici scongiuri). La donna non più fertile periva sotto il peso atavico del pregiudizio sociale che concedeva alla fertilità la principale funzione femminile; tanto per togliere ogni dubbio sempre Simone de Beauvoir si sarebbe riferita alla menopausa come a una “definitiva mutilazione”.
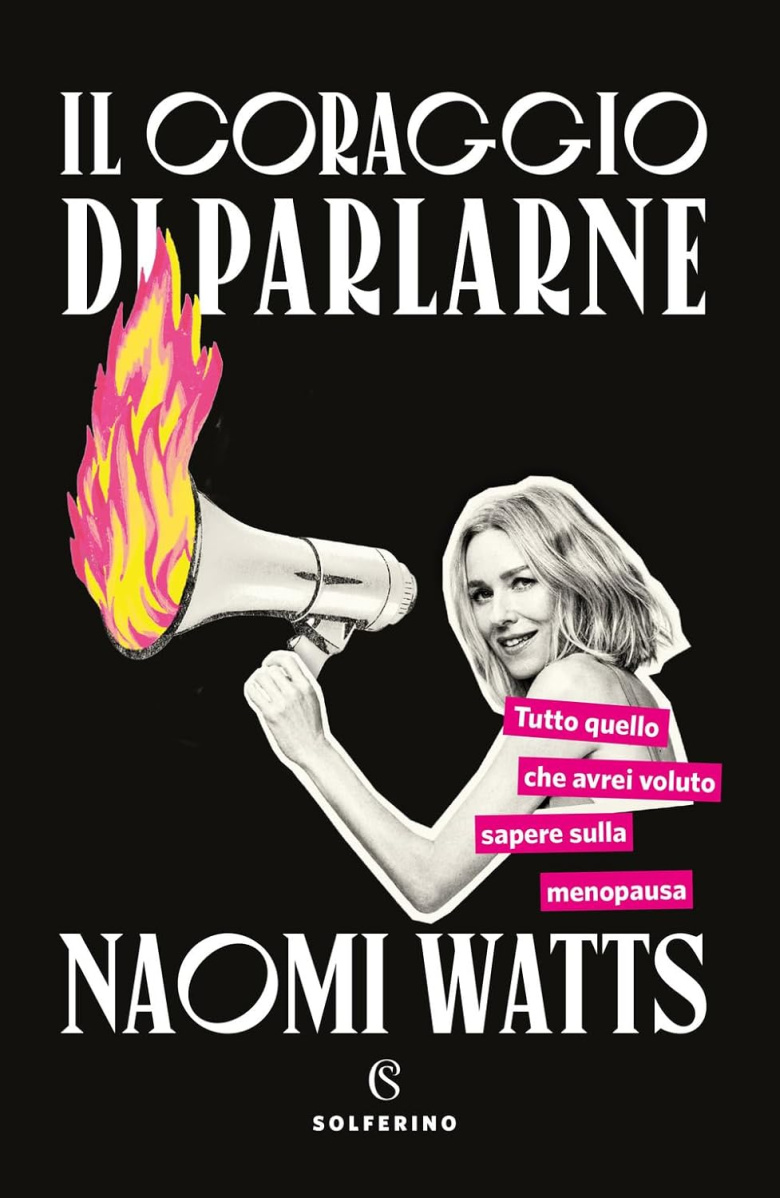
Sulla scia di Il doppio standard dell’invecchiamento (1972) di Susan Sontag, tuttora la menopausa non ha un parametro estetico: se il maschio di mezz’età, non più ragazzo si trasforma in uomo maturo, brizzolato e con le sue belle rughe a segnargli la faccia, restando un soggetto che si rinnova nel suo poter essere ancora seducente, per la donna della stessa età non è così. Condannata a dover restare, per la società, la moda, la famiglia, l’eterna ragazza di un tempo, con abbigliamento e apparato cosmetico immobili a dieci anni e settanta sintomi prima, la donna resta intrappolata nel disperato tentativo di immobilizzarsi con “diete, chirurgia estetica, trucco, tintura dei capelli, vestiti costosi per cercare di assomigliare alle giovani che non sono più”, dove la prima a essere sorda al cambiamento, oltre a medici impreparati e a una società ottusa, è lei stessa. La medicina è la scienza che più di tutte ha trascurato l’argomento, mentre i temi biologici ed esistenziali venivano qua e là affrontati dalla letteratura filosofica. La filosofa femminista australiana, Germaine Greer nel 1991 parlò della menopausa come di una vera e propria “era dell’invisibilità”, nella quale la donna sparisce, senza che nessuno sappia bene chi la sostituisca. Per secoli la medicina ha pressoché ignorato quelle che sono le esperienze trasformative femminili per eccellenza, come la pubertà, la gravidanza e maternità, soprattutto, il climaterio. Nel 1990, nel suo Questione di genere, nel sostenere la tesi principale che il genere è performativo, sulla scia di de Beauvoir, la filosofa Judith Butler metteva in discussione che l’identità di genere derivi dal sesso biologico, mentre si costituirebbe soprattutto come prodotto culturale, attraverso azioni e comportamenti sociali, linguistici, e molto altro ancora. Il punto resta comunque che in certe fasi della vita gli ormoni, studiati tardissimo nella storia delle scienze, “non guardano in faccia a nessuna performance”. Nell’antichità la medicina si interessava al corpo femminile con scarso interesse, lasciandolo avvolto in un nebuloso mistero tra ineluttabilità e pregiudizio, malattia e destino, con l’utero che veniva considerato pregiudizialmente un organo pauroso e folle – basti pensare alle variazioni che subisce, a seconda dei periodi e delle necessità, nelle sue dimensioni. Nel suo Historia animalium, Aristotele concedeva al ciclo mestruale un ruolo a dir poco vago, i motivi del menarca restavano oscuri, e Ippocrate credeva che il flusso mensile altro non fosse che una necessaria purificazione degli umori negativi della donna.
L’unica certezza sulla quale si trovavano tutti d’accordo era che la menopausa, che ancora non si chiamava così, altro non fosse che una transizione dalla fertilità alla infertilità, un peggioramento e una perdita irreversibili. Il termine “ménèspausie” fu introdotto per la prima volta nel 1816 dal medico Charles-Paul-Louis de Gardanne che lo trasformò nel definitivo “menopausa” nel 1921, nel titolo del suo best-seller De la Ménaupause ou de l’âge critique des femmes. La svolta che avrebbe finalmente segnato lo studio dell’età di mezzo femminile si sarebbe consumata solo nel 1946 con l’avvento dell’endocrinologia, e l’inaugurazione di una vera e propria teoria degli ormoni e del loro ruolo. La scoperta dell’apparato endocrino, il terzo sistema di comunicazione tra le varie parti del corpo, oltre a quello sanguigno e quello nervoso, fu rivoluzionario ed ebbe un seguito medico di forte impatto sociale e culturale, all’origine dell’invenzione della pillola anticoncezionale negli anni Cinquanta, della fecondazione in vitro e dello studio fisiologico della menopausa, strettamente legata a una vera e propria tempesta ormonale. In The Menopause Brain (2024), la neuroscienziata Lisa Mosconi dimostra come, prima di tutto, la menopausa sia un episodio del cervello, organo dotato di una sua struttura ormonale complessa e strettamente connessa alle ovaie, che evolve durante l’intera esistenza e che, durante la perimenopausa, gioca per anni a ping-pong con la mente e il corpo delle donne (modificandone ormoni, ossa e muscoli). In quel lungo lasso di tempo la struttura, la chimica e la connettività cerebrale sono radicalmente trasformate dalla menopausa. In breve: il climaterio non è una patologia, né un aspetto dell’invecchiamento, ma la transizione da un tipo di funzionamento all’altro del cervello durante la quale si riorganizza con nuove funzioni e cambia, tra le altre cose, la regolazione della temperatura corporea, la libido, le emozioni. Ad esempio, con la menopausa l’attenzione femminile si focalizza, potendo abbandonare il famoso multitasking (altro termine di cui avremmo fatto volentieri a meno, almeno io) al quale la condannavano gli estrogeni, diventa più stabile e può assumere anche una nuova visione del mondo.
Quando la donna entra nella turbolenta fase della menopausa può vivere momenti di ansia immotivata, sbalzi d’umore, attacchi isterici, irresistibili desideri erotici, vampate di calore o sensazione di freddo improvviso, depressione: non sta impazzendo, né sta cadendo in una paranoia ipocondriaca, ma è il suo cervello che si sta modificando, a spese di tutto il resto. Negli Stati Uniti attualmente il 75% dei medici non è preparato e licenzia la paziente senza averle prescritto nessun trattamento. Da noi non va molto diversamente. Per comprendere i 70 tra sintomi e comorbidità individuati al momento, tipici dell’esperienza più trasformativa (come definita dalla filosofa Laurie Ann Paul), basterebbe connettere i saperi di campi diversi, come quello neurologico, ginecologico, endocrinologico. Qualsiasi donna ne abbia fatto esperienza ha provato sulla propria pelle come la medicina continui ad annaspare, avendo sempre ignorato il più importante cambiamento della vita femminile insieme al suo corpo, considerato per secoli una versione difettata di quello maschile. La donna balla da sola fino alla fine, viaggia attraversando in solitaria un’esperienza che resta sostanzialmente afona, senza un suo spazio preciso nella medicina né nella società. Oggi, passo dopo passo, inciampo dopo inciampo, si inizia finalmente a dare la parola a un’esperienza altrimenti quasi silente e della quale la scienza inizia da pochi anni a balbettare, si rimettono a posto, uno dopo l’altro, i pezzi del mosaico nel quale la donna si rompe, sgretolandosi momentaneamente mentre gli estrogeni abbandonano a frotte il suo corpo. Giocando col paradosso, rovesciando un tavolo carico di carte ormai vecchie e superate, alla fine del suo saggio Gloria Origgi trova forse l’ultima risposta, quella definitiva alla domanda con la quale si apriva il libro (una donna in menopausa è ancora una donna?): “forse bisognerebbe assegnare il sesso non alla nascita, ma alla fine della vita: quando si vede chiaramente se il percorso di un individuo sia stato un percorso maschile o femminile”.
In copertina, opera di © Laura Berger, Three Rivers, 2025.







