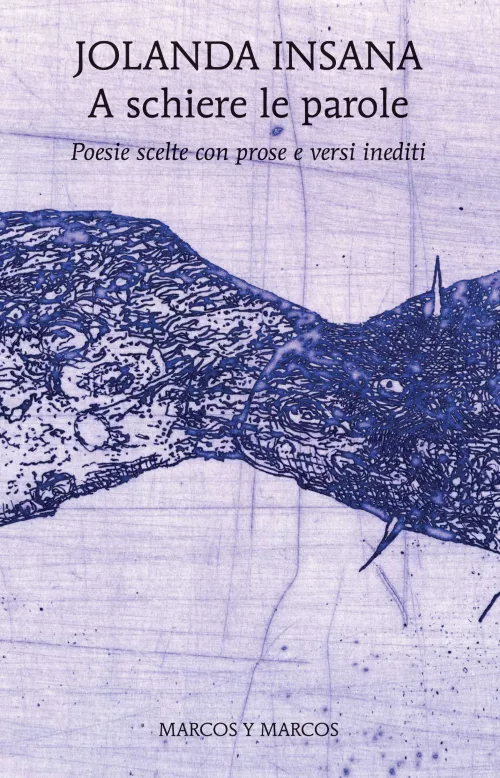Jolanda Insana, picchiacuori e fottiverso
Jolanda Insana ha rappresentato, nell’ultimo scorcio di Novecento, il caso particolare di un espressionismo ricercato, specie se si riporta il dato all’interno di quel vero e proprio cosmo che è la poesia delle donne: sia nei suoi aspetti più lirico-intimistici, sia in quelli più oracolari e sapienziali, sia in quelli più sperimentali. Fin dalla prima apparizione in un quaderno collettivo di Guanda, sotto l’egida autorevole di Giovanni Raboni, la sua scrittura si è posta in un dominio tutto suo, dove lingua e dialetto, retaggio popolare e tradizione colta hanno saputo abilmente mescolarsi e fondersi, con esiti davvero sorprendenti e del tutto originali nella temperie degli anni Settanta.
Sciarra amara fu il titolo scelto per quella prima silloge di versi, che nel 1977 focalizzarono una sicura attenzione intorno al nome di un’esordiente non più giovane, giunta infine alla pubblicazione dopo un lungo e sedimentato apprendistato; anni durante i quali la forza tellurica del sostrato etnico aveva rivitalizzato la frequentazione dei classici, dei greci e dei latini su cui Insana si era formata negli studi universitari. Come se, impiantandosi su quell’armonia e su quel rigore, l’urgenza quasi folcloristica del dire avesse infine trovato la sua forma, l’autrice coniava un dettato insolito in quel panorama, dominato da soggettività brucianti o dall’estenuarsi di quella che, non senza qualche riserva, era stata definita la «linea lombarda». Di quel ritorno all’io, dopo la stagione dei Novissimi, Insana costituì il più risoluto punto di fuga, e lo fece con un agire poetico ormai consapevole.
Vale riportare quanto Raboni sottolineò, con la consueta acutezza, a proposito di quei versi che per la prima volta incrociavano i lettori: «Usando il suo terroso dialetto siciliano come, volta a volta, una lingua morta (della morte) e una lingua della sopravvivenza o del futuro, e impastando con il medioitaliano delle nostre violenze e frustrazioni quotidiane secondo un progetto che dimostra la sua appartenenza alla schiera dei macheronici, degli aderenti ante o post litteram alla grandiosa “funzione Gadda” isolata una volta per tutte da Gianfranco Contini, la Insana dà vita, con questo collage di testi autosufficienti che è anche, e senza alcuna contraddizione, una sorta di poema-dibattito testardamente e dolorosamente ininterrotto, a un organismo espressivo tra i più singolari, compatti e vitali nei quali, da qualche anno a questa parte, ci sia capitato di imbatterci». Lo scopritore, fattosi nell’immediato recensore, individuava alcuni punti salienti che già allora determinavano le direzioni espressive intraprese, coerentemente perseguite dalla sua autrice.
Sull’immagine calzante di un dialetto «terroso», ctonio e vitale, Insana aveva saputo erigere una costruzione linguistica coerente e insieme dialettica, dove vita e morte (pensando alla Sicilia, alla sua storia e al coacervo delle sue culture, si sarebbe tentati di scriverle con la maiuscola) inscenavano un teatro fitto di tensioni e di reciproci attentati. Questo fu in effetti il significativo miracolo di un italiano medio, di una lingua standard contaminata da pulsioni in apparenza centrifughe (il folcloristico e il tradizionale), che congiunte e dominate in un solo flusso espressivo avrebbero rotto l’argine dei toni ora confessionali, ora diaristici e autoreferenziali, allora dominanti la scena della ricerca poetica, accanto al manierismo sempre più imperante.
Con ciò, come intuì Raboni, Insana rispose a un vero «progetto». Ci sono poeti che nascono compiuti e il cui destino è solo quello di crescere intorno a una scrittura già ben assestata; altri che invece hanno necessità di sperimentare rotte diverse. Come Sereni appartenne a quest’ultima specie, Raboni fu piuttosto della prima, e dovette quindi riconoscersi nell’inquieta fermezza di Sciarra amara. Certo, a monte c’era stata un’altra, importantissima fascinazione siciliana, che poté rappresentare un fertile terreno di accoglienza da parte sua: penso a un autore, oggi in forte e giusta rivalutazione, come Bartolo Cattafi, che muoveva dalla stessa provincia. La geografia dello Stretto, che dal punto di vista antropologico ora risponde a un pieno, ora a un vuoto, colpì Raboni due volte. Da quel momento il poeta non avrebbe mai mancato di esercitare una sorta di prelazione editoriale su quanto Insana andava congedando: i libri, fino alle ultime apparizioni nella collana verde di Garzanti e infine negli Elefanti, stanno lì a dimostrarlo. Mancati entrambi, sulla poesia dell’autrice messinese sembrava calato un inspiegabile silenzio, fino a questa opportuna operazione antologica proposta nella collana «Le ali», che Marcos y Marcos ha affidato alle cure di Fabio Pusterla e Massimo Gezzi.

Il titolo, A schiere di parole, si assesta su una metafora che chiarisce ulteriormente la natura militante del progetto linguistico di Insana. «Partiamo per la guerra dei meloni», annota altrove, introducendo a mo’ di epigrafe la raccolta Fendenti fonici che resterà per lei come un marchio di fabbrica, a evidenziare la componente acustica di un’espressività che proprio nell’atto performativo rinviene la dimensione più propria e più efficace. La componente dialettale riemerge con tutto il suo portato di oralità, imponendo una prossemica mai spontanea, ma ben studiata al fine di coinvolgere il lettore; non solo stordendolo nell’insistenza di quei fendenti, ma anche immettendolo concretamente sulla scena di un teatro di cui l’abile «pupara» resta la sola regista.
Nella rappresentazione di questa «guerra dei meloni» la lingua torna a farsi carico, nello stesso tempo, di una profondità e di un’inconsistenza che ugualmente reggono l’insieme delle relazioni umane, sul piano del presente individuale come su quello ben più ampio e tragico della Storia. E nel farlo tocca l’intera tastiera delle sue varietà, attingendo a una vasta gamma di soluzioni che contemperano una lunga diacronia (il passato, sia il sostrato etnico sia la cultura classica), fino all’attualità della cronaca; passando per i linguaggi più settoriali abbraccia idioletti e modi di dire del contemporaneo, mostrando davvero la sua attitudine al macheronico, come rilevava Raboni, e percorre toni e registri fino all’insulto e alla bestemmia.
La scelta antologica, compiuta da Anna Mauceri, comprende l’intero percorso creativo di Insana, da Sciarra amara all’ultimo Turbativa d’incanto, ma il volume è arricchito da una consistente scelta di prose, edite e inedite, che spaziano dall’autoritratto (qui l’autrice si presenta, nel consueto scoppiettio verbale, come «padrona di contorsioni», raccoglitrice di «torsoli di materia verbale», picchiacuori e fottiverso) all’accenno di romanzo, abbracciando un arco temporale che arretra a ben prima della silloge d’esordio; come, del resto, alcune prove in versi che chiudono il libro, impreziosendolo con la loro rarità. Sono gli incunaboli di ciò che poi sarebbe divenuta la scrittura di Insana, ma le direzioni possono già intravedersi, dall’impianto formale alle variazioni di registro. Sono i testimoni di un progressivo atteggiarsi della voce, fino alla compiutezza di Sciarra amara, che segna la conquista definitiva di quelle «teatranterie» destinate a farsi cifra dominante, dimensione autentica di una carica espressiva rimasta pressoché unica.
Nella sua densa prefazione, Maria Antonietta Grignani sostanzia la «funzione Gadda», già rievocata, in una linea che dalle lontane origini del Contrasto di Ciullo d’Alcamo, passando per il plurilinguismo dantesco, ripresa e proiettata in avanti da Aretino e Folengo, giunge nel pieno della modernità irrorandone le tensioni; ora votandosi all’ironia, ora dando voce a una forma di critica anche sociale, esasperando la richiesta di attenzione da parte dei destinatari proprio nell’istante in cui li stordisce – e li irretisce – con i suoi giochi pirotecnici. È un dato più che condivisibile, che innesta la poesia di Insana nel solco di una vivacità regionale, spontaneamente teatrale, stemma di un’identità difesa a oltranza, ostentata proprio nella sua rappresentazione. Eppure, sotto quest’energia istrionica, traspare il desiderio di una visione della realtà ancora segnata dalla sorpresa e dall’incanto, per cui Insana si mostra come l’abile pupara che è, ma anche come la bambina che assiste a un teatro forse estraneo o straniante, ancora inconsapevole di quanto quello stesso spettacolo visceralmente le appartenga. E allora non le resta che assorbirla, quella lingua che viene da lontano, appropriarsene per plasmarla e reinventarla, portarla in casa sua come cosa viva e lasciarla riaffiorare da un sostrato profondo, da un io collettivo senza più tempo.
In questo non-tempo la poesia può solo crescere e prosperare, rinvenendo la sua dimensione; e al poeta non resta che affacciarsi sull’orlo di una modernità abissale, che osserva sé stessa con l’occhio un po’ severo e un po’ malinconico di chi ha compreso di essersi allontanato, per sempre, da un nucleo originario di serenità. Ecco, «Il persempre è un tunnel senza illuminazione che non si sa dove sbuca, né io so dove porta la strada abbandonata», leggiamo in uno dei frammenti in prosa (il frammentismo, forma della crisi); ed è in questa ritrovata consapevolezza che lo sguardo su sé stessa e sulla sua epoca – segnata da nuovi conflitti e nuovi fenomeni migratori, verso i quali Insana mostra in più punti della sua opera un interesse dolente e mai cronachistico – si fa limpido e la lingua, finalmente affrancata dai lacci di una comunicazione conformistica, può tornare a giocare. Così ogni fonema restituisce alla sua parlante tutta la potenza eversiva di quell’antico teatro dove Vita e Morte si fronteggiano, come due paladini ormai stanchi e assuefatti al loro ruolo, eppure ancora desiderosi di combattersi.