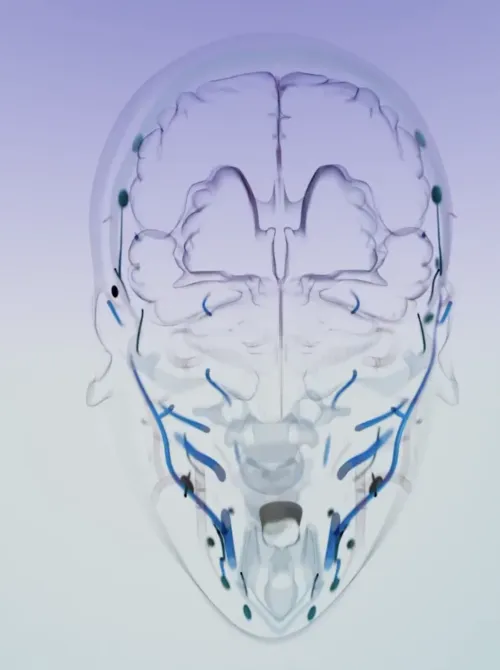Le neurominoranze e il sistema
Il paradigma della neurodiversità è un approccio sociologico e politico emerso grazie alla riflessione e alla presa di parola dei gruppi di persone adulte impegnate nell’attivismo sulal propria condizione autistica negli anni Novanta, in netto contrasto sia con le visioni mediche sia con quelle antipsichiatriche. Sviluppato inizialmente da teorici come Nick Walker, Kassiane Asasumasu e Harvey Blume, rifiuta la validità di una norma rispetto alla quale tutti i cervelli dovrebbero essere valutati e propone di considerare il funzionamento e le caratteristiche della mente in modo coerente con il principio della biodiversità: come negli ecosistemi ambientali la coesistenza di grandi varietà di individui rinforza la resistenza e l’adattabilità complessiva, così la diversità neurologica è vitale per l'umanità. In questa prospettiva tutti i tipi di mente sono valorizzati e la normalità non è intrinsecamente superiore all’atipicità. Il movimento per la neurodiversità adotta il modello sociale della disabilità, secondo il quale la disabilitazione è un processo eminentemente sociale, derivante dalle strutture e dalle pratiche del vivere collettivo (come la mancanza di rampe o gli ambienti sensorialmente sovrastimolanti), piuttosto che un problema individuale causato dalla menomazione corporea o cerebrale. Di conseguenza, diversi tipi di mente possono essere abili o disabili in ambienti diversi, e nessuno è naturalmente superiore all'altro. Questo non significa negare la sofferenza delle persone autistiche, ad esempio: essa viene compresa nel contesto dell'emarginazione e dell'oppressione sociale che, nel considerare deficit le modalità cognitive, esistenziali e comunicative peculiari, le reprime anziché darvi spazio.
Robert Chapman, filosofo e teorico sociale che lavora nelle università del Regno Unito, si occupa da anni di follia e disabilità; il suo blog raccoglie riflessioni orientate a “sviluppare la prima metafisica marxista-femminista dell'autismo”. Nel libro L’impero della normalità, la cui versione italiana è curata dal Collettivo Ippolita e arricchita da un saggio di Enrico Valtellina, la neurodiversità viene concettualizzata come un asse di diversità umana – simile all’appartenenza etnica, di genere o all'orientamento sessuale – e ciò implica che la patologizzazione delle neurominoranze costituisce un'altra forma di oppressione sistemica. Le persone neurodivergenti impegnate nell’attivismo hanno iniziato a riappropriarsi delle diagnosi (come autismo, ADHD o disprassia) riconoscendole come forme condivise di disabilitazione e rifiutando l'idea che il loro significato si esaurisca in una disfunzione personale. Da questa posizione deriva una radicale contestazione dell'autorità clinica: la teoria della neurodiversità decentra la potestà del personale psichiatrico, psicologico e di altre specializzazioni (cliniche, riabilitative o educative), ponendo le persone disabili come principali esperte della propria esperienza e andando verso l’obiettivo di un cambiamento radicale. A lungo termine tale movimento mira a sostituire il dominante "paradigma della patologia" con quello della neurodiversità, in modo che esso riconverta la ricerca scientifica, le pratiche cliniche e la cultura. Per Chapman, è l’occasione per superare il dualismo cartesiano che si è dimostrato utile sia al capitale che allo Stato: “la combinazione tra una concezione completamente meccanicista del corpo come macchina funzionante o guasta, e un netto dualismo per preservare la sacralità della mente” si è rivelata infatti la più funzionale al processo di valorizzazione della forza-lavoro; “la proposta di Descartes (...) giunse a una piena accettazione non soltanto perché era utile alla medicina, ma anche perché era enormemente utile al capitale, dato che nel diciannovesimo secolo industriali, proprietari di piantagioni e altri capitalisti consideravano i lavoratori come macchine potenzialmente funzionanti o guaste”.
Dalle misurazioni dell’intelligenza di Sir Galton fino ai moderni psicanalisti direttori di manicomi (che Chapman definisce "complici del sistema detentivo statale"), l’oggettivazione scientifica della mente è orientata dagli interessi e dai valori della classe dominante. Anche quando l’egemonia della disciplina psichiatrica viene contesa e oscilla tra l’organicismo e lo psicologismo, la funzione finale di sostegno alla produzione, correzione delle devianze e controllo della separazione tra popolazione produttiva e improduttiva non viene mai messa in questione: “in altre parole, Kraepelin immaginava di estendere l’approccio sviluppato da Galton per studiare l’intelligenza, inglobando ogni altro aspetto della mente, e dando una base sia alla psichiatria sia a una varietà di ruoli legati alle mutevoli esigenze del capitale in ambito educativo, lavorativo, e via dicendo”; nel dopoguerra, invece, l’evolversi delle forme di controllo sociale e la compromissione del biologismo con l’eugenetica nazista contribuirono a una modificazione dell’egemonia nel campo psichiatrico, “nei circoli liberali si diffuse l’idea che la psichiatria biologica kraepeliana fosse contaminata. Gli eugenisti sgattaiolarono nei dipartimenti di genetica e psicologia, e cambiarono etichetta ai loro studi senza riferimenti al perfezionamento delle razze”: si apriva la fase dello psicanalismo di massa a cui corrisposero nuovi modelli di psichiatria sociale. L’avvento del neoliberalismo, descritto da Robert Chapman principalmente come un passaggio dall'economia keynesiana a quella hayekiana, ha impattato sulle società occidentali provocando una “disabilitazione di massa” e contestualmente inquadrando questo fenomeno nella privatizzazione dello stress e nel "neuro-thatcherismo".
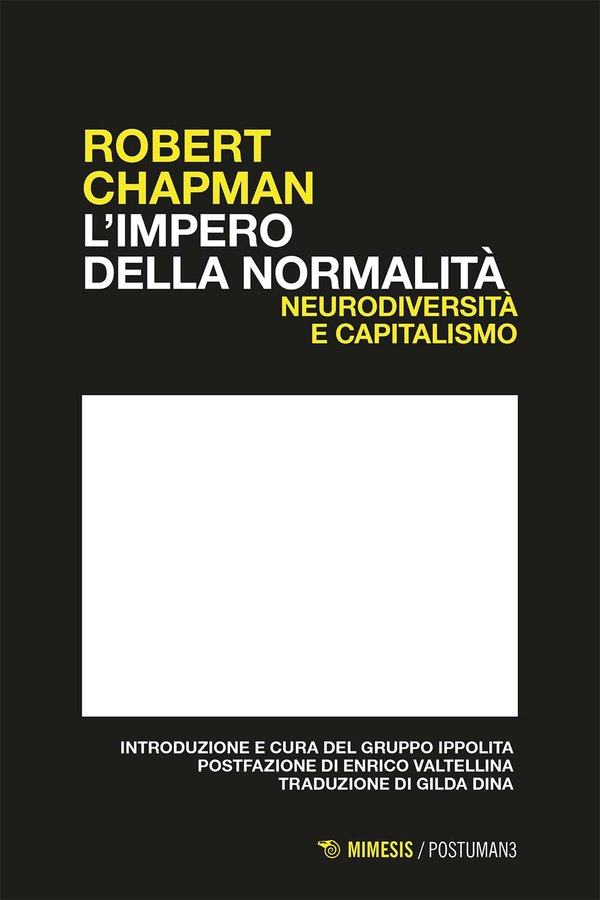
Con la rivoluzione digitale e il capitalismo cognitivo, infatti, sono emerse "nuove norme restrittive relative alla sfera cognitiva, emotiva e d’attenzione"; questa "intensificazione sensoriale-cognitiva del capitalismo ha comportato l’esclusione di un maggior numero di persone dall’istruzione o dal lavoro", danneggiandole e spingendole "verso la popolazione eccedente". Le nuove diagnosi disabilitanti, come l'autismo e l'ADHD, si sono estese radicalmente poiché una crescente percentuale della popolazione non soddisfaceva più le capacità di elaborazione sociale, comunicativa e sensoriale richieste dalla nuova economia: tratti precedentemente benigni o minimamente considerati sono diventati significativamente invalidanti a causa dell'intensificazione capitalista. Quindi "il neoliberalismo ha portato ciò che Mark Fisher definì una privatizzazione dello stress, per cui la cura personale è diventata un imperativo etico dell’individuo, e l’autogestione ha preso il posto del sostegno statale, sempre più limitato". Le industrie del benessere e della mindfulness sono fiorite, aiutando le persone stressate ad adattarsi a orari di lavoro più lunghi e a condizioni di vita peggiori. Gli interventi statali per ansia e depressione si sono ridotti a farmaci e a poche sessioni di psicoterapia cognitivo-comportamentale con l'obiettivo specifico di riportare le persone al lavoro, aumentando l'alienazione e lasciando inalterati i problemi più profondi. Chapman usa il concetto di "neuro-tatcherismo" per descrivere come "il capitalismo sovverte i tentativi di contrastare i suoi effetti nocivi trasformandoli in nuove opportunità di massimizzazione del profitto e della produttività". In questo contesto, l'attivismo per la neurodiversità deve svincolarsi, come già ha fatto il movimento delle persone disabilitate, dalle sirene liberali degli approcci individualisti e del modello medico, indipendentemente dal fatto che essi siano esplicitamente psichiatrizzanti oppure si presentino ammantati dalla copertura dell’antipsichiatria o delle psicoterapie.
L'antipsichiatria, pur avendo sollevato importanti questioni sul controllo sociale intrinseco alla psichiatria, ha fallito nel comprendere le radici sistemiche dell'oppressione neurodivergente, finendo per rafforzare, anziché contestare, le logiche di dominio del capitalismo: la negazione della realtà della malattia mentale e della disabilità ha involontariamente rafforzato il paradigma della patologia, accettando l'oggettività e la scientificità della "normalità biologica" del corpo e concentrandosi solo sulla presunta non-scientificità della malattia "mentale": in pratica l’antipsichiatria ha "mancato il bersaglio" della vera causa dell'oppressione, focalizzandosi sulla scarsa validità scientifica dei saperi o sulla violenza delle pratiche manicomiali, senza riconoscere la “logica neuronormativa più ampia del sistema capitalista”. Il principale obiettivo delle critiche di Chapman all’antipsichiatria è Thomas Szasz, le cui posizioni individualiste vengono contrapposte agli approcci di Franco Basaglia, di Peter Sedgwick del Collettivo di pazienti socialista attivo in Germania dagli anni ‘70; la sua critica si concentra inoltre sugli orientamenti odierni che, negando la malattia mentale, puntano in realtà a sostituire l’egemonia psichiatrica con una nuova egemonia psicoterapeutica: operazione che lascia intatto il cuore del modello medico e si contrappone in modo regressivo all’emersione di un movimento direttamente gestito dalle persone disabilitate in salute mentale.
Il libro di Chapman risulta fondamentale per contrastare i tentativi neoliberali di recupero del paradigma della neurodiversità: limitandosi a riforme graduali e puntando solo a cambiamenti di riconoscimento e rappresentazione – piuttosto che puntare su un cambiamento delle condizioni materiali più profonde – il movimento rischia la cooptazione da parte del capitalismo sotto forma di inclusione, che sfrutta i "super poteri" neurodivergenti per scopi produttivi, ma non mette in discussione le strutture profonde di oppressione.
Le prime formulazioni, come quelle di Singer, focalizzandosi su un autismo “ad alto funzionamento", hanno marginalizzato le persone autistiche più distanti dagli standard neuronormativi anche nel campo dell’attivismo, riproducendo aspetti del paradigma di Galton. A questi rischi Chapman contrappone l’analisi materialista del paradigma della patologia e delle condizioni economiche capitaliste che lo hanno generato e lo mantengono; senza un cambiamento delle strutture materiali, il modello medico non può essere pienamente superato. Nell’ottica di un marxismo neurodivergente, che miri a spezzare l'associazione tra salute, norma e produttività, e a trasformare la disabilitazione e la condizione neurologica in uno spazio di organizzazione e di resistenza contro il sistema capitalista, l’assunzione dell’identità neurodivergente è uno strumento di lotta, che non va assolutamente confuso con un sostegno al modello medico dominante: «al contrario, il suffisso “neuro” dà risalto alla natura incarnata della mente e all’inseparabilità della cognizione dal corpo, e oltre a questo, dal mondo».
Leggi anche:
Anita Romanello | Cervelli diversi
In copertina, opera di © Kate Cooper.