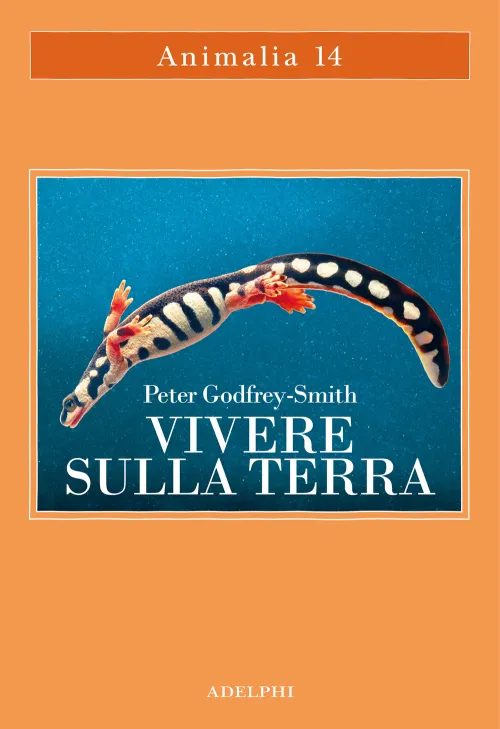Godfrey-Smith: la Terra è viva
Arriviamo sempre ultimi, con la pretesa, però, di aver scoperto tutto noi (noi occidentali, s’intende). Nel suo Il nocciolo della vacuità. Comprendere la filosofia di Nāgārjuna (pubblicato in italiano dalle edizioni Ubiliber) il monaco vietnamita Thich Nhat Hanh scriveva che al cuore della visione di Nāgārjuna (filosofo indiano del secondo secolo dopo Cristo) c’è la nozione di “reciprocità”: secondo questo principio “questo è presente perché quello è presente”, ossia non esistono nel mondo entità autosufficienti, tutte in qualche modo sono collegate con e dipendono da tutte le altre: questo significa, prosegue Thich Nhat Hanh, che “le cose si aspettano a vicenda per potersi manifestare insieme”. È una visione allo stesso tempo meravigliosa e semplice, perché in fondo tutti noi lo sappiamo, niente può esistere senza la partecipazione di tutte le altre cose del mondo (le cose, propriamente, non sono altro che questa interconnessione reciproca), eppure viviamo e ci comportiamo come se non lo sapessimo, come se davvero il mondo fosse composto di entità isolate a autonome.
È questo il pensiero, ma forse sarebbe meglio chiamarla l’intuizione, alla base del libro del filosofo della scienza australiano Peter Godfrey-Smith Vivere sulla terra (Adelphi, 2025), un libro che è appunto ispirato da un radicale “approccio ecologico”: in effetti “l’approccio che propongo” – per questo dicevamo più sopra che pretendiamo di scoprire quello che altre culture hanno sempre saputo – “abbraccia fedelmente l’idea per cui noi esseri viventi e agenti nel mondo siamo qui tutti insieme, in quanto elementi di un unico grande sistema. Abbiamo tutti prospettive differenti su di esso ma, allo stesso tempo, continuiamo a farne parte e contribuiamo, individualmente, al suo modo di essere e di cambiare” (p. 23). In altri termini, non siamo soli, non c’è il mondo da una parte e dall’altra noi umani, c’è il mondo, e del mondo siamo tutti parte, o, per essere più precisi, ognuno di noi (e in questo noi rientrano viventi e no, cose e persone, tutto quello che c’è insomma) non è altro che un modo particolare di essere del mondo (come la nebbia è un modo d’essere dell’acqua, o il tramonto del sole e dell’aria): non è che il vivente è sulla terra, è che la terra è viva, perché la terra è inseparabile dalla vita che si vive sulla terra: l’immagine del mondo che ne risulta, “è dunque quella di una Terra dinamica. Il nostro pianeta non è un palcoscenico inerte né qualcosa che può cambiare soltanto per effetto della propria forza: il mutamento è il risultato delle attività vitali” (p. 45). Con una formula che è molto più scientifica di quanto si possa ritenere, non è che sulla terra c’è vita, la terra è viva. La formula poetica è anche in questo caso quella più aderente ai fatti. Ma non si può sostenere una tesi del genere senza accettarne le conseguenze, soprattutto quella che una mentalità scientifica – anche se indubbiamente aperta e recettiva come quella di Godfrey-Smith – non solo non è disposta ad ammettere, ma nemmeno a prendere in considerazione. Perché se la terra è a suo modo viva, allora l’atteggiamento che noialtri umani dovremmo assumere nei suoi confronti (e quindi, di noi stessi, perché noi siamo la terra, e la terra siamo noi) non può essere soltanto, né prevalentemente, quello tecnico-scientifico (ed economico). La terra è viva, appunto.
La tesi scientifica secondo cui il pianeta terra è ‘vivo’ nel mondo occidentale (come sabbiamo visto questa idea è molto più antica, anche nel ‘nostro’ mondo; è ad esempio quella del filosofo calabrese Tommaso Campanella, 1568 – 1639) è nota come l’ipotesi Gaia (nella mitologia greca Γαῖα, la dea primigenia della terra), sostenuta all’inizio fra molti scetticismi dal fisico inglese James Lovelock e dalla biologa statunitense Lynn Margulis negli anni ’70 del Novecento. In effetti per la mentalità scientifica ‘ortodossa’ parlare della terra come qualcosa di ‘vivente’ è non tanto sbagliato (una roccia non è viva come è viva una gallina), ma proprio del tutto assurdo. Eppure è proprio questa assurdità che l’ipotesi Gaia sostiene, la terra è viva. Godfrey-Smith è un filosofo della scienza, e quindi possiamo immaginare quanto, per una persona con la sua preparazione disciplinare e soprattutto il suo modo di pensare, un’ipotesi del genere possa sembrare affatto improponibile, eppure – onore al filosofo australiano – la prende davvero in considerazione, e alla fine sostanzialmente l’accetta. Il punto è che fare propria questa ipotesi, ed è davvero quello che fa Godfrey-Smith pur con molti distinguo, significa accettare qualcosa che per la moderna mentalità tecnico-scientifica è molto difficile da accettare, una mentalità che invece considera l’intero mondo una cosa enormemente complessa a nostra disposizione, cioè di cui possiamo fare quello che vogliamo (come abbattere le foreste per produrre mais con cui allevare carne da macello oppure mettere al lavoro il vento, e senza retribuzione, per produrre elettricità). Il problema è come spiegare, da un punto di vista scientifico, l’esistenza di Gaia, “poiché” – è il punto decisivo di tutto il libro – “Dio non sembra entrare nel quadro” (p. 50). In questa esclusione consiste, propriamente, la nostra moderna mentalità economico-scientifica, nel presumere in partenza che Dio non entri nel quadro necessario per dare conto del mondo. Che cosa significa, in questo caso, la parola “Dio”? Com’è noto è blasfemo anche solo provare a rispondere a questa domanda, il punto è provare a vedere il mondo come qualcosa di intrinsecamente dotato di valore. Per vedere il mondo in questo modo non è necessario credere in Dio, (o forse, credere in Dio significa vedere il mondo in questo modo) si tratta piuttosto di vederlo, come suggeriva il mistico e logico austriaco Ludwig Wittgenstein, come un “miracolo”. Con la precisazione che un “miracolo”, per Wittgenstein, non è un fenomeno che non si spiega con le ‘normali’ leggi della natura; piuttosto è un miracolo vedere il mondo come qualcosa che non dev’essere spiegato, appunto come qualcosa che si spiega da sé.

Ma perché la questione di Dio è così importante, anche se Godfrey-Smith le dedica solo una parola di passaggio? Perché l’ipotesi Gaia non è tanto una ipotesi scientifica, è piuttosto un invito a vedere il mondo come un miracolo. In realtà è lo stesso Godfrey-Smith che, onestamente, si rende conto che la “complementarità” (p. 58) fra l’infinità di fattori che rendono possibile la vita sulla terra è tanto complessa e intricata da sembrare inspiegabile. Prendiamo il caso, a cui dedica molte pagine piene di dati e di descrizioni accurate, dell’esistenza di acqua allo stato liquido, un fenomeno che non sembra così comune come potremmo pensare: “alcuni meccanismi stabilizzanti e compatibili con la vita non sono soltanto interessanti, possono sembrare quasi inspiegabili. La combinazione di fattori che ha impedito alla nostra acqua di congelare o di bollire ed evaporare è uno di questi meccanismi (o, perlomeno, a me sembra che sia così)” (p. 58). È lo stesso filosofo della scienza Godfrey-Smith ad ammetterlo, questi fatti enormemente complicati e improbabili “non sono soltanto interessanti, possono sembrare quasi inspiegabili”. Appunto. In questo consiste vedere il mondo come un miracolo, prendere atto del fatto che il mondo c’è, e non cercare di (o nel rinunciare a) spiegarlo. Il mondo c’è, il mondo è vivo, Gaia esiste, noi siamo Gaia, Gaia siamo noi: “mentre andiamo avanti insieme, siamo parti vive di un sistema più vasto che include viventi e non viventi. Pur non somigliando molto a un organismo” – qui Godfrey-Smith è costretto a ricordarsi di ‘credere’ solo nella scienza, in particolare nella teoria dell’evoluzione darwiniana – “si tratta di un sistema dove la parte vivente è strettamente legata a quella non vivente. La Terra è stata trasformata in qualcosa di vivo dagli organismi che ospita, pur non essendo viva in sé” (pp. 58-59). Quest’ultima precisazione, oltre ad essere molto vicina ad essere autocontraddittoria, indica però il disagio di Godfrey-Smith a dover ammettere la presenza di Gaia, che è viva senza essere fatta di cose vive, proprio come accade al nostro corpo, che è vivo anche se i componenti atomici che lo compongono non sono vivi (ma questo significa solo, in fondo, che la distinzione fra ciò che è vivo e ciò che non lo è non è affatto assoluta).
Che il grande impensato di questo libro sia il pensiero di Dio – un pensiero che finché non verrà affrontato seriamente renderà del tutto insolubile l’attuale gravissima crisi ecologica – lo dimostrano due ulteriori esempi. Nel primo, quello del “test della reincarnazione”, Godfrey-Smith immagina un possibile argomento contro l’allevamento industriale degli animali da macello. Nessuno, anche il mangiatore seriale di bistecche al sangue può fingere di non sapere le condizioni spaventose in cui si svolgono le brevissime e dolorosissime esistenze degli animali allevati per la loro carne. L’argomento di Godfrey-Smith contro l’allevamento industriale è un tipico argomento religioso, dal momento che si basa sulla possibilità della reincarnazione: “Supponiamo di essere destinati a tornare indietro diventando un maiale in un allevamento industriale intensivo, un CAFO [Concentrated Animal Feeding Operation]. […] È un’esistenza che dura circa sei mesi, inizia con l’allontanamento forzato dalla madre e non prevede neppure un attimo di tempo dedicato a fare cose che i suini apprezzano, neppure un giorno. Se rinascessimo così, passeremmo tutti i nostri giorni chiusi in un luogo affollato, in preda a un misto di stress, monotonia e dolore. La situazione delle mucche da carne allevate in modo intensivo […] è leggermente meno tragica. Le mucche da latte possono vivere un po’ meglio o un po’ peggio. Nel caso peggiore, come i maiali, sono costrette al chiuso per tutta la vita e periodicamente obbligate a riprodursi per poi essere immediatamente separate dai propri vitelli. Se doveste tornare per vivere in uno di questi modi, scegliereste di farlo?” (p. 241). Lasciamo la risposta alla lettrice e al lettore, qui interessa l’argomento usato da Godfrey-Smith, che presuppone proprio quella che la visione del mondo di molte religioni prevede, la reincarnazione.
L’ultimo esempio riguarda la nostra posizione soggettiva nel mondo. In effetti, se c’è Gaia in che senso “io” posso esistere come entità autonoma e indipendente? La risposta di Godfrey-Smith è, ancora una volta, molto simile a quella che avrebbe potuto dare Nāgārjuna. Secondo il filosofo australiano, per rispondere a questa domanda occorre puntare “direttamente sulla connessione, sulla nostra continuità materiale e sulla parentela che ci lega a tutti gli altri organismi della Terra e tiene conto dell’importanza della sostituzione, dell’andare e venire degli individui” (p. 320). Non esiste “io”, esiste Gaia (e quindi “io” sono un modo di essere di Gaia, come la foglia è un modo di essere dell’albero, che a sua volta è un modo d’essere della Terra e dell’ossigeno, e così via), questo il pensiero religioso l’ha sempre saputo: “possiamo percepire un senso di identificazione con i processi che caratterizzano la vita sulla nostra” – perché “nostra”? Ma non possiamo pretendere troppo da un filosofo della scienza – “Terra. Questi processi prevedono, per specie come la nostra, esistenze che prendono la forma di un viaggio, messe in moto e alimentate dalle energie della natura e poi dissolte nuovamente in esse, come prima è accaduto ad altri” (p. 324). “Io” non esiste, esiste la vita, esiste la continuità e l’ininterrotta trasformazione della vita della Terra (la terra non è nient’altro che questa vita). E che cos'è questo se non un pensiero religioso?