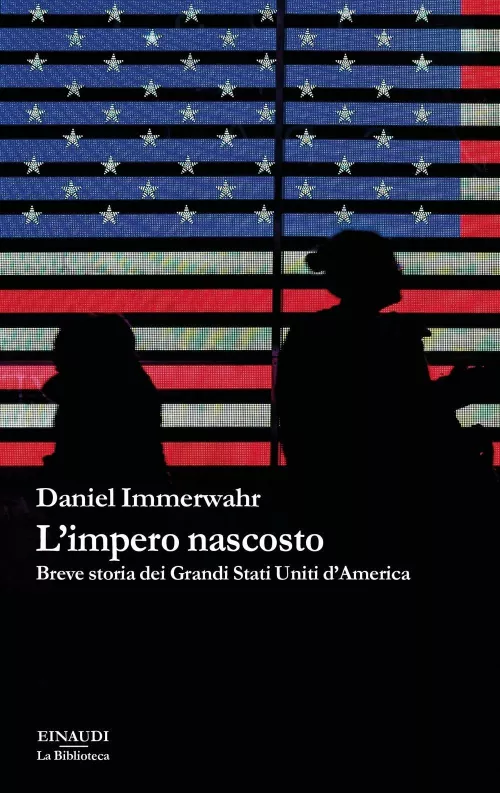Empire state of mind / Stati Uniti: l'impero nascosto
La quarta di copertina di un libro è la prima cosa che si guarda dopo che il titolo ha attirato la nostra attenzione. Non sempre dice la verità. Lo fa nel caso de L’impero nascosto di Daniel Immerwahr (Einaudi, 603 pp., 34 euro), quando dice che “la storia degli Stati Uniti al di fuori degli Stati Uniti” è “la vicenda di un impero che ha sempre negato di essere tale”. Impigliati nella stessa contraddizione che gli aveva impedito di nominare la schiavitù nella Costituzione dopo avere affermato l’uguaglianza e la libertà di tutti gli uomini, gli Stati Uniti hanno evitato di chiamare colonie – di pensare e definire come possedimenti coloniali – le numerose dipendenze territoriali accumulate nel mondo al di fuori dei propri confini nordamericani. Ne è visiva testimonianza anche l’evoluzione delle rappresentazioni novecentesche della mappa – il logo – del paese.
Tuttavia gli Stati Uniti sono un impero, scrive Immerwahr – storico alla Northwestern University – nell’ultima riga del libro, a suggello della sua lunga, argomentata dimostrazione. Nessun arzigogolo. Nessun salto mortale da “antiamericano” vendicativo nei confronti delle proprie classi dominanti. Immerwahr non forza la realtà, mette in evidenza le contraddizioni che l’hanno attraversata e l’attraversano. Da buon divulgatore, mette in fila sia i fatti noti, sia quelli poco noti perché dati per scontati o ignorati dai più negli stessi Stati Uniti. Il suo è un discorso ampio, ricco di contestualizzazioni e di divagazioni interessanti, ma il filo è costituito dalle contraddizioni intrinseche a quello che definisce l’empire state of mind, l’ideologia imperiale del suo paese.
Gli Stati Uniti non sono, oggi, un impero simile ai precedenti storici, da quello romano a quello britannico. E quando gli si sono avvicinati hanno comunque seguito modelli acquisitivi ed espansionistici diversi, mostra Immerwahr. Di quello britannico, però, hanno adottato la giustificazione razziale, sposandola con quella Provvidenziale. A fine Ottocento, ne davano testimonianza le parole dello storico e senatore Albert Beveridge, per il quale era stato Dio stesso a gettare “su questo suolo il seme di un popolo forte… una razza conquistatrice… Un popolo imperiale per virtù della sua forza, per diritto delle sue istituzioni, per autorità dei suoi disegni ispirati dal cielo, un popolo che dona la libertà, che non vuole tenersela per sé”. Era il 1898, l’anno in cui gli Stati Uniti annettevano le Hawaii e sconfiggevano la Spagna a Cuba e a Manila, prendendole le Filippine e Guam, Puerto Rico e le Virgin Islands. Subito dopo si sarebbero presi anche la loro parte dell’arcipelago di Samoa. Oceano Pacifico e Caraibi.
È da lì che inizia davvero il libro di Immerwahr ed emerge la sua rilevanza. Le prime cinquanta pagine erano state una sintesi dell’espansione continentale degli Stati Uniti nell’Ottocento. A dire il vero, sono pagine piuttosto frettolose. Suscitano dubbi nel lettore sulla “consistenza” storica futura del discorso, che invece entra poi più decisamente nel merito innalzando la sua cura esplicativa e quindi la portata informativa. Mentre i primi due capitoli dicono quello che tutti sanno (comunque sempre un po’ meno di quello che dovrebbero sapere), il resto del libro dice gran parte di quello che gli stessi statunitensi non sanno o non sanno neppure di non sapere. In particolare, il fatto che a partire proprio dalla guerra con la Spagna, il loro paese ha istituito – e in parte ancora intrattiene – rapporti di tipo coloniale con altre entità territoriali.
Conquistato l’impero spagnolo – circa settemila isole nei due oceani, con più di 8,5 milioni di persone – e assunto il controllo su Cuba, formalmente indipendente, si apriva per gli Stati Uniti la “questione controversa… dell’impero”. I nuovi territori come le Filippine e Puerto Rico erano colonie, o erano parte degli Stati Uniti? I loro cittadini erano o no cittadini statunitensi? Valevano o no, per loro, le garanzie costituzionali? L’insieme delle questioni poste dai cosiddetti “casi insulari”, che alcuni riassumevano comunque sotto l’etichetta di questioni coloniali, ebbero alcune “sistemazioni” formali. La vincente fu che “una grande potenza mondiale che estende il suo dominio” dai ghiacci del Nord alle palme del Sud Pacifico “non dev’essere limitata da regole troppo rigide o troppo costrittive”. E all’inizio del Novecento la Corte suprema sanzionò quel principio fissando che la Costituzione riguardava soltanto gli stati; quindi, così come aveva fatto nei decenni precedenti con i territori dell’Ovest continentale, spettava al Congresso legiferare se e quando “incorporare o meno i nuovi territori”.

Ph William Egglestone.
In particolare, questa sembrava la prospettiva più probabile per le Hawaii (ma con molti dubbi, a causa della sua popolazione non bianca) e per l’Alaska, più adatte all’insediamento dei bianchi, e meno per il nero e meticcio Puerto Rico che, veniva scritto con il massimo di ambiguità, era “di pertinenza” degli Stati Uniti “in quanto possedimento”. Decisivo fu il secondo dopoguerra. Infatti, come è noto, Alaska e Hawaii diventarono stati (1959), mentre Puerto Rico rimase in una sorta di limbo istituzionale: a tutt’oggi fa parte degli Stati Uniti e i suoi abitanti ne hanno la cittadinanza, ma senza rappresentanti nel Congresso. Scrive Immerwahr con buona approssimazione: “In America nessuno sa che Puerto Rico è in America”. E il colore della pelle dei portoricani e la loro povertà rimarranno ancora a lungo ostacoli decisivi al mutamento del loro statuto.
Il libro tratta più estesamente la vicenda delle Filippine. Caso più importante e controverso degli altri sia per la loro importanza economica, sia per la densità della loro popolazione, sia per il succedersi dei drammatici passaggi di mano tra Spagna, Stati Uniti, Giappone e di nuovo Stati Uniti nel corso del primo Novecento. Al termine della Seconda guerra mondiale, dopo la conquista giapponese e i bombardamenti statunitensi, tra il 20 e 25 per cento degli edifici risultò distrutto o danneggiato e le vittime furono più di 1,6 milioni. Sebbene la guerra nelle Filippine sia stata “di gran lunga l’evento più distruttivo mai avvenuto sul territorio statunitense”, essa compare raramente nei testi di storia, conclude Immerwahr. Manila era stata anche, però, oggetto di ripetute promesse di indipendenza, prima della guerra. E avendo i giapponesi concesso l’indipendenza durante la loro occupazione, gli Stati Uniti non potevano fare marcia indietro. Le Filippine divennero indipendenti nel 1946.
Prese forma allora, grazie all’egemonia militare, economica e politica acquisita dagli Stati Uniti con la guerra (e grazie alla Guerra fredda), la struttura finale, attuale, dell’impero. Immerwahr lo chiama “impero puntillista”: non macchie di colore – come il rosso britannico sulle carte geografiche – distribuite su tutto il globo e collegate tra loro da un’unica rete di cavi per le comunicazioni interimperiali, ma una rete di punti sparpagliati nei luoghi strategici e sempre più collegati tra loro via etere. Durante la guerra, gli Stati Uniti “possedevano la cifra sconvolgente di trentamila impianti su duemila basi oltremare”. Dopo, se da una parte i movimenti anti-imperialisti impedirono a chiunque anche solo di immaginare la possibilità di acquisire nuove colonie, dall’altra, fu proprio quella presenza diffusa a suggerire i nuovi modi per “proiettare potere in tutto il pianeta”. Non nuovi “possedimenti”, dunque, ma egemonia economico-militare (e, non trascurabile, linguistico-culturale), accordi e trattati, basi militari in territori propri oppure in nazioni ospitanti, con estensioni, autonomie ed extraterritorialità diseguali. E certo, sempre, anche guerra; anch’essa però combattuta in modi diversi dal passato.
Le basi in casa altrui possono essere un problema. Tre esempi. Non lo costituisce la più nota, Guantanamo, nonostante sia da oltre cent’anni una enclave ritagliata per contratto sulla costa di una Cuba nel frattempo uscita dall’orbita statunitense. Differenti invece sono i casi della base di Okinawa, dove i militari statunitensi hanno suscitato nel corso dei decenni tensioni sempre più forti con la popolazione locale e con il Giappone, e delle impreviste conseguenze del mantenimento delle basi in Arabia Saudita dopo la fine della guerra irachena del 1990-91. Come è noto, la presenza militare statunitense è stata più volte indicata come prima responsabile dell’organizzazione di al-Qaida e dei vendicativi attentati del settembre 2001 negli Stati Uniti. E delle guerre che l’impero ha combattuto in Asia dopo il 2001.
“Prigioni straniere, zone recintate, basi nascoste, isole-colonie, stazioni GPS, attacchi mirati, reti, aerei e droni: sono questi”, scrive Immerwahr, “i luoghi e gli strumenti della guerra al terrore ancora in corso. Questa è la forma attuale del potere. Questo è il mondo creato dagli Stati Uniti”. I possedimenti oltremare, siano esse le sperdute isolette del Pacifico o le basi possedute o affittate in paesi terzi, sono essenziali per l’esistenza dell’impero; sono, per così dire, l’assistente non dichiarato che siede accanto ai politici statunitensi quando discutono, minacciano, trattano con i loro simili. Gran Bretagna e Francia, riassume Immerwahr, hanno complessivamente tredici basi all’estero; la Russia ne ha nove e altri paesi ne hanno una: sono una trentina le basi non appartenenti agli Stati Uniti. Invece gli Stati Uniti, oggi, “ne possiedono circa ottocento, e ci sono accordi che consentono loro l’accesso a ulteriori zone straniere. Quelli che si rifiutano di farlo ne sono comunque circondati. I Grandi Stati Uniti, in altre parole, sono i vicini di casa di tutti”. Molti statunitensi non lo sanno e tanti, tra i “vicini”, neppure. In condizioni normali l’impero si mantiene sotto traccia, nel logo non compare.