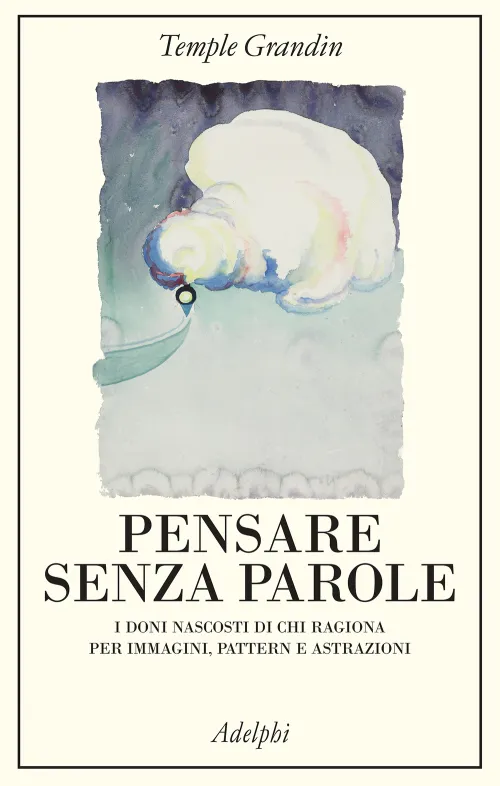Perché non capiamo gli animali
Come scriveva nel Traité des animaux del 1755 il filosofo Étienne Bonnot de Condillac: “le bestie […] non sono degli automi: provano sensazioni” e di conseguenza “se sentono, sentono come sentiamo noi”; non servivano le neuroscienze, come invece vuole la moda, per farci scoprire che gli animali, appunto, provano sentimenti (le neuroscienze ci ridicono in inglese quello che la filosofia, in altre lingue, scriveva già da secoli). Appunto, le ‘bestie’ – “bestia” è un termine tecnico, significa un vivente privo di linguaggio composto di parole e frasi, come quello delle lingue umane – hanno sentimenti, provano emozioni, a loro modo pensano. Tutto sta a intendersi sulla locuzione preposizionale ‘a loro modo’. Perché che gli animali pensino, a loro modo, appunto, non ci sono dubbi, da Aristotele in poi nessuno ne ha mai veramente dubitato (in fondo lo stesso bistrattatissimo Cartesio lo sapeva perché quando sosteneva che gli animali fossero delle macchine voleva proprio mettere in evidenza che il loro modo di pensare è diverso da quello degli esseri umani; da notare che al tempo di Cartesio già esistevano le prime macchine calcolatrici, cioè appunto dispositivi non viventi capaci di pensare. Perché non solo gli animali pensano, com’è ormai evidente pensano anche le macchine). Gli animali non umani pensano, allora, anche se pensano in un modo diverso da quello tipico della maggioranza degli esseri umani, quello che lo psicologo sovietico Vygotskij chiama “pensiero verbale”, ossia appunto un pensiero fatto di parole e discorsi (anche gli animali non umani dispongono, a loro modo, di un qualche linguaggio; a proposito, Condillac lo chiamava “linguaggio d’azione” per differenziarlo da quello umano). Con una precisazione importante: il pensiero verbale non è un pensiero che si esprime attraverso le parole, è un pensiero inseparabile dalle parole. Si tratta di un pensiero in cui si fondono in modo inestricabile il pensiero non linguistico – quello che Temple Grandin, l’autrice di Pensare senza parole. I doni nascosti di chi ragiona per immagini, pattern e astrazioni (Adelphi 2025) – chiama “pensiero per immagini” e quello, appunto, intessuto di linguaggio, quello che lei infatti chiama pensiero “per parole” (p. 19).
Da notare che per Grandin il pensiero cosiddetto “per immagini” non è una caratteristica esclusiva degli animali non umani: è anche il pensiero degli esseri umani molto piccoli, più o meno fino ai due anni d’età (infanzia viene dal latino infans, composto da in- e fans, participio presente di fari, ‘parlare’: l’infans è quindi chi non parla), ma è anche il pensiero di tutta una parte dell’umanità che pensa in modo “neurodivergente” (fra cui la stessa Grandin), pensa cioè in un modo non standard, ossia prevalentemente per immagini anziché per parole. Pensare senza parole allora è prima di tutto – ed è forse il suo pregio maggiore – un elogio delle diversità cognitive, e quindi delle diverse forme di vita umane: non esiste un modo ‘normale’ di pensare, che sarebbe poi quello logico-linguistico (quello che si insegna a scuola), esistono piuttosto tanti modi diversi di pensare, alcuni così diversi da rendere la vita molto difficile (è il caso delle forme più estreme di autismo), altre che invece esplorano modalità cognitive non inferiori o peggiori, ma solo appunto diverse da quelle che gli ormai onnipresenti test considerano invece l’unico ammissibile, quello appunto considerato standard. Il punto è che per la maggior parte degli esseri umani, che nascono senza linguaggio, succede che “a poco a poco, il linguaggio prende il sopravvento. A un anno e mezzo, buona parte dei bimbi avrà nel proprio corredo un gruzzolo di sostantivi e verbi, e a due anni inizia a comporre frasi” (p. 11). Questo passaggio rappresenta molto di più che una tappa nel processo di sviluppo dei piccoli umani; in realtà marca una vera e propria soglia antropologica, perché il modo di stare al mondo di un infans (che poi, come scrive la stessa Grandin, in fondo non è così diverso da quello di un mammifero non umano) è completamente diverso da quello che lo stesso umano avrà una volta che il ‘suo’ cervello sarà stato completamente riplasmato dal linguaggio (Grandin non lo cita, perché cita poca filosofia, ma la sua tesi è molto simile a quella di Heidegger, per non parlare dello psicoanalista Jacques Lacan). Mentre il pensiero “per immagini” è un pensiero associativo, globale ma anche concreto, incapace di ragionare per astrazioni (è un pensiero che infatti non si trova a suo agio con la matematica), il pensiero “per parole” invece “tende a comprendere le cose secondo un ordine” (p. 19); non a caso Condillac definisce questo pensiero “analitico”, nel senso che è un pensiero che divide, separa, spezzetta il mondo in entità discrete. È evidente che il mondo di chi pensa per immagini sarà molto diverso da quello che pensa per parole, per non parlare di quello che lo pensa attraverso i numeri.

Grandin considera una delle cause principali della decadenza dei sistemi educativi, e di conseguenza lavorativi, contemporanei – soprattutto di quello statunitense, che purtroppo è ancora preso a modello in tante altre nazioni – proprio nel privilegio assoluto accordato al pensiero “per parole”, che infatti è l’unico che si possa misurare attraverso test standardizzati. In effetti Pensare senza parole è, prima di tutto, un motivato e documentato atto d’accusa contro il sistema dei test, che non è un modo per valutare le conoscenze, come possono credere solo gli sprovveduti, bensì un modo per stabilire d’autorità come (e cosa) si debba pensare: “possiamo generare una forza lavoro del ventunesimo secolo fatta di persone con o senza lauree universitarie, con pensatori verbali e visivi e con il neurodiverso? Possiamo smettere di guardare ai test e promuovere l’apprendimento? Possiamo prendere i nostri visualizzatori spaziali e di oggetti e offrire loro percorsi scolastici e lavorativi che si avvalgano dei loro punti di forza?” (p. 141).
Grandin non parla di sistemi economici, ma è evidente che il privilegio accordato al pensiero misurabile non è tanto, né principalmente, una questione pedagogica, ma appunto economica: il pensiero per numeri e test è il pensiero del capitalismo, il pensiero che non vede l’insieme ma solo il dettaglio computabile, il pensiero valutabile, quello dei costi e dei benefici (quello dei voti e dell’eccellenza). Rivalutare, e non solo a scuola, il pensiero “per immagini”, che poi semplicemente è il pensiero non calcolante, significherebbe rivalutare un modo di stare al mondo completamente diverso da quello dominante. E qui torna la questione animale. Pensiamo al modo in cui un piccolo umano si avvicina al mondo non umano: non c’è traccia in lui di antropocentrismo, animali e non viventi sono per lui interlocutori esattamente allo stesso modo degli esseri umani. Se fosse per il pensiero infantile l’antropocene non sarebbe mai cominciato: “la tendenza a percepire gli animali come completamente ‘altri’ aumenta con il predominio del pensiero verbale, sia negli individui sia nelle varie culture. È possibile che, al crescere della coscienza verbale, insieme con l’uso della parola e del linguaggio scritto, il nostro rispetto per gli animali sia diminuito, e che sia mutata la comprensione che abbiamo di loro” (p. 273). In effetti pensare “per parole” significa anche, ed è l’aspetto meno considerato, sentire per parole: il piccolo umano che prima si avvicinava senza problemi a un vivente non umano a un certo punto comincia a pensarlo come un “animale” (l’animot di cui parla Derrida), ossia a partire da una astrazione, e così l’animale in carne ed ossa svanisce. Il mondo pensato, cioè detto, prende il posto di quello corporeo e sensibile: “i bambini perdono parte della loro immaginazione visiva alla comparsa, e poi al sopravvento, del linguaggio verbale. Pensatori visivi come me […] entrano in contatto con gli animali perché le parole non sono il mezzo principale con cui essi comunicano. Per i pensatori totalmente verbali, il pensiero visivo è quanto mai complicato da concepire” (p. 304).
Ecco perché, allora, non capiamo gli animali, malgrado tutto l’amore che molti dicono di provare per loro: perché il modo prevalente di pensare, e quindi di agire e sentire, è un modo che rende impossibile quella vicinanza corporea che è invece la caratteristica distintiva del pensiero “per immagini”, e senza la quale l’animalità ci rimarrà sempre estranea. Non si tratta di capire gli animali (perché non c’è proprio niente da capire, se non che il loro modo di stare al mondo è diverso dal nostro), si tratta di sentire il mondo non umano in un modo radicalmente diverso da quello che il sistema economico in cui viviamo ci impone di pensare. Occuparsi del pensiero “per immagini” significa allora aprire l’immaginazione a un modo diverso di stare al mondo: “il maggiore ostacolo per comprendere il pensiero visivo è non sapere che tale pensiero esiste” (pp. 269-270). Un “ostacolo” che “è ancora più evidente quando cerchiamo di comprendere la vita interiore degli animali. […]. Essi vivono – e pensano – attraverso i sensi. E privi come sono di un linguaggio verbale, archiviano i ricordi di esperienze vissute sotto forma di immagini, suoni, odori, sapori o ricordi tattili. Il pensiero e i ricordi basati sui sensi sono rievocazioni di esperienze senza parole” (p. 270). Grandin non lo dice (ma non conosce la filosofia, come abbiamo visto), ma ci sta dicendo che quella di cui abbiamo bisogno è una vera e propria svolta antropologica (e, visto che si occupa tanto del linguaggio, di un linguaggio più vicino alla poesia): si tratta non di amare gli animali, ma cominciare a sentire il mondo come lo sentono i bambini, i neurodivergenti (sì, quelli che una volta venivano chiamati matti) e soprattutto gli animali. La salvezza è nei gialli occhi e impenetrabili di un gufo.