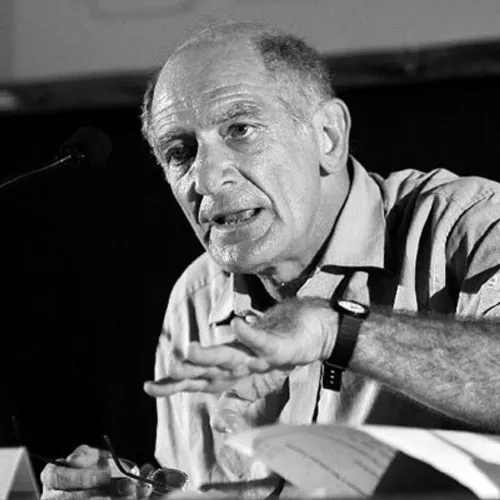Paolo Virno, l’esuberanza del possibile
Secondo la famigerata undicesima tesi su Feuerbach di Karl Marx “i filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo ma si tratta di trasformarlo”. Questa tesi non dice che i filosofi fanno solo chiacchiere, dice piuttosto che i filosofi trasformano il mondo interpretandolo (quello che questa tesi asserisce si applica, infatti, anche e soprattutto a sé stessa, così istituendo una nuova possibilità di cambiare il mondo attraverso il pensiero). In effetti ogni nuova interpretazione cambia il mondo, perché ogni nuovo sguardo teorico schiude possibilità d’azione che prima di quella nuova interpretazione erano invisibili. Questo fanno i filosofi, cambiano il mondo inventando concetti, quindi azioni, che prima di loro non sembravano praticabili. Questo ha fatto in tutta la sua vita Paolo Virno.
Perché Paolo Virno è (stato) un filosofo. Nella vita pubblica Virno è conosciuto come un militante rivoluzionario, come un uomo con un carisma straordinario, come un amatissimo professore universitario (ha insegnato Filosofia del linguaggio all’Università della Calabria e all’Università di Roma3), ma è stato soprattutto un filosofo. L’oggetto intorno a cui non ha mai smesso di pensare è stato il linguaggio. Perché, come scrive nelle prime righe di Quando il verbo si fa carne (Bollati Boringhieri, 2003), la “facoltà di linguaggio” coincide con “la natura umana”. Se si vuole capire il modo in cui vivono gli esseri umani, e provare a cambiarlo, bisogna partire da ciò che rende umana questa vita, ossia appunto dal linguaggio. È a partire dall’identità fra “facoltà di linguaggio” e “natura umana” che proveremo a ripercorrere alcune delle linee di sviluppo principali di questo pensiero.
L’animale umano è umano perché è capace di linguaggio, perché parla pensa si emoziona desidera ricorda ama combatte nel linguaggio (non attraverso il linguaggio, ma proprio nel linguaggio: questo vuol dire, letteralmente, che il verbo, cioè appunto il linguaggio, diventa la carne dell’animale umano). Non è che l’essere umano, oltre alle sue altre caratteristiche, possiede anche quella di usare una lingua: è questa stessa capacità, allo stesso tempo culturale (l’umano viene al mondo come infans, senza parola appunto) e naturale (non si può insegnare a parlare ad un cane, per quanto sia un animale intelligente), che caratterizza la forma di vita specificamente umana.
Partiamo dalla questione centrale della prassi e della vita di Virno, la dimensione intrinsecamente politica e conflittuale dell’esistenza umana. La riflessione teorica di Virno è mossa dal desiderio di lottare per il comunismo – che, come dice all’incontro Chi sono i comunisti – Conferenza di Roma sul Comunismo C17 del 2017, consiste propriamente da un lato nel battersi contro “quella barbarie moderna che è il lavoro salariato” e dall’altro nella “valorizzazione spasmodica di tutto ciò che vi è di unico e irripetibile nell’esistenza di un singolo membro della specie” umana; da qui deriva la centralità che nel suo pensiero occupa la politica come lo spazio dove queste radicalmente diverse individualità sono in relazione. Per essere più precisi: lo spazio politico è la forma di vita umana. Di conseguenza solo una filosofia che tematizzi la centralità della politica, e quindi appunto del conflitto (perché gli individui sono tutti diversi), è in grado di incidere sulla vita degli esseri umani. La caratteristica distintiva del linguaggio è dischiudere l’accesso al “possibile”, il fatto che il corpo umano è abitato da una potenza – la facoltà del linguaggio – che non si limita a ‘dire’ il mondo com’è, ma ininterrottamente produce mondi possibili fra loro alternativi, dal momento che, come scrive in Motto di spirito e azione innovativa (Bollati Boringhieri 2005), “l’animale umano è in grado di modificare le sue forme di vita, divergendo da regole e abitudini consolidate”, ossia, “l’animale umano è ‘creativo’” (p. 7): non c’è un solo modo – quello capitalistico – di essere umani. L’inevitabilità del conflitto, e la sua produttività (il comunista, dice in quello stesso intervento, è “radicalmente antimonopolistico” perché il comunista “vuole fare a pezzi il monopolio della decisione politica”), sono la diretta conseguenza della natura umana, che è appunto quella di un vivente del possibile, cioè del cambiamento e della trasformazione: “la politica non è una forma di vita fra le altre, […] fa corpo con lo stesso avere linguaggio. Una e medesima è la configurazione biologica che consente di parlare e spinge ad agire politicamente” (Quando il verbo si fa carne, p. 32).
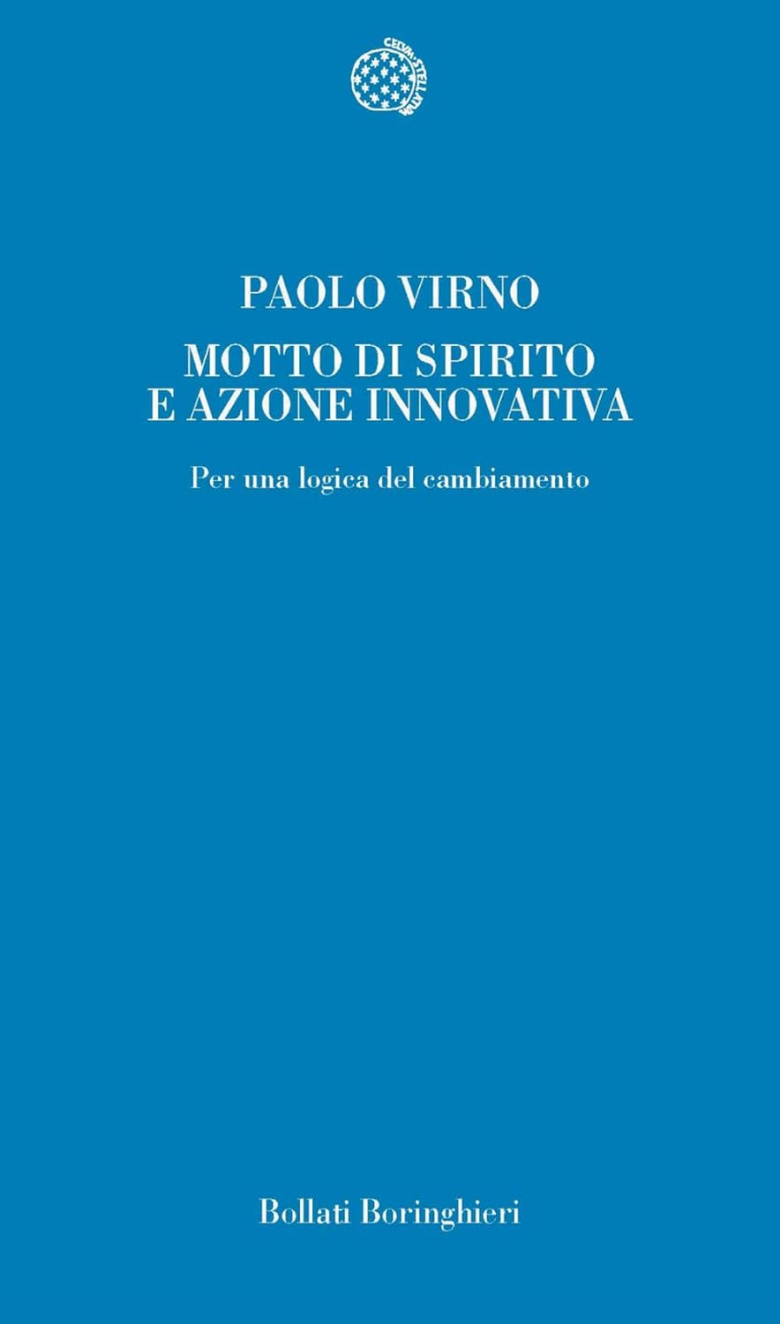
In E così via, all’infinito. Logica e antropologia (Bollati Boringhieri, 2010), Virno definisce più in particolare quali siano le caratteristiche – allo stesso tempo antropologiche e logico-linguistiche – della vita umana: “la chiave di volta di una antropologia materialistica, che resti in sintonia con la teoria dell’evoluzione e però sia in grado di rendere ragione del funzionamento delle istituzioni politiche o del significato dei riti religiosi, consiste in tre fondamentali categorie logiche: la negazione, la modalità del possibile, il regresso all’infinito” (p. 9). Ritorna qui l’intreccio che ha sempre caratterizzato il suo pensiero, allo stesso tempo teorico e politico: “propriamente umano è l’animale capace di introdurre la paroletta ‘non’ in qualsiasi proposizione; quello, cioè, capace di dire come non stanno le cose”. In effetti che cos’è la politica se non appunto la capacità di dire non come il mondo è – mentre al momento l’unico mondo ammesso è il mondo del capitalismo – bensì come il mondo non è, e come potrebbe essere altrimenti? La paralisi politica del nostro tempo nasce proprio dal fatto che il pensiero non si permette più di essere politico, cioè conflittuale, ossia in grado di pensare il possibile: la paralisi che rende la sinistra del tutto incapace di incidere sui problemi del mondo contemporaneo deriva, alla fine, proprio dal fatto che non è più capace di dire ‘no’ al capitalismo (seguendo Virno, è una paralisi conseguente all’abbandono del comunismo come prospettiva di una forma di vita radicalmente alternativa a quella esistente). Perché, come scrive in Parole con parole. Poteri e limiti del linguaggio (Donzelli, 1995), il “possibile palesa un’inoppugnabile asimmetria (o esuberanza, o primogenitura) nei confronti sia del ‘necessario’ che dei valori di verità” (p. 129). È l’esuberanza del possibile, allora, il tema della filosofia di Virno.
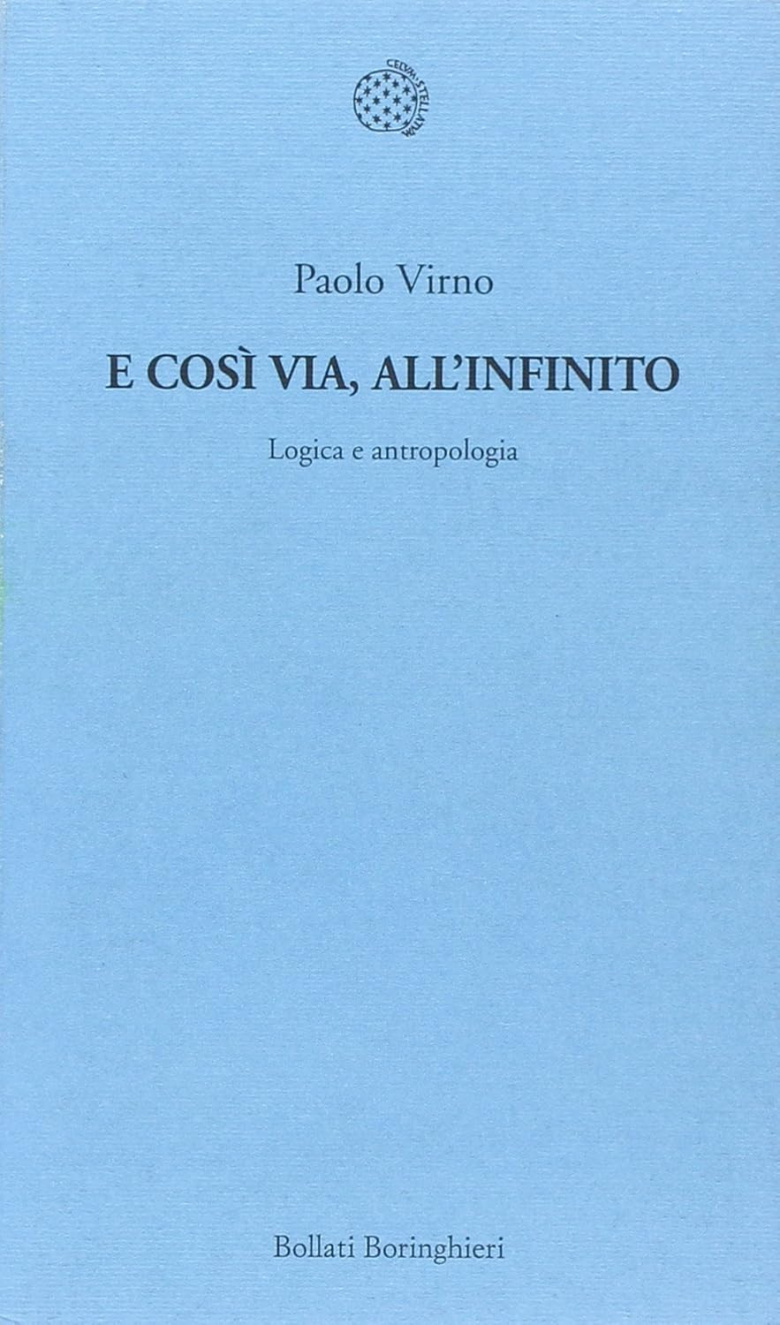
La negazione è il dispositivo logico-linguistico che apre l’esistenza dell’animale umano al possibile. Per questa ragione la nozione fondamentale del pensiero di Virno è allora la ‘negazione’, perché – come scrive nel Saggio sulla negazione. Per un’antropologia linguistica (Bollati Boringhieri, 2013) – “l’indagine sulla negazione linguistica è, fin dal principio […] un’indagine antropologica” dal momento che attraverso la negazione si può rendere conto della “capacità di distaccarsi dagli avvenimenti circostanti e dalle pulsioni psichiche”, come anche “dell’alternarsi di inibizioni e disinibizioni non prescritte da strategie di adattamento all’ambiente, il bisogno di riti e istituzioni, l’ambivalenza degli affetti, l’abitudine a trasformare repentinamente le condotte più abituali” (p. 9). Fare politica significa dire ‘no’ al mondo com’è, ossia attestare la propria umanità, perché l’umano – in quanto animale del linguaggio – è il vivente del possibile, ossia non di ciò che è, bensì di ciò che potrebbe essere. Allo stesso, siccome l’antropologia dipende dalla logica, questa apertura al possibile è sempre sul punto di diventare fine a sé stessa, ossia nell’essere pura potenzialità che non diventa mai azione: “l’impotenza contemporanea”, scrive nell’ultimo libro pubblicato in vita, Dell’impotenza. La vita nell’epoca della paralisi frenetica (Bollati Boringhieri, 2021), “consiste nel pieno possesso di una potenza che, però, recalcitra a passare all’atto quando questo passaggio è previsto, opportuno, ricercato. Non si ha a che fare, quindi, con la penuria o l’eclissi di una capacità, ma con la duratura inibizione del suo esercizio effettivo” (p. 11).
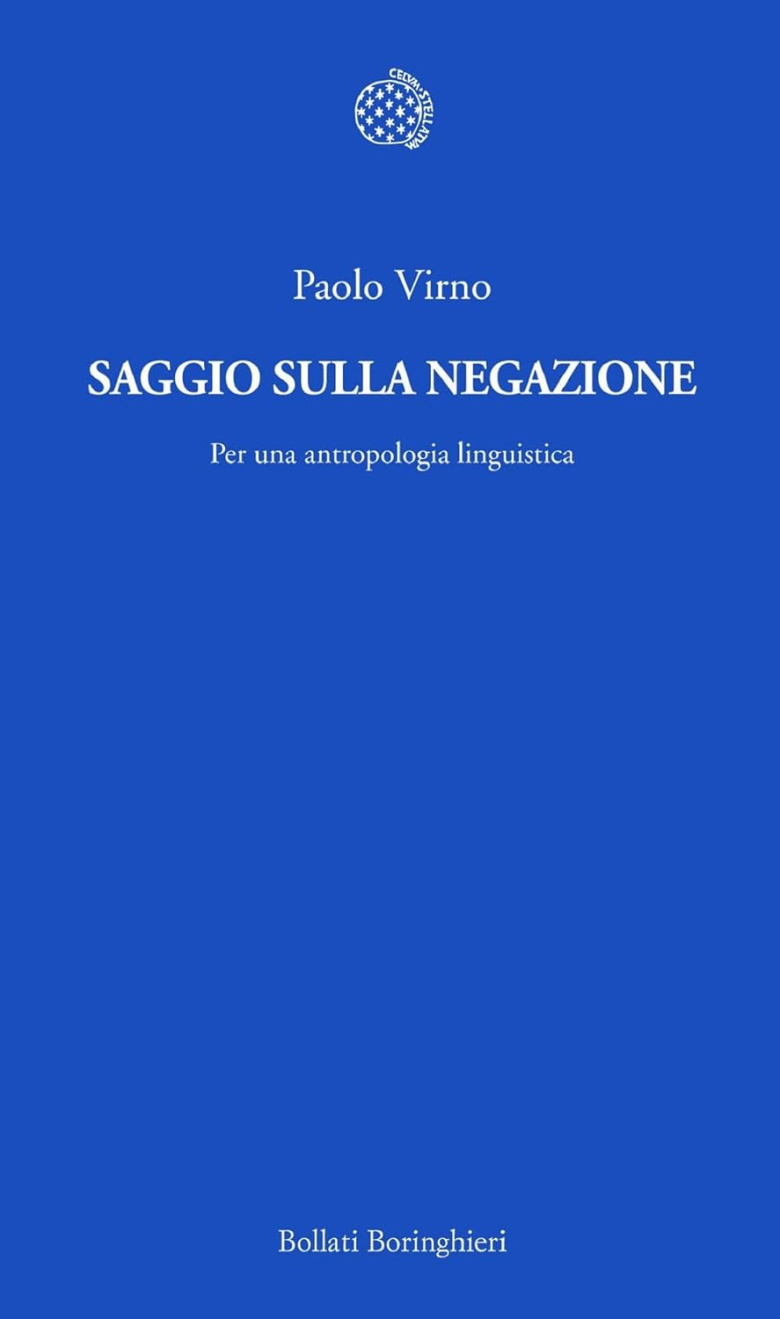
L’immagine dell’umano che risulta da queste considerazioni è quella di un vivente intrinsecamente decentrato, perché sempre abitato e percorso da potenze (il possibile, la negazione, il regresso all’infinito) che non smettono di proiettarlo oltre e fuori di sé. È questa condizione che viene analizzata in dettaglio in Avere. Sulla natura dell’animale loquace (Bollati Boringhieri, 2020). Basta osservare un gatto, e si capisce che c’è una differenza radicale fra essere un esemplare della specie Homo sapiens e uno della specie Felis catus. Pensiamo ad uno di quei gatti di casa supernutriti e castrati, il cui ventre appesantito quasi sfiora il pavimento. Il gatto è obeso, ma il gatto non se ne preoccupa, perché il gatto non si guarda né si prende cura di sé. Tutto sembra portarci a credere che il gatto non sappia di essere un gatto, accontentandosi di essere un gatto. Il gatto è solo il gatto che è, questo vuol dire essere un animale (non umano). In una condizione simile anche l’essere umano più trasandato si rende conto di essere molto, troppo grasso, e sa che dovrebbe mettersi a dieta (poi la dieta non la comincia, ma comunque sa che dovrebbe farla). Ma questo significa che questo vivente si osserva, e osservarsi dall’esterno vuol dire che l’umano non coincide con il proprio corpo. In effetti già parlare del ‘proprio’ corpo presuppone una distanza fra il corpo e chi quel corpo in qualche modo lo possiede; è questo il fondamentale dualismo che taglia l’umano da sé stesso, “la mancata coincidenza dell’Homo sapiens con la sua natura” (p. 11) è la caratteristica distintiva degli esseri umani: “filo conduttore di ogni indagine sulla natura umana è il dualismo preliminare e persistente da cui è segnato l’Io che ha sé stesso” (p. 131). L’Io non è sé stesso, così come il gatto è immediatamente il gatto che è, l’Io ha sé stesso, come ha un corpo, dei pensieri, delle speranze, delle paure: c’è allora un “dualismo originario” (p. 132), questo dualismo è la natura umana, ossia questa insuperabile “relazione estrinseca che l’animale umano intrattiene con le facoltà e le prerogative dalle quali è permeato” (p. 153).
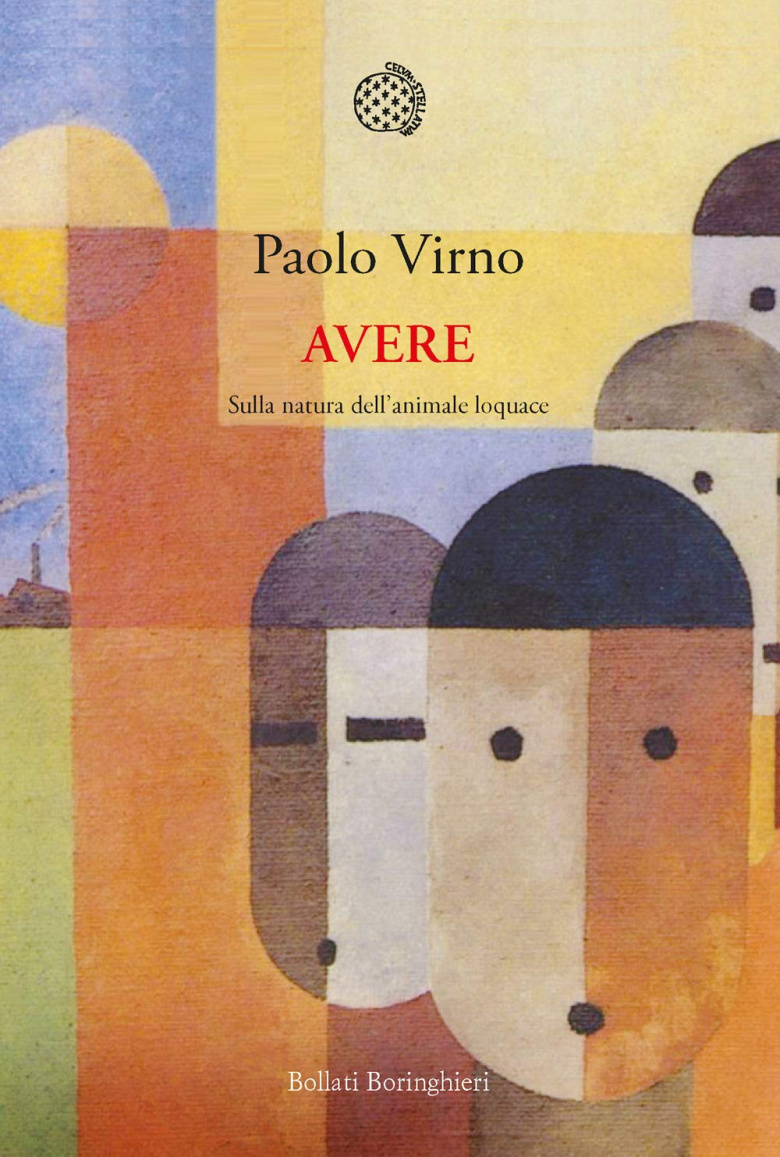
È umano allora quel vivente che non si limita ad essere quel che è, come succede al gatto felicemente obeso, bensì chi non fa che ridefinire il rapporto con la propria stessa natura biologica, con il ‘proprio’ corpo e ciò che lo rende umano. In questo senso essere umani significa non coincidere mai con la propria natura. E qual è il fondamento di questo dualismo? La risposta di Virno è ancora la stessa: nella facoltà del linguaggio, dal momento che il “singolo elemento della nostra essenza […] che ci obbliga a instaurare una connessione estrinseca con la totalità di tale essenza […] è il linguaggio verbale” (p. 42). È a partire da questa estraneità di sé a sé, infine, che Virno ragiona dell’amicizia come della condizione in cui, attraverso l’estraneità dell’altro, riusciamo ad essere in contatto con la nostra radicale estraneità a noi stessi: “affinché possa imbattersi in un héteros autós, in un altro sé stesso, è necessario che l’animale umano sia già da sempre héteros, altro o diverso, rispetto a sé stesso” (p. 58). Essere estranei per essere intimi, essere lontani per essere vicini, questo fanno i filosofi, questo fanno per Virno gli amici. La sua filosofia continuerà ad esserci amica, la sua voce a risuonare con noi. Come scrive il poeta Velimir Chlebnikov (la traduzione è di Angelo Maria Ripellino): “quando muoiono i cavalli respirano, / quando muoiono le erbe seccano, / quando muoiono, i soli si spengono, / quando muoiono, gli uomini cantano”.
Leggi anche:
Gabriele Pedullà, Paolo Virno, ritratto di un filosofo
Alessandro Foladori, Paolo Virno. L’idea di mondo
Annalisa Ambrosio, Un libro di paolo Virno / Avere
Michele Pavan, Per una filosofia affermativa
Nicola Turrini, Il sabotaggio dell’empatia