Scuola: le nuvole di settembre
Settembre è di nuovo qui. Da giorni il ritmo nelle strade si è intensificato e per chi ha a che fare con il mondo-scuola – studenti, docenti, genitori – ci sono tutti i segni del ritorno alla piena attività. L'anno scolastico è iniziato il 1° di settembre e con il primo giorno di scuola si riavvia il sistema. Un sistema che comincerà ad accelerare per frequenza, intensità e densità dell'impegno; ora è ancora lento, anticipato dagli esami di riparazione nelle secondarie superiori, un momento non privo di amarezze, e dalle prese di servizio nelle sedi di destinazione e dalle riunioni di funzionamento e programmazione. Ci sono nuovi inizi per docenti (ma anche studenti), trasferimenti e promesse di serenità per chi è in fuga da qualcosa, il ritrovarsi per chi riprende la routine e si ripromette di evitare errori e trappole dell'anno precedente, di migliorare le condizioni e aumentare le soddisfazioni. Simile a un capodanno, settembre porta bilanci, previsioni e propositi, commenti, analisi e annunci. L'anno scolastico passato è finito senza finire, lasciando in sospeso questioni che hanno aspettato, come uccelli neri sui cornicioni delle case e delle strade.
Polemiche sull'esame di Stato e annunci del nuovo assetto della maturità hanno caratterizzato il dibattito pubblico tra giugno e luglio: i rifiuti di sostenere l'orale per protesta (di cui si è letto), pur nella semplificazione e sovrarappresentazione, testimoniano un clima di sfiducia che alimenta il conflitto, vero o presunto, tra studenti e docenti e rafforzano il partito trasversale della scuola più severa e la linea ministeriale che ne ha fatto una questione di principio. Il precedente tipo di esame era senz'altro ambiguo, stanco e consunto: come per ogni cosa, quando non ha funzionato è perché le regole di svolgimento non sono state condivise o adeguatamente messe in atto. Sottolineo quando, perché le esperienze sono molto diversificate e ve ne sono anche di positive, oscurate dalla dominanza dei discorsi di lamentazione. La scuola con il suo carattere iperonimo non è squadrabile da ogni lato, non lo è mai stata e ora lo è meno che mai, e penso possa essere raccontata con onestà solo per storie e frammenti che non abbiano pretesa di universalità.
Quando gli esami non hanno funzionato, contraddicendo l'andamento precedente, le ragioni possono essere più o meno queste (in modalità e/o): i consigli di classe non sono stati in grado di lavorare sull'affinamento di competenze per condurre un percorso a partire dall'analisi di documenti; i docenti di commissione hanno interrogato su conoscenze, magari capziose, al posto di ascoltare le rielaborazione degli studenti; criteri valutativi di esterni e interni sono risultati anche molto eterogenei; i presidenti non sono riusciti a garantire equilibrio nelle commissioni. Alcuni hanno cercato nell'esame qualcosa che parlasse di loro o delle scuole in cui si sono ritrovati, ne hanno fatto questioni private o banchi di prova di concezioni generali del mondo e della vita. E ancora: molti studenti e studentesse sono arrivati poco preparati, con fragilità o troppo stanchi a giugno, non sono stati in grado di reggere programmi intensi e ripassi sistematici stretti tra i tempi aleatori e il caldo opprimente; non hanno saputo selezionare e individuare i criteri di rilevanza del materiale a loro riservato e – complici i tri(s)ti suggerimenti dei siti per studenti e dei supporti digitali – si sono infilati in collegamenti stereotipati, che soffrono di sintesi della sintesi e di una lettura anacronistica. Peso psicologico della prova, ripetitività delle scelte, compressione dei tempi, desiderio di finire presto e presenza dei biases umani fanno il resto.
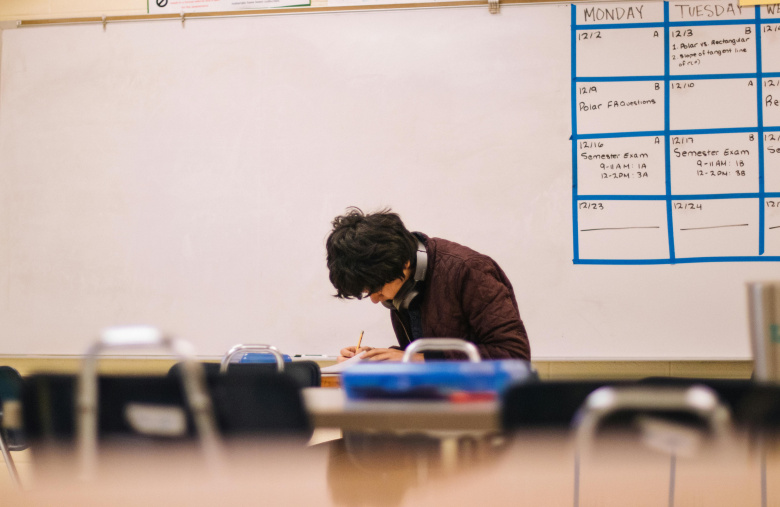
Così, nei casi infelici i voti e il disallinenamento tra sistemi valutativi, aspettative e personalità, hanno finito per non restituire il percorso di crescita degli studenti né il riconoscimento della professionalità docente e hanno contribuito a rendere più profondo il fossato tra vita scolastica e quello che succede dopo, lasciando una tonalità di frustrazione, sfiducia e delusione che rischia di stingere sugli anni precedenti e su quelli futuri, tanto più se le scelte motivazionali di orientamento non sono ancora mature, consapevoli o sentite come proprie. Questo sentire, che mi pare diffuso e che ho raccolto in diversi commenti e scambi, porta molti a pensare che l'esame non serva più, vada eliminato e limitato al solo scrutinio finale e poco più, magari un'esposizione conclusiva su un elaborato di taglio originale e creativo (questa è la mia personale opinione) che abbia anche una funzione simbolica.
Quello che si sa del nuovo esame, forgiato dal bisogno di evitare la lesa maestà della scena muta nell'orale e da un'idea di scuola più difficile e autoritativa riguarda innanzitutto il nome “maturità”, che dovrebbe corrispondere maggiormente al divenire adulti. Diminuiscono i membri della commissione (da sette a cinque), sono previsti un presidente più due membri interni e due esterni; rimangono i due scritti e punteggio in centesimo ma vengono ridotte le materie oggetto di esame a quattro (indicate dal Ministero per ogni indirizzo a gennaio) e scompare il documento iniziale di spunto per l'orale. Ampio spazio viene dato al curriculum/portfolio dello studente, ai percorsi extracurriculari e di orientamento come i Pcto, già Alternanza scuola-lavoro e ora Formazione scuola-lavoro. A ispirare la riforma dell'esame – stando alle fonti – è dunque una maggior attenzione alla persona, alla sua autonomia e responsabilità, e alla dimensione esperienziale. Restiamo in attesa del testo definitivo, con il disincanto di chi dovrebbe sapere che i dispositivi di legge assumono le forme che le prassi esegetiche di circolari applicative, uffici scolastici regionali, sindacati, collegi e docenti gli daranno. Si tratta insomma di capire come l'indirizzo normativo reagirà con la burocratizzazione che investe ogni pratica formalizzata e standardizzata, da rodare e incerta all'esordio, e con il residuo delle consuetidini precedenti; e si tratta di vedere come la coorte generazionale dei nati nel 2007 soggettiverà il rito di passaggio a partire dalle proprie e altrui ambizioni, aspettative e dai tanti miti che si producono a più livelli nelle sottoculture studentesche alimentate dal brusio di fondo di stampa e social media.
Potrebbe non essere peggio di come è andata finora, anche se a giudicare dalle prime reazioni le premesse non suggeriscono ottimismo. L'insistenza sullo svolgimento della prova orale mostra un'intenzione punitiva contro la scena muta, rendendo surreale distinguere nello studente la presa di posizione dall'incapacità o dal blocco psicologico, con una presa di posizione che innanzitutto cristallizza un comportamento minoritario e lo stilizza come possibilità, rafforzando così il potere del rifiuto nel momento in cui lo sanziona e facendone una sorta di reato di opinione. Tale divieto che si fregia del diritto automatico alla bocciatura è anche sintomo di impotenza verso il gesto di disobbedienza e comunica in termini relazionali e pedagogici il rifiuto della disponibilità a comprendere l'adolescenza contemporanea con la sua feroce complessità. Inoltre l'eterogeneità a geografia variabile della parte esperienziale svolta negli anni e la sua complessa documentabilità potrebbero rafforzare le differenze di opportunità e di valutazione tra territori e indirizzi, senza contare lo scivolamento retorico che spesso accompagna le modalità di restituzione delle competenze acquisite.
Ma c'è molto altro. Di grande importanza è la questione dell'insegnamento della storia, in particolare quella contemporanea, in rapporto con la politica: le nuove Indicazioni nazionali e l'annunciato controllo sui manuali scolastici accusati di essere di parte (anche questo ha animato le cronache estive) mostrano come la memoria pubblica sia oggetto di grande impegno per la destra di governo che, in base alla sua concezione di egemonia culturale, si declina nell'idea di una scuola nazionale che “insegni l'Italia” e l'“Occidente”. Rivolte al momento alla scuola primaria e secondaria di primo grado (ma è ragionevole immaginare il seguito), le linee guida ministeriali sono state criticate da docenti e associazioni scientifiche di categoria e dal Consiglio superiore dell'Istruzione tanto per gli aspetti epistemologici quanto per l'alto tasso ideologico e, a dispetto delle dichiarazioni sulla disponibilità al dialogo, sono rimaste identiche alla loro prima formulazione. È facile prevedere l'inasprirsi della dinamica da “guerra culturale” e l'intensificazione del divario di reazioni tra conformismo e contestazione: la postura neonazionalista e identitaria a cui si vuole intonare la scuola, che ha tratti monumentali e d'antan, metafisici e personalisti, aziendalisti e neoliberali, confligge con le tradizioni di lungo periodo della scuola democratica e con i diversi programmi di Educazione civica elaborati negli anni nei diversi contesti e in base all'Autonomia scolastica. A fronte delle molte crisi del presente un cambio di passo non è più rinviabile ma in senso radicalmente democratico nei contenuti e nei metodi con più apertura a differenze, mondialismo, interculturalismo, geografia e antropologia.

Rimane da capire come si svolgerà concretamente il divieto dell'uso dei cellulari in classe e quale tipo di strategie verranno adottate nelle prassi quotidiane nei confronti dell'uso dell'intelligenza artificiale. La questione è destinata a polarizzarsi: da un lato ci sono magnifiche sorti progressive e tecnofile che non tengono adeguatamente conto di cosa significhi far usare uno strumento potente come l'IA senza saper padroneggiare i fondamenti di una lingua e di una cultura; dall'altro c'è l'apocalittica del declino dell'umanesimo che si concentra di fatto sulla sopravvenuta inutilità dei compiti e sull'impossibilità di svolgere verifiche e prove scritte come si è sempre fatto. Di fronte a questa rottura epocale, effettivamente sconcertante quanto poco recepita, sembra prevalere la strada del divieto e della mancata negoziazione educativa ed è troppo presto per poter cogliere con chiarezza le linee comuni utili a fare i conti con il disallineamento tra scuola e società. Ma forse questo vuol dire che, come sempre, si chiede troppo alla scuola e ai suoi attori senza dotarli delle risorse necessarie, troppo per una società stanca e incerta, traumatizzata e sonnambula in un periodo di crisi strutturale che investe prima di tutto il mondo degli adulti.
Ora, non si tratta di allargare il discorso sulla scuola oltre misura e fuori dal campo (che è un modo di chiuderlo) ma vorrei insistere su cosa significhi insegnare veramente oggi, o almeno provarci. Non possiamo dimenticare che le scuole si riaprono in uno scenario cronicizzato di guerra internazionale e di aspra conflittualità in una collettività frammentata, polarizzata e litigiosa; che le scuole riflettono la mobilitazione della società civile e sono fermenti vitali nel rispondere all'inerzia dei governi europei destabilizzati dalla deriva statunitense del trumpismo e dal riequilibrio multipolare dei poteri. L'emergenza continua ed estenuata delle tante e terrificanti crisi umanitarie del presente, e in particolare in Medioriente con il tema del genocidio in corso a Gaza, sta determinando la consunzione della retorica del Mai più di cui la scuola come luogo di formazione integrale è protagonista: lo stallo di impotenza e inazione in cui siamo pietrificati è tale da delegittimare le politiche della memoria elaborate decenni fa e la credibilità del diritto internazionale sorto dalle macerie della seconda guerra mondiale.
Il pianeta brucia, lo scioglimento delle calotte polari procede, la biodiversità si riduce, gli eventi meteorologici sono diventati estremi, le estati faticose e roventi e ovunque si levano richieste di giustizia sociale, di genere e contro i razzismi. In breve, la brutalità del mondo entra ogni giorno in forme spesso aberranti e sfigurate nelle stanze di ragazze e ragazzi che chiedono ascolto e fiducia e cercano nei docenti alleanza, riferimenti e supporto. Mentre questo succede la scuola italiana rischia di farsi più piccola, provinciale e reazionaria assecondando una chiusura apparentemente rassicurante perché fondata sul mito dell'ordine tradizionale (che non ha mai funzionato in quanto profondamente iniquo).
L'anno scolastico inizia in questo orizzonte vasto di nuvole basse e scure, con la certezza che niente sarà facile e la convinzione che questo debba accrescere la determinazione a cambiare le cose. La vita nelle classi è un patchwork di esperienze culturalmente mediate di crescita e metamorfosi per tutti quelli che vi sono dentro. Proprio perché siamo a scuola possiamo lavorare per limitare il peggio del nostro tempo inquieto e ferito. Essere docenti consapevoli del momento in cui viviamo significa non solo trasmettere tradizioni culturali e scientifiche; non può limitarsi a addestrare i discenti a convivere con la realtà, cioè la rappresentazione sociale dominante e naturalizzata dello stato delle cose presenti; ma vuol dire fornire strumenti per imparare a decifrare criticamente il mondo e a confrontarsi con il reale, il dato opaco che emerge dalle crepe dell'esistente con le possibilità future e da costruire di ciò che potrebbe essere.
Un simile ambizioso quanto necessario progetto non può che iniziare dalla cooperazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti nella scuola. Dalla comunicazione chiara e dalla discussione aperta. Dal prendersi cura di noi, dei luoghi e delle comunità in cui abitiamo. Dal progetto di custodire ciò a cui teniamo, di proteggere persone, animali e cose fragili, di spostare in avanti il margine di azione potenziale di ognuno. Dal continuare a meravigliarci di quello che scopriamo e a gioire per conquiste e trasformazioni di chi cresce e cambia con noi.







