L'Italia a scuola: un romanzo di formazione
Chi scrive è stata allieva di Mario Isnenghi all’Università di Venezia nei primissimi anni Duemila (e poi di nuovo, ma in maniera più diluita, durante il dottorato di ricerca a Torino, una decina di anni più tardi), e perciò la lettura del suo Autobiografia della scuola. Da De Sanctis a don Milani (il Mulino, 2025) ha avuto il sapore di un amarcord, forse ancor di più rispetto a un altro libro recente di Isnenghi, che pure richiamava le memorie personali dell’autore e dunque anche alcuni luoghi della memoria universitari “privati”.
Il filo rosso che tiene insieme i densi otto capitoli più un epilogo di questo volume è da rintracciare in una chiave di lettura cara allo storico veneziano: quella dei “viaggi in Italia”, intesi non soltanto come attraversamenti dello spazio geografico in cui si contiene lo Stato-nazione nato nel 1861, ma anche come costruzioni delle “idee di Italia” con le quali gli italiani e le italiane si misurano uscendo – concretamente, ma anche idealmente – dalla dimensione ristretta del luogo di nascita e di residenza, e delle reti sociali che fisicamente possono intrattenere nella loro vita quotidiana, per incontrare la nazione.
Quella dei “viaggi in Italia” fu proprio l’ossatura interpretativa che Isnenghi scelse per il corso monografico di Storia contemporanea nell’anno accademico 1999-2000, e che già allora attirò la mia attenzione di studentessa, inducendomi a scegliere il suo corso rispetto ad altri della stessa materia attivati per quell’anno a Ca’ Foscari.
Il fascino esercitato da quella cavalcata nei viaggi reali e immaginari degli italiani tra Otto e Novecento fu tale che poi decisi di laurearmi con lui in Storia contemporanea: questo lo sottolineo per dire che forse per me un libro come quello di cui qui si parla ha un valore speciale e rappresenta una lettura particolarmente succulenta. Ci ritrovo infatti tutta la capacità di Isnenghi di tenere insieme, con sguardi originali e penetranti, tante diverse storie e financo microstorie, reali e immaginate, che si mostrano in grado di confluire in un “noi”; la sua abilità nel creare raffinate mappature identitarie della realtà storica, culturale e sociale, che si dipana tra Ottocento e Novecento, i due secoli nei quali le persone, sempre più profondamente, anche a livello di masse e non soltanto più di élite, definiscono sé stesse e trovano l’ubi consistam delle proprie traiettorie biografiche anche nei termini dell’appartenenza nazionale e della “messa in pratica” della cittadinanza circoscritta dallo Stato-nazione, sotto forma di diritti e doveri.
I “viaggi in Italia” che Isnenghi ricostruisce in questo libro sono riferiti a un’ambiente, a una categoria con cui egli ha familiarità per motivi biografici – è stato insegnante di scuole secondarie prima di diventare docente universitario – oltre che per i suoi interessi di studioso delle diverse “Italie in formazione”: sono quelli degli uomini e delle donne di scuola. Certamente, dunque, maestri (e maestre) e insegnanti, ma più in generale, e in senso anche più lato rispetto a quello prettamente istituzionale, personaggi che trovano nel “fare scuola” un orizzonte non soltanto di realizzazione personale, ma anche, e soprattutto, di impegno culturale e civile.
Attivismo, militanza sono infatti altre due parole che danno al volume la sua chiave di senso e che forniscono un criterio di selezione stringente, eppure sufficientemente ampio, alle storie che vi sono raccolte. Storie che, perciò – anche se forse, data la completa differenza di contesto, non possono fornire delle vere e proprie “figure ispirazionali” per gli uomini e le donne di scuola di oggi – contribuiscono a delineare un’idea di scuola sulla quale, lo dico sin d’ora, alle donne e agli uomini della scuola di oggi serve ragionare. E questo soprattutto perché il percorso tracciato da Isnenghi – al di là e al di sopra della dialettica progresso-reazione che scandisce forme e contenuti del “pensiero educante” e delle istituzioni educative – prende le forme, se confrontato con la situazione attuale, di un inesorabile anticlimax, sul quale si può produttivamente riflettere e al quale può valere la pena di reagire.
Infatti, sebbene non certo a suo agio nelle vesti del nostalgico laudator temporis acti – preferendo affidare le sue valutazioni sul presente a qualche stoccata provocatoria, specie in chiusura di volume – Isnenghi unisce i suoi punti in un modo che costringe lettori e lettrici di oggi a misurarsi con una concreta sensazione di perdita: con la sensazione cioè, che in passato – e oggi non più – tanto nelle parole di chi ne occupava la cabina di regia, quanto nella voce di chi la abitava quotidianamente con i propri pensieri e le proprie energie, la scuola trovasse la sua ragion d’essere nella capacità di forgiare, nel bene e nel male, una dimensione collettiva.
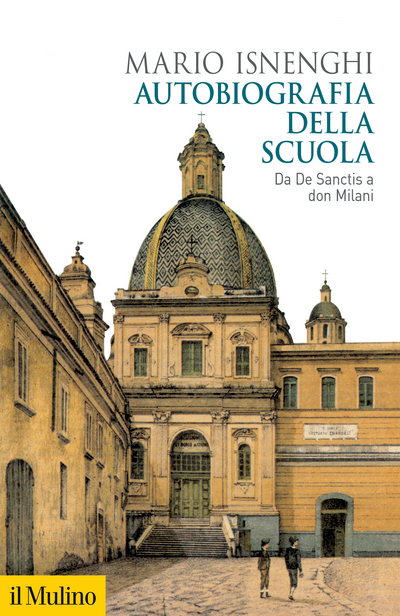
Naturalmente, circoscrivere il senso di un “noi” implica anche lasciare fuori qualcuno, e non sempre – nell’ottica del progresso civile e culturale – per nuocere: i diversi modi di “fare scuola”, e di «impara[re] la cosa-Italia» (p. 9) attraverso il “fare scuola”, di cui racconta Isnenghi comportano evidentemente tante estromissioni. Anzi, questa “autobiografia della scuola” è tracciata anche, letteralmente, per esclusione, e basta scorrerne l’indice per rendersene conto: la scuola italiana immaginata, pensata e realizzata tra Otto e Novecento perimetra e marginalizza, agendo da forza centrifuga, a seconda dello spirito dei tempi e delle alterne vicende politiche, per tanti soggetti (gli austriaci, i cattolici, le donne, i dissidenti, gli antifascisti, gli ebrei, i fascisti…).
E proprio marginalità ed esclusioni, all’interno degli estremi dichiarati in copertina, testimoni invece di progetti inclusivi (La storia della letteratura italiana di Francesco De Santis, 1870-1871 e La lettera a una professoressa di Don Milani, 1967), caratterizzano le date periodizzanti, la partitura cronologica del libro: 1886, il “caso Italia Donati”, che mette in luce il corto circuito tra emancipazione femminile e ruoli di genere tradizionali e fa da detonatore interpretativo per raccontare, attraverso tanti altri «modelli e antimodelli», l’educazione delle donne; 1931, il giuramento dei professori al fascismo; 1938, le leggi anti-ebraiche; 1943, la cesura storica che dà inizio all’epurazione contro i fascisti.
All’andamento ondulatorio tra inclusioni ed esclusioni corrisponde quello sussultorio tra avanguardie e resistenze: e attorno gli “spiriti guida” del libro – Edmondo De Amicis, Antonio Fogazzaro, Augusto Monti, per citare soltanto coloro che si prendono più spazio nella narrazione –, che si muovono in questo territorio non piano, con percorsi non lineari, Isnenghi traccia tanti profili minori, ciascuno con la sua storia, ma coralmente rappresentativi di questo “romanzo di formazione” della scuola italiana, come progetto ancor prima e ancor più che come atto.
Romanzo, come si evince dal titolo, autobiografico, e dunque (auto)biografiche sono anche le fonti di cui Isnenghi si serve per costruire la sua narrazione. A diari e memorie si affiancano gli epistolari, indispensabili questi non soltanto a scavare nelle percezioni dei protagonisti, ma anche rintracciare i nodi delle reti sociali e culturali che danno concretezza alla dimensione collettiva del “fare scuola”. E poi le fonti letterarie, non solo quelle di qualità maggiormente riconosciuta – come può essere Cuore di De Amicis – ma anche opere di fiction di secondo e terz’ordine: libri che non hanno tenuto alla prova del tempo, instant-book d’epoca, prodotti nell’urgenza di mettere in scena temi e problemi allora particolarmente sentiti, testi ascrivibili a un «artigianato ideologico-sociale» (p. 170) utilissimo per calarsi ora – facendo la tara a tutte le stereotipizzazioni del caso – in quegli immaginari, colti nel momento del loro farsi o disfarsi. Per l’epoca fascista Isnenghi si affida agli annuari scolastici, evidenti «strumenti identitari», autobiografie «standardizzate e […] messe in posa» della vita scolastica ai tempi dello Stato etico. Memorie e rievocazioni in soggettiva – e non sempre fedeli ai fatti – tornano in campo a segnare il rivolgimento di fronte rappresentato dalla fine del fascismo e dalla nascita del nuovo quadro istituzionale democratico e repubblicano.
La chiusa verso il dopoguerra è forse un po’ precipitosa, lasciando al lettore – o almeno, a questa lettrice – interrogativi aperti riguardo alle percezioni autobiografiche del mondo della scuola del secondo Novecento. In particolare, resta solo abbozzata – nel cenno a Mario Lodi e a don Milani alla fine del libro – la questione del Sessantotto come momento di rottura: momento, questo, generativo di cambiamenti positivi, come ha sempre messo in luce il pensiero democratico e progressista, o degenerativo, come la cultura di destra oggi sostiene?
La risposta non arriva netta, ma, come suggerivo in precedenza, possiamo averla proprio nel senso di perdita che la ricostruzione di Isnenghi, nella sua ricchezza di spunti e di riferimenti, suscita. Nelle idee di scuola degli ultimi decenni, – a destra come a sinistra – ha prevalso un’idea di inclusione orientata a rispondere ai bisogni individuali nella società globalizzata (le “competenze”, la spendibilità per il mercato); e allora guardare a questo ricco passato può servirci ad avere più coscienza di una scuola che si fa progetto collettivo, che racconta quale “noi” vogliamo consegnare al futuro, come cittadini ormai non soltanto più di uno Stato-nazione, ma del mondo intero.







