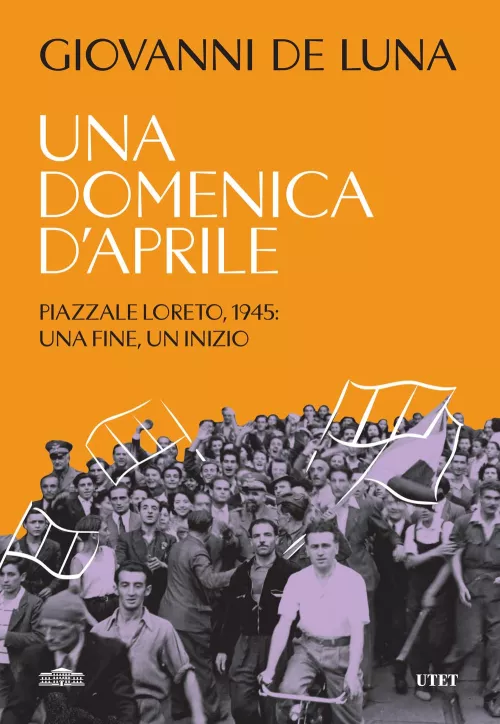L'Italia di piazzale Loreto
Ci sono eventi che si sedimentano nella storia, talmente levigati dal tempo da diventare luogo comune. Storie che si crede di conoscere perfettamente e a cui si allude comunemente, che sembra siano sempre state lì e in quel modo, quasi scolpite dal destino, mentre sono il frutto di un processo di rielaborazione che avviene per tutto il periodo che ci separa da loro e che è filtrato dagli interessi per i quali cui la vicenda è diventata di dominio pubblico, modificandosi progressivamente e impercettibilmente. Succede in particolare con le storie più grandi di noi e di impatto decisivo sulla collettività, oggetto di valutazioni di segno opposto, non tanto per i fatti in sé quanto per le interpretazioni datene e le appropriazioni, tanto più forti e parziali quanto più sono oggetto di uso politico della storia.
La fine pubblica di Benito Mussolini e dei suoi fedelissimi nei giorni della Liberazione rientra con forza tragica ed epica tra queste e, per il ruolo che il fascismo ha avuto nell'autobiografia della nazione, non poteva essere altrimenti.
A questo nucleo tematico è dedicato Una domenica di aprile. Piazzale Loreto, 1945: una fine, un inizio (Utet 2025) di Giovanni De Luna, l'uscita più recente di una vasta indagine sulla storia, sulla memoria, sulle narrazioni e sul loro uso pubblico che non dimentica il rapporto tra passato e presente.
De Luna torna su temi su cui ha lavorato – la storia del fascismo e dell'antifascismo, della Resistenza e della Repubblica sociale, della società in guerra, dell'occupazione tedesca e della guerra civile colta nei comportamenti collettivi (ad esempio qui; e qui) e si concentra sulla città di Milano durante la Resistenza in tre importanti episodi strettamente connessi, scegliendo un’efficace forma narrativa ricca di documenti, testimonianze e documentazione fotografica.
Si tratta di momenti ad alta densità di significato, eventi dentro più ampi processi. Il primo è il 10 agosto 1944: a piazzale Loreto sono fucilati dai militi fascisti quindici prigionieri politici, successivamente esposti in pubblico e a lungo insepolti con una macabra messinscena e cartelli di scherno. Davanti a quei corpi di ribelli appartenenti a più generazioni e correnti politiche, passano sgomenti centinaia di milanesi, di pendolari, di donne e bambini e, proprio davanti a quei corpi, i resistenti provano ira, dolore, e desiderano vendetta.
Il secondo è il 16 dicembre 1944: al Teatro lirico il capo del governo della Rsi tiene il suo ultimo discorso, di fronte a una folla militarizzata e tra eccezionali misure di sicurezza; un discorso memorabile per il contesto più che per i contenuti, in cui vengono riletti gli eventi recenti – il tradimento della monarchia, della corte, della borghesia plutocratica, di massoni e clericali –, pieno di falsità sullo stato della guerra, sull'esercito italiano, sui rapporti con la Germania e sulle violenze in atto. Una propaganda che mostra nella sua stereotipia il congegno inceppato del totalitarismo che sopravvive a se stesso nel crepuscolo nazifascista e che viene salutato come “il discorso della riscossa” proprio mentre manifesta una crisi in stato avanzato e terminale.
Il terzo e decisivo momento, la domenica di aprile del titolo, è quello che succede, di nuovo a piazzale Loreto, il 29 aprile 1945, quando il corpo senza vita di Mussolini viene appeso per i piedi a testa in giù: i giorni convulsi della fine del regime sembrano trovare l'epilogo simbolico con l’esposizione del duce, prima eterno e onnipotente ora inequivocabilmente morto e corruttibile. I fatti sono noti: l'arresto di Mussolini, Petacci e dei gerarchi in fuga e le fucilazioni nei pressi di Dongo nei giorni precedenti, il trasporto dei corpi a Milano in una piazza tumultuosa e in continua crescita fin dal mattino, i partigiani e i pompieri che cercano di contenere una massa di gente incontrollabile, la presenza silenziosa e compiacente delle prime avanguardie alleate, i cadaveri prima riversi a terra e oltraggiati e poi innalzati con cavi di acciaio alla pensilina di una stazione di rifornimento di carburante, la fucilazione sul luogo di Achille Starace nel frattempo arrestato, la notizia che continua a circolare attirando persone e la fine dello “spettacolo” entro il primo pomeriggio.
Molto si è detto su quel giorno. Dimostrazione della vittoria del movimento partigiano rivendicata dalle sue componenti antifasciste più radicali; esplosione popolare di vendetta per l'estremo raggiunto negli anni di guerra sbagliata, fallimentare e perduta; cesura netta che pone fine al conflitto con un surplus di sicurezza ultimativa nel fatto che non ci saranno colpi di coda, indulgenze o assoluzioni né leggende di fuga e sopravvivenza... La scena di piazzale Loreto appare qualcosa di più della morte del dittatore o di un “contrappasso” nello stesso luogo di esercizio della violenza fascista sui partigiani, qualcosa in cui subentrano il comportamento della folla come processo dinamico collettivo, la gestione dell'ordine pubblico che cerca una legittimazione dal basso, l'esposizione dei corpi scenografica e funzionale al tempo stesso, ma anche il precipitare degli eventi in mezzo a diverse intenzioni verso la chiusura di un cerchio che viene letto come un orrendo ma necessario rito di morte, nella sovrapposizione del corpo del dittatore con quello dello Stato totalitario, con una catarsi violenta da cui possa scaturire la possibilità di riiniziare a vivere.

Negli anni della dominazione nazifascista la violenza quotidiana si accompagnava alla macabra ritualità dell’ostentazione della morte data ai ribelli come strategia di comunicazione, di dominio e di deterrenza. La pubblica esibizione dei cadaveri, impiccati e fucilati, era una forma di controllo della piazza con un duplice movimento di repressione del nemico e di strategia terroristica volta a evitare la partecipazione della popolazione a sabotaggi, rivolte, atti di guerriglia. La lotta per le sepolture, come nel gesto di Antigone che sfida la legge ingiusta del tiranno (tragedia non a caso ripresa da Brecht in un adattamento anti-nazista nel 1947-48), era un aspetto della lotta di Liberazione: i partigiani correvano rischi per onorare degnamente i compagni uccisi; il rispetto dei morti testimonia l'attenzione alla pietas comunitaria e segna una differenza rispetto al nemico, alla religio mortis fascista e alla sua negazione dell'umanità: dare giusta sepoltura ai caduti era un segno contrario alla profanazione e metteva in luce la sacralità delle vite perdute nella lotta.
Le reazioni scomposte della folla cittadina e della popolazione contadina nei giorni della Liberazione, in diversi luoghi, sono state un impasto di giustizia e vendetta in cui il partigianato appare più impegnato a limitare e controllare la violenza che non a esercitarla. È molto difficile comprendere quelle dinamiche decenni dopo con una sensibilità molto diversa e senza avere chiara consapevolezza di cosa sia una guerra totale, di occupazione, di rapina e di rappresaglia. La fase finale di un conflitto bellico, anche in una guerra come quella partigiana sorta per porre fine alla guerra, richiede spiegazioni complesse. Se ogni discorso sulla Resistenza deve essere affrontato a partire dal nucleo della scelta di sfidare apertamente tedeschi e fascisti con le armi, il tema della violenza nel momento della “resa dei conti” non può essere separato dal suo retroterra, dal clima di guerra e dalle circostanze estreme in cui i fatti si svolgono; così come non possono essere ignorati motivazioni e obiettivi della guerra partigiana, la speranza e i progetti di società futura che ne sono alla base.
Su questo, contro le manipolazioni, si è scritto molto e si è compreso troppo poco in un discorso pubblico che vive di miti, frammenti e spiegazioni semplificate. Per far finire una guerra non ci sono degli interruttori e, quando sono in movimento, i processi insurrezionali prendono una forza di inerzia che nessuno può facilmente controllare. Per comprendere la fine di aprile del 1945 bisogna guardare alle cause contingenti e ai rapporti di forza sul territorio: la modalità di resa per le forze fasciste e tedesche e le trattative ad alto livello, le reazioni violente e la scia di sangue lasciata dai tedeschi in fuga e dai fascisti che non si arrendono, i movimenti dei partigiani dell'ultimo minuto e raddoppiati nel numero. I comandi della Resistenza emanano norme e direttive con grande sforzo di coordinazione, ma ci sono formazioni, gruppi o singoli che prendono iniziative autonome; e poi ci sono la moltitudine in preda al furore, le vendette private, la delinquenza comune, gli imprevisti. La massa diventa un agente protagonista, non un semplice sfondo o un coro di spettatori, per la quale entra in gioco il nesso tra violenza esercitabile e quella patita nei vent'anni di dittatura, in un contesto di esasperazione di lungo periodo legato alle privazioni, alle bombe, alle angherie, alle perdite e ai lutti e a una più vasta «assuefazione generalizzata alla violenza, alla svalutazione della vita, allo spettacolo della morte subita e inflitta» (Colombini). Questo implica che con la guerra totale e civile riaffiorino anche comportamenti arcaici e interruzioni del processi di civilizzazione, connessi alla rottura del monopolio statale della forza e alla crisi di legittimità dei poteri ufficiali post 8 settembre, in particolare del governo collaborazionista durante l'occupazione tedesca le cui brutalità erano giunte al punto di dare una dimensione di totale estraneità dei fascisti repubblichini rispetto alle comunità.
Sullo sfondo di questi ragionamenti e in dialogo con le interpretazioni della storiografia su piazzale Loreto, Una domenica di aprile stringe l'obiettivo sui fatti del 29 aprile 1945 e sulla loro lettura immediata e successiva. Non è emerso in modo chiaro, tra gli attori in campo, chi avesse la leadership riconosciuta in quella piazza, così come è incerta l'iniziativa di porre fine all'esposizione dei corpi del duce e del suo entourage portandoli all'obitorio, condivisa tra i protagonisti del diveniente ordine costituito (i partiti antifascisti, il governo alleato, la Chiesa). De Luna mette in fila i movimenti dei vari attori in campo ora per ora, costruisce un racconto corale con i diversi resoconti, moltiplica narrazioni e opinioni sui fatti – quelle dei testimoni eccellenti e autorevoli o minori come gli autori di diari provenienti dall'Archivio di Pieve Santo Stefano –; riporta i punti di vista e le divergenze politiche, il modo in cui i fatti vengono commentati sui giornali, liberi dalla censura e in fase di rinascente pluralismo, fino a dare conto dei racconti falsi e inattendibili (siano essi di origine popolare o d'autore). Il che mostra come una storia non sia mai la stessa storia, come si possa continuare a interrogare la documentazione nel tempo e quanto miti e leggende producano altra storia, nei termini di un posizionamento rispetto a un certo racconto dei fatti.
Tra le molte fonti lo storico torinese sceglie di interrogare e far parlare la vasta documentazione fotografica, privilegiando gli scatti di Luigi Ferrario, fotografo dilettante all'epoca trentenne, che raccontano in modo più ampio e differenziato le strade milanesi nei giorni della Liberazione, con volti e gesti di uomini e donne in altri luoghi caratterizzati dalla dimensione festiva, colti nel significato di fine dell'incubo e di gioia collettiva per la speranza in un domani diverso. Proprio da qui emerge con forza dal libro il rifiuto dell'immagine stereotipica di piazzale Loreto come paradigma di una massa patologica, rivoluzionaria o anarchica funzionale alle interpretazioni di un dopoguerra bisognoso di ritorno all'ordine, in nome di una visione più sensibile alle molte e diverse folle sovrapposte di volta in volta, fatte di persone che convivono nello spazio e nel tempo della Liberazione, nei giorni dell'«“interregno” […] in cui il vecchio potere, quello dei nazisti e dei fascisti della RSI, non c'è più e il nuovo potere, quello della Resistenza e degli Alleati, non c'è ancora».