Vedi alla voce: infobulimia
La lingua batte dove il dente duole: è di qualche giorno fa la registrazione, tra i nuovi neologismi, di “infobulimia“. Chi la registra è Treccani: nell’immaginario di tanti - prima della rovinosa crisi dei libri di reference, ossia di consultazione, scalzati non tanto dalla rete ma dalla sua portabilità - una sorta di misteriosa entità semidivina che al sapere del paese sovrintendeva. Di qualcuno che sa tutto, in inglese si dice che è un “walking dictionary”, un dizionario che cammina. Adesso che dizionari enciclopedie e oracoli dei più variegati vengono a spasso (e a tavola, a letto, a scuola) con noi, grazie a quest’appendice elettronica “walking dictionary” lo siamo un po’ tutti e non lo è più nessuno. Allora forse anche l’aurea auctoritas della grande T nazionale - con quei volumi-bastione che bastavano, quasi monito a un timore reverenziale, ad ammantare di credibilità chi li possedeva, tanto da farli scegliere come sfondo a professionisti, politici e mezzobusti - non è più riconosciuta. E chi si è ritrovato a voler, o dover, regalare una Treccani ereditata da qualche nonno sa che non c’è libraio antiquario che, per quanto perfetta, la ritiri – gratis. Pur tuttavia, dall’eco di quest’ultimo inserimento sulle varie testate, sembrerebbe che di qualche residua considerazione l’istituzione (e le istituzioni?) ancora goda. E che, se il setaccio degli editor e redattori superstiti (o sarà ormai un conteggio delle occorrenze dell’AI?) ha selezionato questo termine, qualcosa vorrà dire – qui un recente e struggente articolo sull’estinzione in corso della specie specialissima dei lessicografi (negli Stati Uniti, ma poco importa). Il fatto è che dare cittadinanza a una parola, legittimarla, significa riconoscere una realtà. E una realtà non così effimera: perché i neologismi, per venire accolti nei dizionari, devono promettere una certa longevità, o almeno aver dato prova di un minimo di stabilità. È vero, molti non sopravvivono, perché magari non sopravvivono i fenomeni che descrivono, o per altre ragioni – chissà se l’epoca dello schwa avrebbe consentito l’ironico celodurismo. Ma il lessicografo una piccola scommessa in fondo la fa.
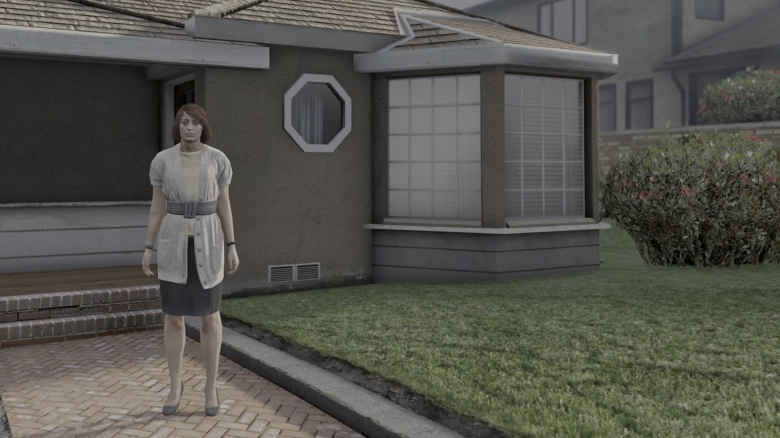
Infobulimia è uno di quei neologismi formati per giustapposizione di due termini: informazioni, ovvio, e bulimia. La cosa curiosa è che non sono pochi i nuovi termini che si riferiscono alla rete che in realtà si rifanno a un lessico medico, che designa situazioni patologiche. La bulimia è secondo l’Istituto Superiore di Sanità, una malattia “complessa, determinata da condizioni di disagio psicologico ed emotivo, che quindi richiede un trattamento sia del problema alimentare in sé che della sua natura psichica. L’obiettivo è quello di portare il paziente, attraverso terapie mirate a modificare i comportamenti e l’attitudine, a adottare soluzioni di gestione dei propri stress emotivi che non siano dannose per la propria salute e a ristabilire un equilibrato comportamento”. Uno stato, insomma, da cui difficilmente uno si salva da solo. È vero che per i casi estremi esistono centri di disintossicazione - digital detox. Sì, per guarire si va in comunità. Ma qui il linguaggio ci viene in aiuto: proprio la polisemia di quest’ultimo termine potrebbe offrire un appiglio a chi di noi non si sente ancora proprio da ricovero, ma si vede su una brutta china. Una rivista seria come The Atlantic qualche mese fa chiamava il singolo lettore a organizzare più feste: dosi di barbecue e ritrovi di vicinato almeno settimanali per vincere l’infobulimia che ci confina in casa, anzi dentro il rettangolino geloso del nostro schermo, e che è corredata da varie patologie secondarie – una su tutte: la polarizzazione. Una malattia che ci porta a ingurgitare nozioni, senza che queste ci stimolino a un’elaborazione o a un output personale. Metafora di un esimio neurologo: “la testa è come una gigantesca rotatoria in cui adesso si immettono troppe strade, tutte trafficatissime: prima o poi si bloccherà!” È l’ingolfamento dovuto all’information overload, ossia il sovraccarico cognitivo così definito da Bertram Myron Gross, molto citato alla comparsa della nuova parola. In un certo senso, insomma, in una testa (un po’ più) vuota c’è più spazio per pensare. Se questa infodemia, per citare un neologismo Treccani del 2020, si combina al fatto che parte dei contenuti che si diffonde in maniera virale è falsa, avvelenata, drogata, geneticamente modificata dall’AI e quant’altro, allora le conseguenze di questo male da cui in fondo tutti ci sentiamo affetti risultano davvero spaventose.
Purtroppo, infodemia e infobulimia si inseguono in un calcinculo vizioso. Per essere visibili, presenti, bisogna imporsi a suon di novità: di articoli (non pubblica un po’ troppo, questa Doppiozero?), di libri (circa 85.000 nuovi titoli l’anno in Italia, per assicurarsi un posto al sole sul bancone e consentire il sistema delle rese), di post, stories, e altri generatori di notifiche di cui non so il nome. La novità impera, anzi è dittatrice. E il dernier cri spesso perde la sciccheria d’antan e diventa l’ultima urlata.

Ma perché noi la novità la cerchiamo in questo modo compulsivo? In fondo, perché siamo fatti così. L’abbiamo sempre fatto. Derek Thompson nel suo minisaggio The Anti-Social Century ne suggerisce le ragioni in estrema sintesi in questo modo: programmati per andare a caccia di dopamina, fino a non molto tempo fa per procurarcela dovevamo uscire. Perché veniva (anche) dallo scarto, per quanto piccolo, dalla solita minestra che ci riservavano le nostre quattro mura, e necessariamente dovevamo cercarla fuori casa: in un incontro, in un giornale fresco di edicola, in una pausa di lavoro alla macchinetta del caffè. Le informazioni che ci procurano quella impercettibile fibrillazione stavano tutte nelle nostre avventure quotidiane extra moenia. Adesso non abbiamo più bisogno di uscire per procacciarci questo “cibo”. Le novità stanno lì, nella scatolina magica che teniamo in mano per un numero imbarazzante di ore al giorno. Inesauribili. E addictive. Eccola lì, la nostra infobulimia dopaminergica.
Peccato che nel frattempo ci siamo persi per strada, piuttosto rapidamente, il contatto e pure un po’ il tatto, quel mescolamento e sfregamento che giova al cuore e anche alla polis.
Insomma: tocca sperare che Treccani questa volta si sbagli e che l’infobulimia evapori dai dizionari come una passeggera bizzarria di questi anni. L’unico modo perché questo avvenga, però, è rivolgerci a una comunità terapeutica: quella che abbiamo intorno a noi!
In copertina, Imagine and building the good life (2024) © Lucia Romanello.







