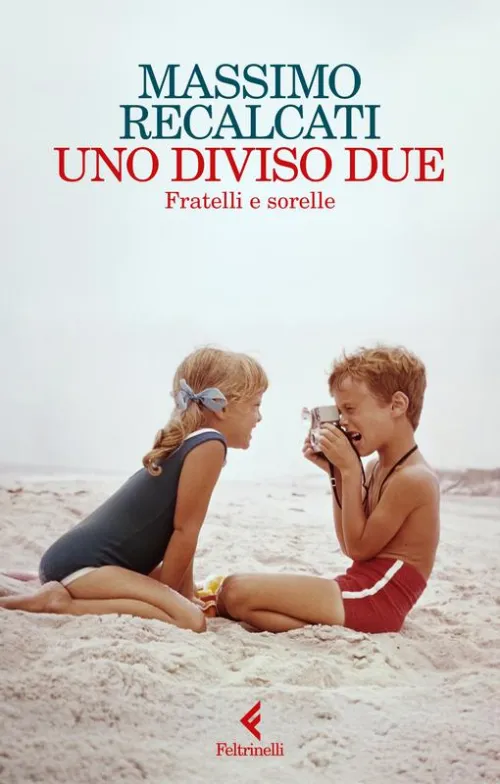Sorelle e fratelli dall'uno al due
Fratelli e sorelle possono essere solidali o è scritto un destino di lotta fratricida? Questa la domanda che attraversa Uno diviso due (Feltrinelli, 2025) di Massimo Recalcati, volume in cui lo psicoanalista mostra come la strada verso la possibilità dell’amore fraterno sia tutt’altro che lineare.
Già Agostino aveva colto – ed è Jacques Lacan a metterlo in evidenza – la matrice della gelosia invidiosa con cui un bambino può guardare il fratellino attaccato al seno materno: ‘ho visto con i miei occhi e ho ben conosciuto un bambino piccolo in preda alla gelosia. Non parlava ancora, e già contemplava, pallido e con uno sguardo torvo, il fratello di latte”. Lo ribadisce Freud, che sottolineava come l’odio sia più antico dell’amore, in quanto il primo moto che anima i legami tra fratelli e sorelle è quello della distruttività. La nascita di un fratello o di una sorella impone un decentramento dell’Io: il figlio deve far spazio a un altro figlio, il suo Io deve rinunciare alla fantasia onnipotente di essere l’unico amato dei genitori. La questione, tuttavia, si pone anche per i figli unici: il punto è l’apertura all'alterità in quanto tale.
Recalcati illustra le sfumature nefaste di tale odio, della gelosia, dell’invidia: esperienze originarie dell’inimicizia umana che lasciano un marchio indelebile fin dall’infanzia e possono orientare la propensione futura nei confronti dell’alterità. La dettagliata descrizione delle “passioni tristi”, che Recalcati illumina con lo sguardo del clinico e dell’intellettuale, rende conto di come la solidarietà fraterna sia un risultato, un compito, non si dia naturalmente e con facilità.
Solidarietà fraterna che non riguarda solo le dinamiche familiari ma anche i gruppi, le istituzioni, la vita politica: il punto fermo dell’opera recalcatiana resta il piano simbolico dei legami, così come per la genitorialità. Non è la consanguineità a garantire l’amore per la libertà dell’altro.
Si tratta dunque di una rinuncia di potenza, oltre che di una frustrazione, si tratta di dover accettare la presenza di un altro che ci destituisce dal ruolo di unici destinatari delle cure e delle attenzioni dei genitori. Questa rinuncia all’essere un Uno pieno, questa disponibilità a far posto al Due, è un processo psichico che richiede il lavoro del lutto, l’accettazione di una perdita, di una mancanza. Si tratta di non cedere a una seduzione immaginaria di potenza/onnipotenza dell’Io e fare spazio all’alterità, a colui che segna una differenza in quanto altro da sé.
Dietro al rifiuto del Due si cela anche una profonda paura. Difendersi dall’altro equivale a cercare di preservare un’illusoria compattezza dell’Io: il Due minaccia questa unità, introduce una crepa, una mancanza che ricorda al soggetto di non essere autosufficiente. L’altro porta sempre con sé l’imprevedibile, il non controllabile, e dunque la possibilità della frammentazione psichica. La paura non riguarda soltanto l’essere invasi o sopraffatti, ma anche l’essere trasformati dall’incontro, costretti a riconosce la propria fragilità strutturale. In questo senso, l’alterità è vissuta come un rischio di perdita di identità: aprirsi al Due implica l’accettazione di una mancanza originaria che costituisce la nostra particolarità più profonda. Il filosofo francese J. L. Nancy, nel suo breve saggio L’intruso, ispirato da un’esperienza autobiografica, ci insegna quanto l’apertura all’altro, allo “straniero”, sia un’operazione psichica sia individuale che collettiva dall’esito sempre incerto. Non c’è solo la paura dello smarrimento di sé, ma il rischio è anche il rovescio, l’eccesso di difesa, l’irrigidimento, l’implosione per una sorta di malattia psichica autoimmune. Ciò vale per i singoli ma anche per i gruppi.
Il dialogo con l’alterità è un’attività che ci accompagna per tutta la vita e il processo non è mai del tutto compiuto: dalla lotta fratricida alle violenze dei fondamentalismi religiosi, dalle crisi della vita associativa e lavorativa a quelle della vita di coppia. La spinta a “fare Uno” è una tentazione continua trasversale ai gruppi umani, dalle dimensioni mortifere collettive, alle atmosfere incestuali di certe famiglie, così come le ha definite Paul-Claude Racamier.
È decisamente impervio il lavoro di testimonianza dell’amore teso a bonificare l’odio, odio che soffoca e vincola: più si disprezza, più ci si ritrova incollati alla persona odiata, rendendo impossibile la separazione.

Come afferma la teologa e attivista politica Teresa Forcades: “Solo attraverso la fiducia nell’altro posso essere libera, anche a livello politico. La paura e la libertà sono dunque incompatibili. Del resto, sono libera quando difendo teorie razziste oppure sono ignorante, interessata, egoista?”. La liberazione è un processo sempre in divenire, un’esperienza che può essere efficacemente accompagnata sin dall’infanzia da parte di genitori: essenziale, infatti, è la capacità di esercitare il riconoscimento singolare di ciascun figlio, facilitando le sue future possibilità di far posto all’altro da sé. Recalcati sottolinea come nelle storie cliniche di chi ha cristallizzato una chiusura verso l’alterità, c’è sempre un problema di riconoscimento da parte dei genitori fin dalla primissima infanzia.
Anche la vita di coppia richiede il coraggio del riconoscimento: si può essere gelosi del passato amoroso e sessuale del proprio partner, dell'intensità dei suoi sentimenti verso altre persone.
Recalcati riporta il caso di un giovane uomo di poco più di trent'anni tormentato dalla gelosia nei confronti della sua compagna. L'analisi rivela una traccia sedimentata nella sua memoria, relativa alla morte di un fratellino di due anni avvenuta poco prima della sua nascita. Il desiderio di sua madre gli è sempre apparso come catturato da questa morte e dall’idealizzazione materna del figlio scomparso. Il suo vissuto è, dunque, quello di essere il “figlio di riserva”, l'indegno sostituto di chi lo ha preceduto. Così, la sua passione gelosa nei confronti della donna amata è provocata dall'angoscia di non poter essere sufficiente per trattenerla con sé. Anche nella lettura che Recalcati fa del lavoro artistico di Van Gogh, sviluppata nei suoi saggi dedicati all’artista olandese, troviamo un’analoga ferita originaria: aver dovuto prendere il posto e il nome proprio di un fratello morto esattamente l'anno prima della sua nascita. L’opera incessante dell’artista è qui decifrata come tentativo sublime di trovare un’iscrizione simbolica a fronte di un vuoto di riconoscimento.
Compito di una analisi è la ricostruzione e la rilettura della propria storia che contestualizza biograficamente la genesi della passione gelosa: l’analista può farsi testimonianza di amore come alternativa vitale all’odio, offrendo un’esperienza di profondo riconoscimento del soggetto. Il riconoscimento, in senso simbolico, può essere generativo di un lavoro psichico di elaborazione e sganciamento dalle “passioni tristi”.
In questo senso l’analisi è un’opportunità, grazie alla relazione di transfert, di riscrivere la propria storia e il proprio destino grazie a un incontro inedito in cui avviene il riconoscimento della propria singolarità. Questo non significa che ogni incontro analitico sia garanzia di questa possibilità, proprio perché non esiste un atto o un ruolo che, di per sé, garantisca il riconoscimento; ma per poter riconoscere è fondamentale essere in una posizione etica, dunque orientata verso la verità e la responsabilità. L’apertura all’ascolto dell’altro non è scontata, necessita di esercizio continuo, intenso lavoro intrapsichico. Aver fatto un’analisi personale, essere “un paziente guarito” come affermava Ferenczi, è alla base della capacità di operare riconoscimento a più livelli.
Recalcati cita le Sacre Scritture, lasciando forse intuire che il vero riconoscimento dell’alterità necessita di più fonti sapienziali, come quella cristiana, indicandoci che nelle parole di Gesù fratello e sorella non sono dati di natura, ma definiscono “chi sa farsi prossimo”.
Lo vediamo nella parabola del buon Samaritano: un viandante viene malmenato, derubato e abbandonato sul bordo della strada. Passa un sacerdote, che lo vede e va oltre. Passa un levita, che va oltre. Passa un samaritano che lo soccorre, lo accompagna alla più vicina locanda, lascia all’oste dei soldi e gli chiede di occuparsi di lui. Salderà al suo ritorno l’eventuale debito sospeso.
Non è il ruolo, non è la professione, e non è neppure il legame di sangue a garantire la fratellanza solidale. La parabola mostra come l’amore e il riconoscimento della sofferenza dell’altro possano scaturire perfino da un eretico (il samaritano) eccedendo sorprendentemente le formalità dell’ortodossia. Il samaritano non attende di essere risarcito personalmente e narcisisticamente dal viandante, ma lo affida a un terzo, il locandiere, istituendo un debito simbolico.
Come scrive Recalcati, “è la testimonianza offerta da chi, pur non avendo alcun legame di sangue con chi è stato rapinato, percosso e ferito, si prende cura di lui senza esigere una ricompensa. È ogni volta ciò che accade quando i prestigi del proprio Io vengono subordinati a un atto di donazione che trascende il suo rafforzamento narcisistico”. Solo questo decentramento conduce l’Uno al Due. Conciliarsi con il proprio fratello equivale a misurarsi con la propria “ombra”.