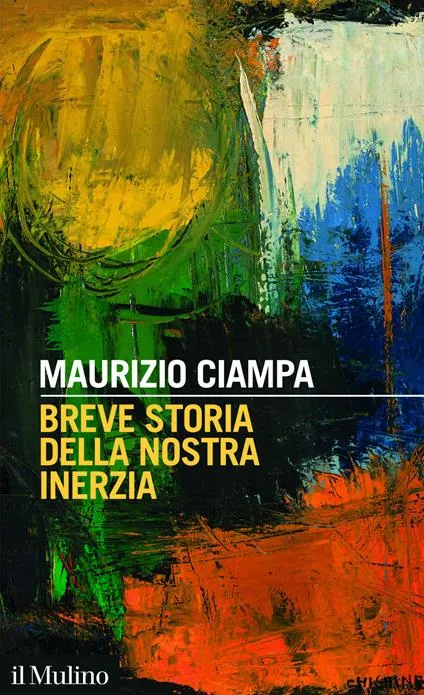Sonnambuli, depressi e impotenti
Il senso di impotenza, la convinzione che ormai le cose non potranno che andare nella propria direzione, governate da forze superiori fuori controllo; e di riflesso la rabbia che, incapace di affrontare i problemi alla radice, si accanisce sui dettagli a portata di mano, a misura della propria debolezza, e sfocia nel rancore vero chiunque ha le conoscenze e il potere di agire, sollevati dall’ansia di decidere, grati e insieme liberi di disprezzarli con l’odio sordo e biascicato che si riversa su chi dall’urto del nulla protegge ma che si avverte anche come il nemico che a questo nulla ci riduce o ci dà in pasto… È la condizione in cui spesso, come scrive Maurizio Ciampa nella sua recente Breve storia della nostra inerzia (il Mulino, 2025), molti di noi si trovano, che si traduce in “accidia, malinconia, noia, apatia, indifferenza, immobilità, endemica stanchezza”, … che vanno a comporre l’inerzia che pervade e corrode la nostra vita come se fosse il portato più peculiare del mondo in cui ci troviamo a vivere negli ultimi decenni. Ma non è così. La sua è una lunga storia, che conviene ripercorrere, sia pure in modo sintetico, per comprenderne meglio le sfaccettature e le forme che è venuta a prendere nei tempi più recenti. “Insediata da sempre nel recinto dell’esperienza umana, l’inerzia compendia i suoi umori corrosivi, i fantasmi di dissoluzione, le rovinose abulie … [e] insidia il cuore e la mente delle donne e degli uomini di questo primo scorcio del XXI secolo”. Ciampa ne ricostruisce le forme e le denominazioni che ha assunto nel tempo in brevi ma densi capitoli, disegnando attraverso immagini pregnanti una fenomenologia che gli permetterà poi di approfondire, nella seconda parte del libro, i caratteri che viene ad assumere oggi, principalmente qui, in Occidente, paradossalmente proprio in un tempo come il nostro in cui dominano le rapide trasformazioni che spesso ci trovano impreparati ad affrontarle, in primo luogo dal punto di vista intellettuale perché poco comprese, accettate e subite senza essere adeguatamente indagate.
Inerzia degli individui, ma anche delle collettività, degli Stati che vedono la catastrofe che si avvicina ma si trovano nell’impossibilità, e non solo nell’incapacità, di farvi fronte. Tanto che “forse la sola azione che resta da compiere – scrive Ciampa –, la più importante, è quella di mantenerci nell’umano, sapendo che gli assunti etici sono andati deflagrando, i loro vincoli non sono più un’evidenza. … [e che, come ha scritto Bruno Latour] «occorre reinventare tutto da capo» … il diritto, la politica, le arti, l’architettura, le città, ma, cosa ancora più strana, bisogna reinventare il movimento stesso”.
Se non che anche il movimento sembra impossibile: a prevalere è lo sfinimento, del pensiero oltre che dell’energia vitale, che non è il preludio, ma già il segno, l’evidenza, dell’asservimento compiuto, e accettato dai più come irreversibile. Almeno qui da noi, nell’occidente più che maturo. Non così altrove, vien da aggiungere, dove prevalgono ben altre urgenze, e il dinamismo, la volontà di fare, è una necessità primaria che nessuna repressione e violenza, almeno per ora, riesce a sedare. Poi vedremo. Le manovre di soffocamento sono già in atto.
Nel suo libro precedente, Italia minima (Donzelli, 2024), Maurizio Ciampa aveva tracciato, attraverso immagini e cronache in gran parte ormai dimenticate, la storia di una nazione che usciva da un regime osceno e da un conflitto spaventoso trasformatosi alla fine in guerra civile, con la voglia, più che di fare i conti col passato, di prendere in mano un futuro finalmente ridiventato possibile. Una vera e propria fame di futuro che si manifestava in una ritrovata energia e volontà di agire, che nonostante l’arretratezza e la povertà diffuse, avevano spinto l’Italia verso un sogno di riscatto e modernizzazione per alcuni decenni, prima di infrangersi contro la realtà di un capitalismo che, appena affermato, si rivelerà presto ancora più feroce delle reazioni a cui avrà dato luogo, abbastanza perché la loro repressione scoraggi ogni eventuale pensiero di riprenderle. Ora è il tempo in cui questo impulso è esaurito, ricacciato in un passato tanto prossimo da essere da molti ancora ricordato, ma insieme abbastanza lontano, nella sua separatezza e chiusura, da avere perso qualsiasi forza propulsiva ed essere ormai disponibile soltanto per le deformazioni di mitologie nostalgiche, di una serie di miti che, svuotati di ogni forza simbolica, non servono che a decorare le pareti del vuoto in cui si vive e ad arredarlo degli oggetti che il ricordo consolatorio affastella senza che siano in grado di colmare alcunché, se non gli scaffali di negozi e supermercati dove corre a rimpinzarsi la bulimia che l’esaurimento di qualsiasi valore o obiettivo che non sia una merce, produce. Fabbrica di miti, o meglio: di fantasmi di miti, che non solo non conduce verso nessun futuro e ne ostacola la pensabilità e ancor più il progetto, ma già al solo contatto con l’istante a cui è ridotto il presente si dissolve e evapora.
In Breve storia della nostra inerzia proprio su questo si interroga Maurizio Ciampa, attraverso una scrittura secca, breve, ma tutt’altro che scarna: ricca di immagini, anzi, espressiva ma che vira sempre verso la descrizione, la formula concentrata per meglio dire e far capire e sentire. Nessun volo immaginifico, se non per quella forma di immaginazione, sottile quanto ardua, che consiste nell’accostare senza asperità espressioni e figure che hanno un’origine diversa ma che insieme costituiscono un continuum che serve a descrivere e a rappresentare le differenti sfaccettature e declinazioni della costellazione di idee e storie che il termine inerzia racchiude, e da lì si espande a coprire, e a far conoscere, territori sempre più ampi del vivere, nel passato come oggi. Ciampa mette insieme tante tessere in apparenza disparate, saggi, letteratura, filosofia, teologia, attualità, cinema, musica formando alla fine un puzzle dove le commessure spariscono e il disegno si presenta unitario e convincente.
Proprio da lì, dalle costanti e dalle trasformazioni di questa malattia del corpo e dell’anima, conviene cominciare se si intende provare a fare il punto di dove siamo, e tratteggiare la geografia in cui ci muoviamo, o siamo come bloccati, impantanati in un’aria gommosa di gesti lenti e faticosi che spesso si capovolgono in agitazioni frenetiche che si consumano sul posto, con i suoi cieli neri, le sue paludi, le asperità che appaiono insormontabili e le voragini che abbiamo noi stessi scavato e in cui siamo caduti, o ci siamo gettati, da un tempo che ci appare immemorabile, senza che abbiamo più la forza, e nemmeno la volontà ormai, come sembra, di uscirne.
L’inerzia, lo scoramento, l’apatia, si diceva, non sono una novità nella vita dell’uomo, e a volte rispondono a difficoltà gravissime o semplicemente all’andamento della vita, alle disgrazie diseguali che toccano chiunque, all’invecchiamento, le malattie e la miseria, la violenza e la guerra in cui la più parte si trova coinvolta senza averlo voluto e nemmeno previsto. Ma questo non basta a spiegarne la diffusione, e si direbbe la sua assunzione a stella polare, spenta, nera come il nero della melanconia, dei nostri giorni.
“Che cosa è dunque accaduto? – si chiede Ciampa –. Qualcosa che non troveremo nelle cronache del tempo … abbiamo abdicato alle nostre prerogative di soggetti, franando in uno stato paralizzante, dove tutto accade a nostra insaputa. Le donne e gli uomini di questi anni si avvertono «superflui». Superfluo appare il loro agire”.
Il risultato è la diffusione universale dell’“indifferenza, il progressivo intorpidimento fino alla neutralizzazione della sensibilità” che produce “un ottundimento socialmente diffuso, il grado zero della nostra presenza nel mondo”, che si traduce nella rinuncia alla coscienza, in un’accettazione sonnambolica della deriva quotidiana. Un costante dormire sognando di essere svegli.
In certi casi questa condizione, come la Melanconia di Dürer nella lettura che ne danno Klibansky, Panofsky e Saxl, può essere “il silenzioso stato che prelude all’atto creativo”, perché ciascuna forma negativa può rivelarsi anche un’opportunità, la premessa per un ribaltamento o per una sortita verso qualcosa di diverso, di nuovo, forme di creatività non solo artistica, ma di azione e di pensiero; lo stesso che avviene nell’esitazione, nella quale Joseph Vogl nel suo libro Sull’esitare vede “come un «nuovo gesto del pensiero», … la possibilità di un’«ontologia critica di sé stessi e del nostro sapere»”, quella che nella notte tra il 22 e il 23 settembre del 1912, sperimenta Kafka scrivendo “La condanna”, quando scopre che l’insecuritas che lo attanagliava si ribalta nella fiducia di poter essere ciò che più di ogni altra cosa voleva diventare, uno scrittore.
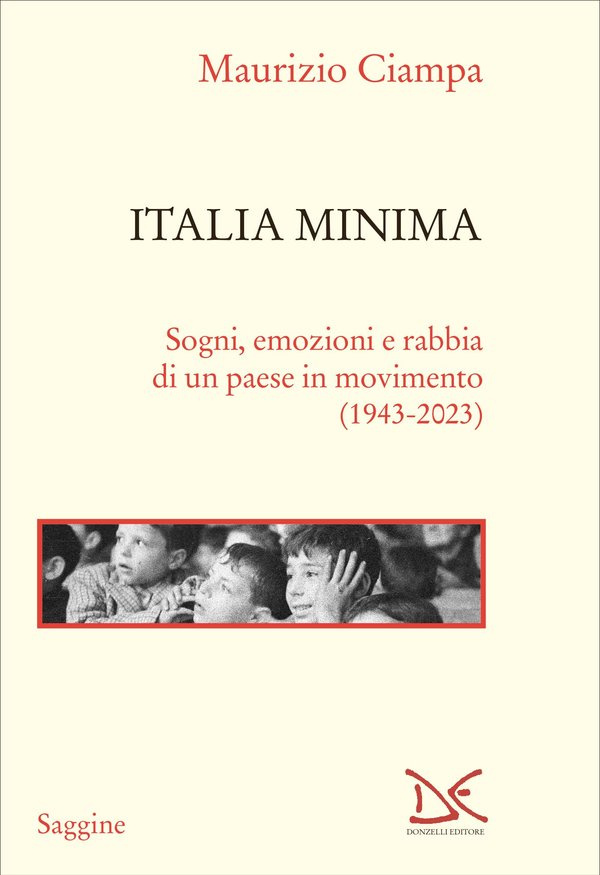
Perlopiù, tuttavia le figure che emergono da poeti e scrittori degli ultimi due secoli e dai loro personaggi, restano al di qua di questa soglia, affogati nel “tedio infinito” di cui è vittima Baudelaire, o come la “folta genia di «soli spenti», o di «nati morti»,” dei personaggi di Turgenev, Gončarov e Dostoevskij, che, a diversi gradi, ritroveremo in L’uomo che dorme di Perec, nel Palomar di Calvino, o in molte figure di Céline, Queneau e Manganelli.
Per essi “nulla più si muove, non si avanza né si arretra. Il tempo è finito, si è esaurito”, come scrive Queneau in La domenica della vita. “Vengono a mancare le parole con cui è stato narrato e rappresentato il Mondo, – commenta Ciampa –. La lunga parabola della civiltà occidentale si conclude nel silenzio o in un rumore senza significato…”
È, afferma Bernard Stiegler “il compimento del nichilismo dove “«nulla ha più valore, perché tutto è calcolabile»” e “non c’è più bisogno di pensare”:
Si diffonde una stanchezza opprimente, che paralizza, e che solo raramente può anche sfociare in “una malinconia discreta, che non allontana il mondo, ma al mondo si mantiene aperta”, come quella descritta da Peter Handke”. Più comune tuttavia, come segnala Byung Chul-Han, è che la stanchezza che predomina nella nostra società sia quella del burnout “che ha consumato tutto il capitale delle proprie energie”. È il mondo dell’uomo esausto di cui parla Deleuze nel libro scritto tre anni prima del suo suicidio, che “è molto più dello stanco … Lo stanco non può più realizzare, ma l’esausto […] mette fine al possibile, al di là di ogni stanchezza.”
A produrla sono i cambiamenti e le dinamiche nella vita di un individuo o nel mondo sociale… quando “non vengono più vissuti come elementi all’interno di una catena di sviluppo dotata di senso e direzione ... ma come un cambiamento senza direzione e frenetico”, afferma Hartmut Rosa in Accelerazione e alienazione. L’accelerazionismo sostiene che lo sviluppo vada però sostenuto per condurre la società a un punto critico che non possa sfociare che in un rinnovamento, che per ora tuttavia è solo un pio desiderio.
Byung Chul-Han sostiene al contrario che i «big data annunciano la fine della persona e della volontà libera»… e che “La crisi della libertà nella società contemporanea consiste nel doversi confrontare con un potere che non nega o reprime la libertà, ma la sfrutta.” Anche se spesso, conviene aggiungere, non ci si fa scrupolo di ricorrere apertamente alla forza, a volte senza nemmeno la parvenza di una motivazione: solo perché la si detiene. A livello collettivo, ma anche individuale.
Il soggetto va “in panne, o gira a vuoto”. Fortissima è allora la tentazione di mettersi in disparte, come gli hikikomori, ormai centomila anche in Italia, che con la loro “irriducibile volontà di non essere e non fare” rappresentano “un buco nero nella società della prestazione, una crepa o una sua zona morta”. Non è casuale l’affermazione come figure di riferimento di personaggi come il Bartleby di Melville o come Robert Walser, che “abitano gli «angoli e le fessure della vita»”, opponendosi in tal modo al potere, alla sua presa “per «una profonda, istintiva, avversione verso l’alto, di qualsiasi specie, verso tutto ciò che ha rango e pretese».”
Diventa allora urgente prendersi una pausa e togliersi dallo stato di sonnambulismo che era stato individuato nello scorso secolo da Herman Broch e riappare ora nel Rapporto Censis del 2023 sullo stato del nostro paese e che, se mantenuto, avrà degli effetti funesti sul nostro futuro.
“L’Italia, e non solo la sua classe dirigente, chiude gli occhi. … Nessuno si muove. Passeggiamo tutti sull’orlo di un baratro, senza volerlo sapere, accarezzando «desideri minori». Per riparare alla scoperta vulnerabilità, s’insegue il fumo di prospettive consolatorie, si cercano elisir, farmaci a buon mercato. Tutto per «placare l’inquietudine». Non ristagna solo l’economia, ristagnano sogni e desideri, si spengono forza vitale e volontà di trasformazione.”
Immobilità e buio, così si presenta il nostro futuro. “E più volte, nell’arco di questi anni, di questi mesi, di questi giorni, la negazione dell’umano è parsa irriducibile. Anche le guerre sembrano prese dall’inerzia, e senza soluzione.” Ma non da chi le fa e le subisce, si potrebbe obiettare, nonostante ora sembri che qualcosa cominci a risvegliarsi persino in chi finora assisteva mosso soltanto dall’indignazione e dalle paure limitandosi ad agitarsi sul posto, in una specie di furia immobile. Che sia questo un primo risvegliarsi dell’idea di futuro, come scriveva Bollas, “come oggetto mentale vitale”?
Un “filo sottilissimo e fragile … ci lega al mondo – scrive Ciampa –. Essere qui e ora, essere con altri. «Credere nel mondo», diceva Gilles Deleuze, «è ciò che più ci manca, abbiamo completamente smarrito il mondo, ne siamo stati spossessati»”.
Leggi anche:
Marco Belpoliti, Fuggire da Sé
Costantino Cossu, L’italia minima di Maurizio Ciampa
Andrea Pomella, Storia della mia depressione
Luigi Grazioli, Storia di una depressione. Andrea Pomella, L’uomo che trema