Dalrymple: la luce dell’India
Qualche tempo fa, mentre chiacchieravo amabilmente insieme a un vecchio amico, mi capitò di rievocare con lui l’epoca lontana dei nostri ripetuti viaggi in India. “Non ci torno più da tanti anni, ma l’incanto è rimasto intatto” – mi confessò – “l’India splende ancora in me come una luce perenne”. Dopodiché concluse con una frase che mi colpì per il suo sognante candore: “Durante gli anni di piombo, mentre in Italia ci si sparava in nome di ideologie tremende, noi…” – e qui mi sorrise con una studiata pausa – “…noi eravamo felici in India”. Eh già! L’India eterna, la grande Madre India, il pellegrinaggio in India quale via di rigenerazione dell’anima… Essere “felici in India”, come se si trattasse di un paese mitico della quiete luminosa e della gioia interiore: una terra sempre uguale a se stessa, preservata dall’angoscia della storia, dal turbine di un presente deteriore dove l’agone politico rischia ogni volta di degenerare in “anni di piombo”.
Per molto tempo, in effetti, soprattutto fra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso, il fascino dell’India è dilagato fra noi, portando a una sorta di conversione spirituale collettiva. Lo yoga, gli ashram, i guru, il cinema di Bollywood… Quasi che l’alternativa indiana fosse apparsa come una luce di salvezza per un mortifero Occidente. Poi, certo, col volgere del millennio, una simile fascinazione orientale ha perso gran parte del suo splendore, senza però sparire mai del tutto. Basti pensare agli innumerevoli centri yoga presenti da anni nel nostro Paese. Ma su cosa si basa questa antica, perdurante “seduzione indiana”? E soprattutto: ora che l’India è diventata lo Stato più popoloso del mondo, ora che la sua economia sta crescendo a ritmi sempre più incalzanti, si stanno forse creando le condizioni perché l’India s’imponga come un nuovo paese-guida, come una nuova superpotenza, nella contesa fra gli “imperi” di Stati Uniti e Cina?
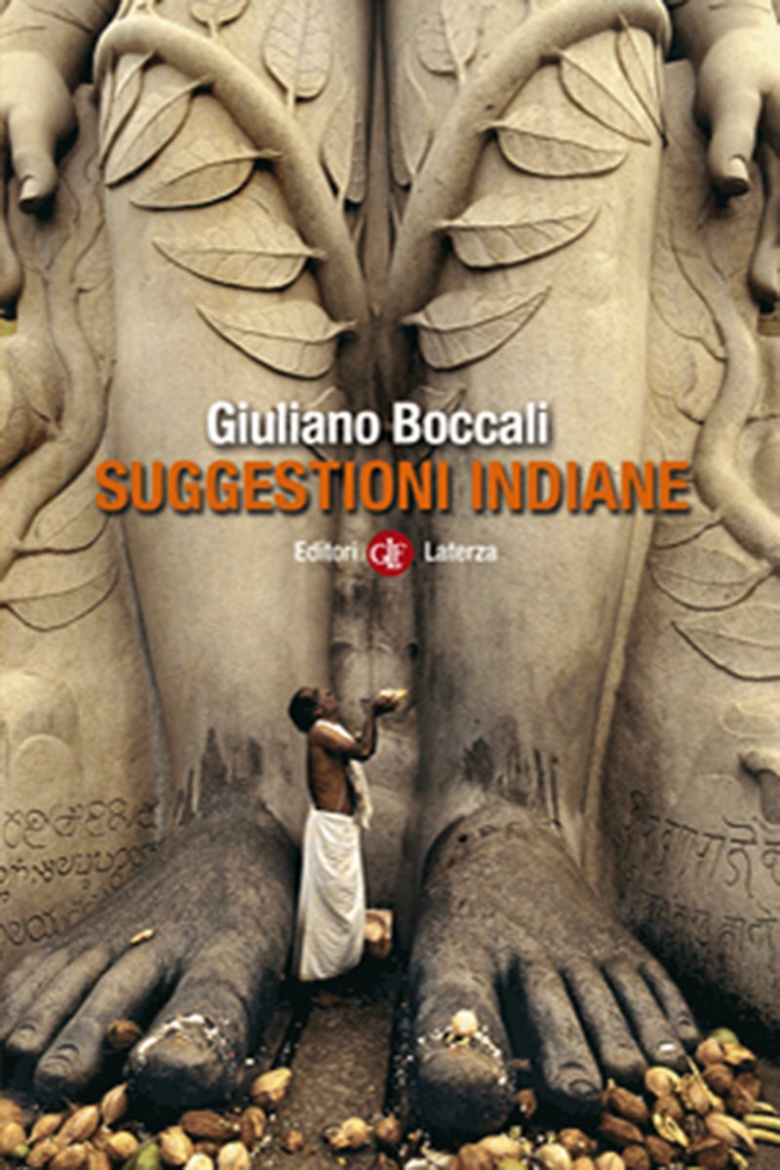
In uno splendido libro di qualche anno fa, Suggestioni indiane (Laterza, 2009), Giuliano Boccali, docente di indologia e letteratura sanscrita, sosteneva che «in India tutto è sacro», e quindi sovraccarico di senso, perché predomina laggiù una concezione ciclica del tempo. La storia, in India, per procedere in avanti, verso il futuro, deve costantemente ritornare indietro, così da rifondare nel mito, nella tradizione, la propria legittimità. Il nuovo cioè, per essere accolto, è chiamato a ripresentarsi quale trasfigurazione del passato. Infatti, afferma Boccali, «l’ininterrotta continuità della tradizione – da oltre 3000 anni – fa sì che l’India sia come un’immensa raccolta vivente (non un museo!) di se stessa, di tutto quello che è stato e che è, perché nulla è mai stato accantonato o soppresso (…) la situazione è unica al mondo, perché anche le civiltà più continue come quella formata in Europa (…) hanno comunque conosciuto cesure radicali (…) Nulla di simile in India: sulle rive del Gange, a Varanasi (Benares) puoi assistere ancora oggi a un rito seguendone con precisione lo svolgimento su un testo di 2600 anni or sono». Di conseguenza – secondo la spiritualità indiana – ogni fenomeno, ogni manifestazione del mondo, per essere compresa e accettata, va ricondotta al cuore di se stessa, alla propria più profonda, sovrastorica interiorità. E questo potrebbe valere anche per noi: raggiungere l’India ci permetterebbe di riscoprire la verità ultima su noi stessi, significherebbe raggiungere quel Sé più autentico che coincide con la sacralità dell’Assoluto. Da qui dunque quella possibilità di “essere felici in India” vagheggiata dal mio amico.
Non così, però, anzi tutto l’opposto, per il grande scrittore di origini indiane Vidiadhar Naipaul, che al Paese dei suoi avi ha dedicato libri intrisi di lucido disincanto. In un testo al tempo stesso abbagliante e quasi raggelante nella sua vivida crudezza, Una civiltà ferita: l’India (Adelphi, 1997), Naipaul dichiara amaramente che l’India sembra condannata «a uno stato di cronica inadeguatezza» dovuta al persistere di «un’antica, non rimarginata ferita». L’India contemporanea, infatti, non riesce a risollevarsi dalla tragedia delle ripetute invasioni, prima musulmane, poi britanniche, che per secoli ne hanno annichilito l’originaria civiltà. A partire dal 1200 e fino all’Indipendenza del 1947, l’India si è trasformata in una terra di sconfitte ripetute, di un disfacimento progressivo e senza riscatto. Secondo Naipaul, il sogno, continuamente riproposto e continuamente frustrato, di rivivere l’India eterna, di ritrovare la propria autenticità nell’India di sempre, non porta ad altro che a un deplorevole, inestinguibile arcaismo: «L’India assimila i suoi conquistatori e sopravvive loro, dicono gli indiani; ma (…) io mi chiedevo se, intellettualmente, non avesse sempre indietreggiato di fonte ai suoi conquistatori e se, nei suoi periodi di apparente rinascita, non avesse in realtà fatto altro che diventare di nuovo arcaica, intellettualmente più misera, rimanendo sempre vulnerabile. La crisi dell’India (…) è la crisi di un’antica civiltà ferita che alla fine ha preso coscienza delle proprie inadeguatezze, ma non possiede gli strumenti intellettuali atti a farla progredire».
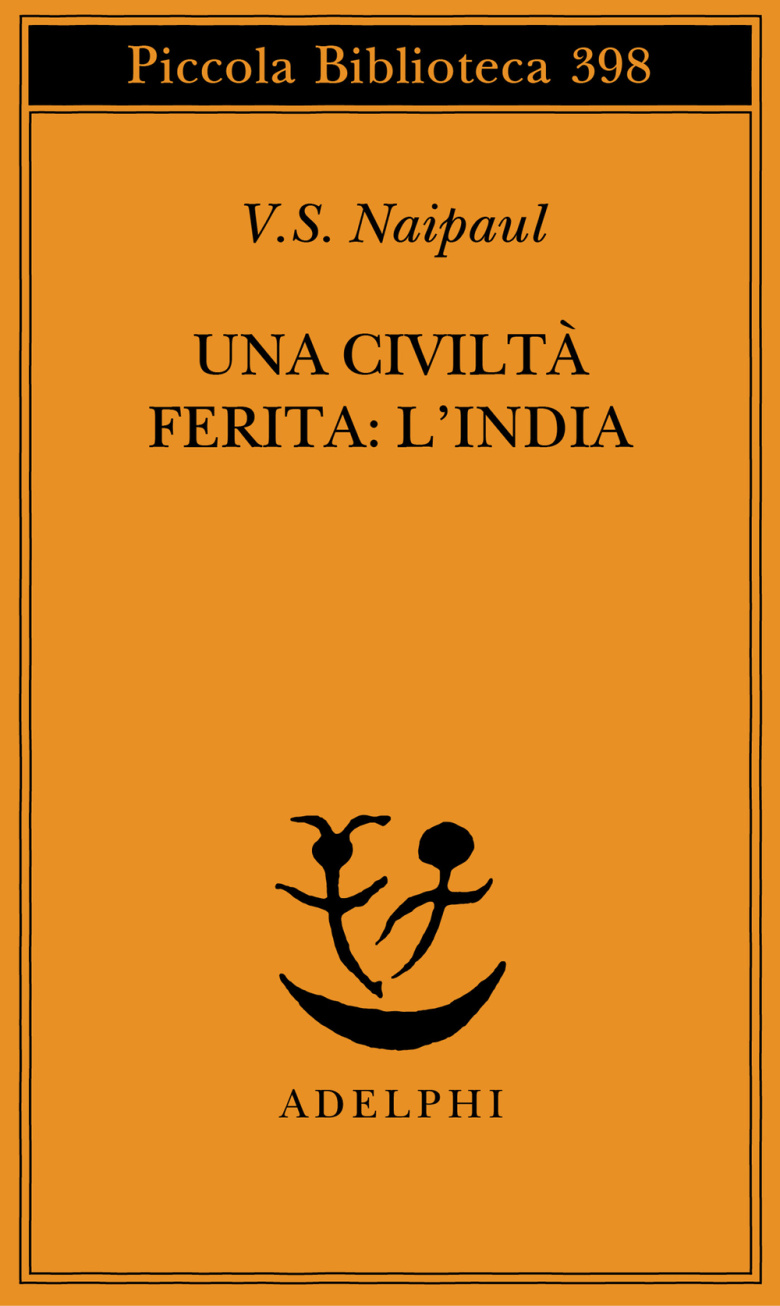
E dunque? L’India come frustrante, opprimente «area di tenebra» – per citare il titolo di un altro libro di Naipaul? O invece l’India come terra del senso e del sacro, dove i miti antichi si rigenerano, permettendo al presente di ritrovare se stesso e la propria nuova strada verso il futuro – come ci suggerisce invece Boccali nelle sue «suggestioni indiane»? Si tratta di un dilemma a sua volta ricorrente, riproposto di generazione in generazione, senza che si possa mai giungere a una chiara conclusione. Ma ora una nuova, straordinaria opportunità di approfondimento e chiarimento, proprio su questi temi ardui e affascinanti, ci viene offerta dalla pubblicazione dell’ultimo, davvero notevole libro di William Dalrymple, La Via dell’Oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo (traduzione di Svevo D’Onofrio, Adelphi, 2025, pp. 550). Nato a Edimburgo nel 1965, Dalrymple è uno scrittore britannico che ha dedicato all’India, alla sua storia, alla sua cultura, numerosi testi di grande fascino letterario e di grande spessore storico. Si avverte in lui il profondo coinvolgimento personale nei confronti di un Paese che, pur splendendo di luce propria – una luce che, come abbiamo visto, può risultare anche “tenebrosa” – sembra funzionare al tempo stesso quale specchio rovesciato dell’Occidente o quale “punto di fuga” del colonialismo britannico e dell’orientalismo europeo. Come se guardare verso l’India significasse scrutare la parte di noi stessi rimasta in ombra. Attenzione però: Dalrymple non è affatto un affabulatore fantasioso, ma tutto all’opposto uno storico rigoroso, documentatissimo, capace di ricostruire, con il massimo della serietà e della chiarezza, quegli eventi, quelle fasi della storia indiana che lui intende descrivere e spiegare.
È questo appunto il caso della sua ultima opera poderosa e vertiginosa, in cui ci presenta e ci spiega quel lunghissimo, eccezionale periodo (più o meno dal 250 a.C. fino alle soglie del nostro Medioevo) in cui l’India agì come un centro irradiante di cultura, civiltà, ricerca scientifica e religiosa, capace di influenzare in modo radicale sia il mondo mediterraneo, sia la Cina e il Sud-est asiatico. Tanto che oggi possiamo con sicurezza affermare che «l’India antica ha trasformato il mondo» (come recita appunto il sottotitolo del libro di Dalrymple). E in che modo una simile influenza sarebbe stata possibile? Perché, ben prima che prendesse piede la famosa Via della Seta fra la Cina e l’Europa, e ben prima che i mercanti europei aprissero a loro volta la celebre Via delle Spezie fra l’Asia del Sud-est e i porti occidentali, l’India aveva già inaugurato una sorta di eccezionale, anzi diciamo pure sbalorditiva rotta di scambi commerciali e spirituali, rivolta tanto verso oriente quanto verso occidente.
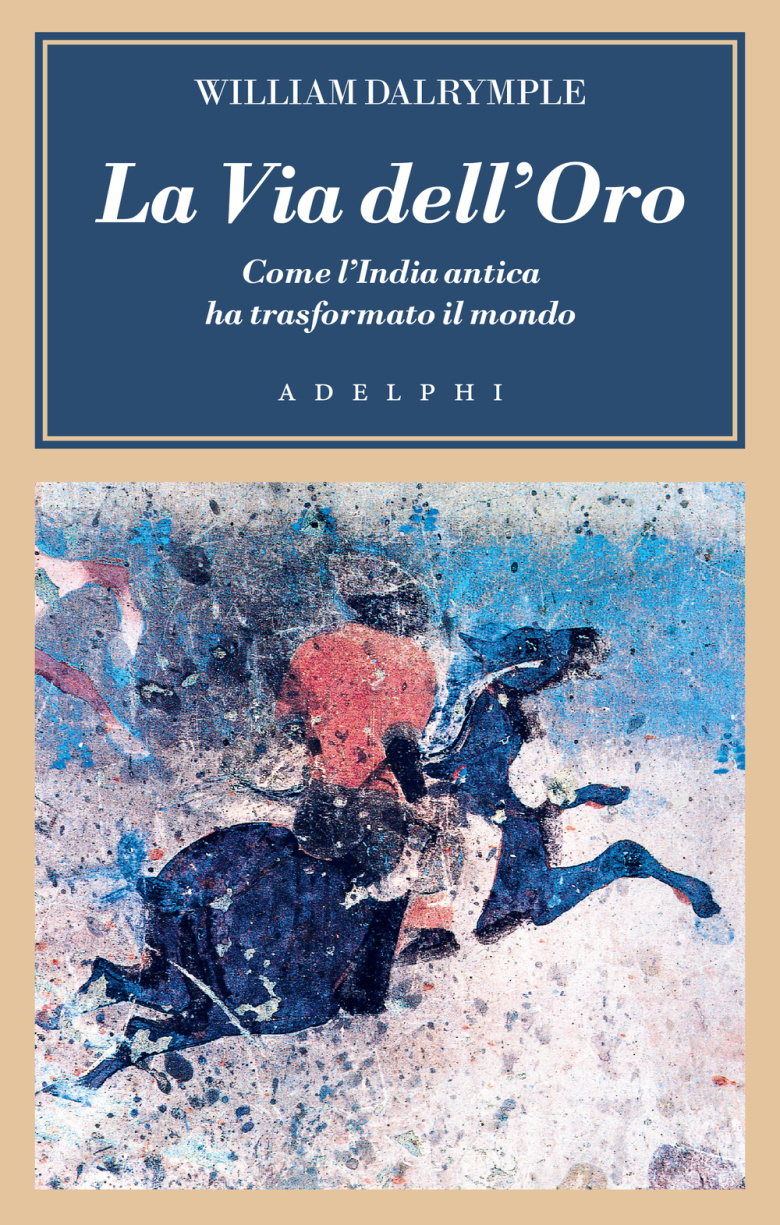
Tale rete di irradiazione mercantile e culturale che dall’India si diramava verso le altre civiltà, Dalrymple – con una scelta felice che s’impone subito, fin dal titolo del libro – propone di chiamarla la «Via dell’Oro». Perché però questa denominazione tanto suggestiva? Essa va intesa non solo e non tanto in senso metaforico – quasi si trattasse di un’aurea via dello spirito – ma prima ancora in senso concreto, letterale. Era l’oro infatti che dall’area mediterranea prima, e in seguito dal Sud-est asiatico, fluiva in abbondanza verso l’India, in contraccambio di «pepe, spezie, avorio, cotone, gemme, teak e legno di sandalo»: tutte merci pregiate e ricercate, provenienti dall’India e dirette verso il Mar Rosso e il Mediterraneo, come pure verso la Birmania, la Cambogia, l’Indonesia… Una millenaria, ramificata via marittima, resa praticabile dal regime dei venti monsonici che, a seconda delle stagioni, soffiano alternativamente verso ovest e verso est, mantenendo al centro il Subcontinente indiano. Ma il punto fondamentale è che, lungo questa prodigiosa Via dell’Oro, non viaggiavano solo merci esotiche, pregiate ed economicamente costose, ma pure idee, sistemi di pensiero, valori spirituali. Come spiega chiaramente Dalrymple stesso:
«Dal 250 a.C. al 1200 d.C. circa, l’India era stata una fiera esportatrice della propria variegata civiltà, fino a creare intorno a sé un impero delle idee – una vera e propria “indosfera” – dove la sua influenza culturale risultava predominante. In questo periodo il resto dell’Asia fu il destinatario consenziente e persino entusiasta di un colossale trasferimento di soft power indiano, in ambiti come la religione, l’arte, la musica, la danza, la tessitura, la tecnologia, l’astronomia, la matematica, la medicina, la mitologia, la lingua e la letteratura (…) Al tempo stesso, l’influenza intellettuale dell’India si è estesa verso occidente, consegnandoci non solo nozioni matematiche cruciali, come lo zero, ma anche la forma stessa dei numeri che tuttora utilizziamo – probabilmente la cosa più simile a una lingua universale che l’umanità abbia mai posseduto. Le conoscenze, i saperi e le intuizioni religiose dell’India antica sono una parte fondante del nostro mondo. Al pari dell’antica Grecia, l’India ha saputo fornire risposte coerenti e profonde alle grandi domande dell’esistenza (…) non con la forza delle armi ma per pura attrazione ed emulazione culturale. In ambito scientifico, astronomico e matematico, l’India è stata maestra del mondo arabo e, per suo tramite, dell’Europa mediterranea».

Il fatto eccezionale è che tale massiccia, prolungata esportazione di beni materiali e immateriali, è avvenuta non al seguito di occupazioni militari, invasioni imperiali, spedizioni di eserciti, ma grazie alla sola forza persuasiva della civiltà indiana. Non perché questo Paese sia per sua intrinseca natura alieno dalla violenza, ma a causa delle sue condizioni storico-geografiche. Situata al margine centro-meridionale dell’Asia, infatti, la regione indiana, per quanto enorme, rimane relativamente isolata dal resto del continente, stretta com’è tra l’oceano e l’immensa catena dell’Himalaya. Inoltre l’India, nel corso di tutta la sua storia fino al dominio coloniale britannico, non si è mai ritrovata unita sotto un’unica entità statale, bensì perennemente frammentata in una varietà multiforme di regni, potentati, dinastie spesso in conflitto tra loro. Politicamente suddivisa, questa terra era però relativamente omogenea sul piano culturale e spirituale. Tanto da permettere al proprio interno un continuo confronto, un’inesausta, reciproca fecondazione fra diverse tendenze religiose, artistiche, filosofiche, letterarie. Tale ricchissimo, ricorrente interscambio di scuole, tradizioni, visioni culturali era a propria volta reso possibile dall’utilizzo millenario del sanscrito, dapprima impostosi per la sua sacralità in quanto “lingua degli déi e degli uomini”, e poi, al volgere del millennio, adottato anche come lingua letteraria, politica, filosofica, scientifica. E fu appunto il sanscrito a venire rapidamente e per secoli utilizzato quale lingua franca dei commerci e degli scambi culturali, in gran parte dell’Asia.
Proprio grazie al sanscrito, infatti, si diffusero verso est i grandi poemi epici del Ramayana e dal Mahabharata, che vennero così adottati e rielaborati quali testi sacri, fondativi per le varie civiltà del Sud-est asiatico. Non solo, sempre per merito del sanscrito, quelle grandi religioni dell’India che erano emerse dopo il lungo periodo della spiritualità vedica, e cioè il buddhismo e l’induismo, dilagarono e si imposero oltre i confini indiani, per venire accolti e rielaborati in Cina, in Tibet, Thailandia, Birmania, Indonesia, dando vita a stupefacenti ibridazioni culturali, anzi a nuovi universi spirituali.
Al tempo stesso, le ricerche dei matematici e degli astronomi indiani portarono alla rivoluzionaria elaborazione del sistema decimale e alla definizione del concetto di zero, e furono proprio l’algebra, la trigonometria, gli algoritmi definiti in India a raggiungere poi Baghdad nell’VIII secolo per spingersi poi da lì verso l’Europa latina. Col risultato che i cosiddetti “numeri arabi”, in realtà indiani, gettarono le basi per la rivoluzione economica e commerciale europea del tardo Medioevo e del Rinascimento. Tanto che Dalrymple annota giustamente, nelle pagine conclusive del suo libro: «È una delle grandi ironie della storia il fatto che l’India abbia fornito all’Europa gli strumenti finanziari e commerciali con cui quest’ultima l’avrebbe in seguito assoggettata (…) Dalla metà del XVIII secolo, una società commerciale europea, la Compagnia delle Indie Orientali, amministrata da mercanti e ragionieri della city di Londra con i loro meticolosi libri contabili, si lanciò alla conquista di un’India frammentata e divisa, perpetrando quello che può essere considerato il più grande atto di violenza aziendale della storia».

In effetti il grande ruolo storico che l’India aveva esercitato come centro del commercio globale e come grande area di irradiazione culturale si era ormai concluso da secoli, dapprima con l’irruzione di agguerrite popolazioni turche che sul finire del XII secolo, avevano messo a ferro e fuoco l’India del nord, distruggendo templi, università, dinastie. A ciò si aggiunsero, di lì a poco, le invasioni dei Mongoli di Gengis Khan, che non arrivarono mai in India ma spinsero popolazioni persiane a penetrarvi massicciamente, proprio per salvarsi dalle invasioni mongole. La conseguenza di tale immane trasmigrazione persiana fu la costituzione di sultanati musulmani in India, che perdurarono fino all’arrivo dei britannici. La lingua dominante divenne così il persiano, e una nuova cultura indo-persiana, a sua volta di grande raffinatezza, si diffuse nel Paese. Col risultato che proprio dall’India musulmana partì poi la grande islamizzazione dell’Arcipelago indonesiano, in sostituzione di quei regni che prima, sempre grazie all’India, si erano convertiti all’induismo e al buddhismo…
E l’India intanto? Quell’India che, di rivolgimento in rivolgimento, è arrivata fino all’era attuale? «L’India continuerà», aveva con sicurezza dichiarato proprio a Naipaul, ancora nel 1961, il grande romanziere Rasupuram Narayan. Come dire: malgrado tutte le traversie della storia, malgrado la sua magnificenza più volte perduta, «l’India continuerà», manterrà la propria luce, a volte splendente, a volte nascosta, poi di nuovo adagio risplendente, nel caos degli immensi cambiamenti che agitano la nostra epoca. «Continuerà» proprio per merito di quella profonda tendenza a perdurare rimanendo fedele a se stessa, che affascinava Boccali e che infastidiva Naipaul? Sì, forse è così. Ma mi pare giusto a questo punto lasciare l’ultima parola a Dalrymple e alla domanda decisiva con cui si conclude il suo libro:
«Il più grande talento dell’India risiede nella capacità di assorbire le influenze esterne e trasformarle in modi radicali, creativi, eterodossi e innovativi; di reinventarsi e reincarnarsi senza mai smarrire la propria identità. È qui che si rivela la sua vera forza. Per oltre un millennio, le idee dell’India si propagarono lungo la Via dell’Oro al seguito dei suoi mercanti, trasformando il mondo e dando origine a un’indosfera: un’area culturale che travalicava i confini politici, paragonabile al mondo forgiato da Alessandro Magno, con la differenza che l’espansione indiana non avvenne mai con la spada ma con la forza delle idee. All’interno di quest’area, la cultura e la civiltà indiane lasciarono un’impronta profonda su tutto ciò con cui entrarono in contatto. Si affaccia così una domanda che nel 1947, anno dell’indipendenza dalla Gran Bretagna, sarebbe parsa impensabile: potrebbe riuscirci ancora?».







